UN TRAGICO AGOSTO
Tempo di lettura: 9 minuti
Un tragico agosto
 Forse perché quello di Agnese Pini (Un autunno d’agosto, Milano, Chiarelettere, 2023) è un libro che non si può leggere senza provare emozioni, mi pare fuori luogo cercare di inscriverlo a forza in un qualche genere. D’altronde i migliori risultati della nouvelle histoire ormai da decenni hanno dimostrato come sul piano narrativo si possa muoversi tra romanzo, saggio, autobiografia, biografia collettiva, ricerca storica, utilizzando i metodi di ognuna di queste modalità di racconto, pur mantenendosene consapevolmente ai margini.
Forse perché quello di Agnese Pini (Un autunno d’agosto, Milano, Chiarelettere, 2023) è un libro che non si può leggere senza provare emozioni, mi pare fuori luogo cercare di inscriverlo a forza in un qualche genere. D’altronde i migliori risultati della nouvelle histoire ormai da decenni hanno dimostrato come sul piano narrativo si possa muoversi tra romanzo, saggio, autobiografia, biografia collettiva, ricerca storica, utilizzando i metodi di ognuna di queste modalità di racconto, pur mantenendosene consapevolmente ai margini.
Non è un caso che l’atteggiamento dominante del libro della Pini sia l’ascolto. Lo dichiara subito l’esergo tratto dai Vangeli, che precede il racconto di una tragica storia di luoghi, tempi e persone.
Come si ricorderà la protagonista positiva del testo evangelico (Luca 10, 38-42) non è Marta, che si affanna nel fare, ma Maria, il cui unico merito è quello di ‘porgere orecchio’.
È proprio quanto fa Agnese Pini che, passando da un ruolo all’altro (dall’impegno nello studio e il lavoro all’ascolto), comincia a prestare attenzione a se stessa e alla propria inquietudine (quella dei figli, dei nipoti, dei discendenti delle stragi, con il loro bagaglio di dolore e di colpa che richiede tempo per rimuovere desideri di occultamento), ascoltando un ultimo testimone indiretto, Roberto Oligeri, ascoltando il procuratore di La Spezia, ascoltando soprattutto i documenti e facendoli parlare.
Riesce così a dare voce, tanti anni dopo, a voci che nessuno ha potuto sentire dopo quel tragico agosto del 1944: voci di bimbi che giocano, di donne che parlano tra loro sbrigando faccende domestiche, voci soffocate e zittite ad un tratto dal silenzio della paura, dai colpi delle mitragliatrici…
Raccontare una storia, nella fattispecie un eccidio, è un modo per commemorarne tanti, per ricordare che il sadismo accompagnato alla violenza gratuita si colloca oltre ogni atto di guerra (e le poche regole che la totale assurdità dei conflitti comunque prevede) e che all’interno di ogni gruppo armato possono verificarsi piccoli/grandi gesti di umanità (il soldato tedesco che senza rischio per sé – diversamente dalle SS ubriache che torturano e seviziano – finge di non accorgersi di una fuga; o l’altro che risparmia in extremis la piccola Clara da cui parte il ‘romanzo’).
Parlare dell’uccisione di 160/159 persone compiuto dalle SS di Fosdinovo a San Terenzo Monti, a Bardine, nello spiazzo davanti alla fattoria di Valla, è un modo anche, per la Pini e per noi, per ricordare le 280 stragi avvenute in Toscana tra l’aprile e l’agosto del ’44 che, con la complicità dei fascisti, coinvolsero 83 comuni portando alla morte di 4500 civili.
È un modo per riflettere su quello che fu la resistenza e il suo ruolo, rispondendo alle accuse per tutte le possibili imperfezioni (e rappresaglie), ribadendo che, oltre ogni oggettiva fallibilità personale o di gruppo, anche la resistenza era fatta da imperfetti esseri umani il cui principale, indimenticabile merito è stato quello di essersi trovati, più o meno consapevolmente perfino, talvolta (basta ricordare il precoce, calviniano Sentiero dei nidi di ragno o un film di Louis Malle, Lacombe Lucien, su sceneggiatura di Patrick Modiano), da quella che era e continua ad essere, indiscutibilmente, la parte giusta della storia.
Ma più che ricollegare Un autunno d’agosto a quanto si è scritto/detto sulla resistenza da parte di testimoni, storici, scrittori (ricorrerebbero allora i nomi di Fenoglio, Calvino, Viganò…), artisti (penso ai fogli a china e inchiostro colorato su carta di Vespignani, dal 1943 al ’48, esposti nella mostra Fantastico Calvino organizzata alle Scuderie del Quirinale, che mostrano case sventrate, dimostranti uccisi, torturati…), vorrei soffermarmi piuttosto sul contrario del patto narrativo che questo volume, come altri del genere, stabilisce e richiede, quando dichiara che tutto quanto è narrato, a partire dai nomi, è assolutamente vero.
La sospensione dell’incredulità (tipica della narrativa) non solo non è invocata, ma è dichiaratamente evitata, a partire dalle date (specificate e seguite nei mesi, nei giorni, nelle ore, nei secondi), dai nomi, che più volte vengono fatti e ripetuti in modo ogni volta più completo. Parimenti è esplicito, il libro, nell’interpretare quanto era avvenuto.
Nel caso specifico di San Terenzo le testimonianze sono chiare: non si era trattato (come in altri casi) di un attentato ma di un atto di guerra condotto in pieno giorno, al quale si sarebbe dovuto rispondere con misura equipollente. Ma tutto aveva congiurato nel corso di quella storia, così come in tante altre: il caso, che fa che siano proprio gli abitanti a chiedere l’intervento dei partigiani; il caso, che colloca alcuni fuori delle zone dell’attacco; il caso, che porta ad ascoltare o rifiutare consigli di fuga. Ma su scelta e caso si basa la vita: “ecco la sostanza del nostro stare al mondo”, ricorda l’autrice.
Alcune figure si stagliano con particolare forza accanto a quelle che potrebbero o che sono ancora oggi davanti a noi: la coprotagonista/autrice del libro (discendente di una delle vittime e giornalista di successo) e Roberto Oligeri (il cui padre aveva perduto in quei giorni d’agosto la moglie e cinque figli, mentre nella sua trattoria dava da mangiare al comandante tedesco che aveva ordinato la strage).
A loro si aggiunge quanto si può trovare ormai facilmente su You Tube per impegno dell’associazione Linea gotica – officina della memoria: con immagini del paese, delle viti a cui erano legati i prigionieri agonizzanti, e le foto degli uccisi, il monumento con i loro nomi.
C’erano insomma già dati/persone rintracciabili, ma quello che fa Agnese Pini (oltre a spingerci a nostra volta a cercarli, e non è merito da poco) è dare a quei volti, a quelle fotografie, una storia, riempiendo di vita ciascuno di quei nomi.
Quelli delle vittime e anche quelli dei carnefici, quelli degli umili, incolti, che non giudica mai, e quelli dei consapevoli, in testa ai quali stanno Don Michele Rabino, che implora inutilmente la gente di andarsene e che sarà una delle prime vittime, e il comandante partigiano, che, incerto sul da farsi prima dell’intervento, aveva fatto presenti i rischi invitando le persone a fuggire (e che per il resto della vita pagherà un prezzo alto di rimorso e solitudine). Sullo sfondo la voce delle vittime è individuale e corale insieme, affidata ai si dice…, alle leggende, alle credenze, alle paure e speranze collettive.
La voce narrante non condanna mai le vittime o gli umili, anche quando sbagliano (nei giudizi/pregiudizi sulla resistenza), ma non assolve mai gli altri: mantiene netto il giudizio sui nazi-fascisti e su tutti quanti hanno compiuto il male. Consapevole delle possibili sfumature, non ha dubbi sulla colpa di quanti, dopo, non hanno voluto capire, hanno amnistiato, insabbiato, dimenticato, assolto, fino all’arrivo del procuratore onesto che dopo settanta anni ha avuto il coraggio di aprire l’“armadio della vergogna”. Già, coraggio, perché ogni scelta lo richiede.
L’autrice non mitizza i partigiani (come non li mitizzava il commissario Pin di calviniana memoria), ma distingue nettamente, come fa la sua fonte, tra azioni di guerra e attentati. Discute insomma anche la percentuale di 1 a 10 richiesta da tedeschi ubriachi in preda all’odio e alla vendetta. Non offre insomma nessun appiglio che spinga a invocare la banalità del male (pure usata in altri casi), perché qui il male è fin troppo visibile, visibile come avrebbe dovuto esserlo alla fine della guerra per processi che colpevolmente non ci sono mai stati.
Questo non significa che la Pini non usi artifici narrativi (a partire dall’ossimoro del titolo, che si riflette in quello delle storie di vita e morte che propone), con l’abile slittamento dalla prima persona narrante, che periodicamente riappare, a favore di un racconto in terza persona, che punta il riflettore su diversi personaggi con uno sguardo che, salvando i particolari, potremmo dire al grandangolo. Sì che è come se ci trovassimo anche noi sul cucuzzolo sopra la fattoria a osservare tanti piccoli esseri umani, mentre l’esercito nemico li circonda, li attacca…
Mi capita, quando leggo un libro, di accostarvi delle suggestioni di lettura: questa volta mi sono venuti in mente dei versi di quel Paul Éluard che ha scritto che “il perdono è forte come il male, ma che il male è forte come il perdono”, in particolare quelli dell’Éluard che esclude che si possa perdonare ai carnefici («Il n’y a pas de salut sur la terre / Tant qu’on peut pardonner aux bourreaux»), e delle pagine di Vladimir Jankélévitch, autore di un libro che, rispondendo in modo negativo a un fin troppo vulgato interrogativo sul perdono, ha sottolineato con forza che è troppo comodo perdonare a nome dei morti.
 Ricordava Jankélevitch che siamo tenuti a testimoniare, visto che i morti dipendono interamente dalla nostra fedeltà e che il passato ha bisogno della nostra memoria. È quanto fa in questo libro Roberto Oligeri, e con lui, guidata da lui, Agnese Pini (svolge, il più anziano testimone, il ruolo dell’aiutante, come lo avrebbe chiamato Propp nei racconti di fiabe); mentre la stessa protagonista inserisce di quando in quando la sua quête in un percorso quasi fiabesco fatto di strutture circolari del tempo, come se altrove almeno la storia si potesse riscrivere.
Ricordava Jankélevitch che siamo tenuti a testimoniare, visto che i morti dipendono interamente dalla nostra fedeltà e che il passato ha bisogno della nostra memoria. È quanto fa in questo libro Roberto Oligeri, e con lui, guidata da lui, Agnese Pini (svolge, il più anziano testimone, il ruolo dell’aiutante, come lo avrebbe chiamato Propp nei racconti di fiabe); mentre la stessa protagonista inserisce di quando in quando la sua quête in un percorso quasi fiabesco fatto di strutture circolari del tempo, come se altrove almeno la storia si potesse riscrivere.
Con Un autunno d’agosto siamo costantemente dentro quella che potremmo chiamare una dimensione morale. L’obiettivo è ridurre la distanza tra il soggetto e l’oggetto; di qui l’incertezza, la paura, la commozione della protagonista che si trasmette anche a noi. D’altronde c’è anche un grande equilibrio tra due rischi possibili: quello della distanza intellettuale e quello opposto della coincidenza passiva.
Agnese Pini è capace di dissociare l’occhio e lo sguardo, come dire che oggetto e soggetto sono sotto lo stesso sguardo rigoroso, attento… mentre pratica una sistematizzazione retrospettiva, ci mostra un tempo raccontato in parallelo allo svolgersi della tragedia. Parla dell’irreversibile, dell’irrevocabile; di ciò che il tempo non potrà cambiare mai più.
Antonio Tabucchi ha sostenuto che una delle ragioni della letteratura sta nella sua capacità di regalarci vite che non potremmo avere. Dinanzi a un libro come questo viene fatto di pensare che non ci dà soltanto un presente o un futuro impossibili, ma anche un passato che non è stato il nostro, permettendoci di ripercorrere l’irrevocabile, di restituire al passato quello che non può più avere, ovvero lo spazio e il tempo.
Un irreversibile insomma che può attenuarsi solo grazie alla memoria; laddove il perdono corrisponde alla dimenticanza. Mentre sottolinea la responsabilità dell’individuo, è palese la sua scelta di far raccontare la storia non dai vincitori ma dai vinti, ad uso delle future generazioni.
Come aveva fatto Calvino, che per il Cantacronache 1958 aveva scritto un testo, Oltre il ponte, messo in musica da Sergio Liberovici, dove aveva ‘cantato’ i sogni della resistenza:
“Avevamo vent’anni e oltre il ponte / oltre il ponte che è in mano nemica / vedevam l’altra riva, la vita / tutto il bene del mondo, oltre il ponte […] Silenziosi sugli aghi di pino, / su spinosi ricci di castagna, / una squadra nel buio mattino / discendeva l’oscura montagna. / La speranza era nostra compagna / a assaltar caposaldi nemici […] Vedevamo a portata di mano / dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, / l’avvenire di un mondo più umano / e più giusto, più libero e […] Io son solo e passeggio tra i tigli / con te, cara, che allora non c’eri. / E vorrei che quei nostri pensieri, / quelle nostre speranze d’allora / rivivessero in quel che tu speri, /o ragazza color dell’aurora”.
È in definitiva questo l’obiettivo che si propone Un autunno d’agosto, un libro dalla sapiente struttura che, con la climax ascendente nella parte conclusiva, nell’intrecciarsi delle voci, delle storie, auspica che si possa giungere un giorno alla conoscenza e grazie a quella a una memoria condivisa. Memoria condivisa – si badi bene – che è il contrario di quella proposta nel 1996 da Luciano Violante nel citare i cosiddetti ‘ragazzi di Salò’.
La memoria condivisa invocata Agnese Pini, nella quale ci riconosciamo, è una memoria che possa vederci infine tutti insieme convinti nel distinguere i torturatori dai torturati, le vittime dai colpevoli, che ci veda infine uniti nel pensare che “quanto fecero – con consapevolezza, lucidità, premeditazione, odio, ferocia – le Brigate nere nelle stragi del 1944 non fu guerra civile. Fu criminalità organizzata, fu barbarie, fu imperdonabile orrore”.
Agnese Pini ci ricorda che “negando o banalizzando la verità [si] distrugge la storia”. Al suo invito possiamo rispondere adesso con i suoi 160 nomi, e, ad deterrendum, con i nomi degli altri, occultati per decenni per compiacenza, che si dovrebbero citare a ludibrio.
Per leggere gli articoli di Anna Dolfi su Periscopio clicca sul nome dell’autrice

Sostieni periscopio!
Anna Dolfi
Commenti (1)
Lascia un commento Annulla risposta
PAESE REALE
di Piermaria Romani
Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.
Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.
(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)







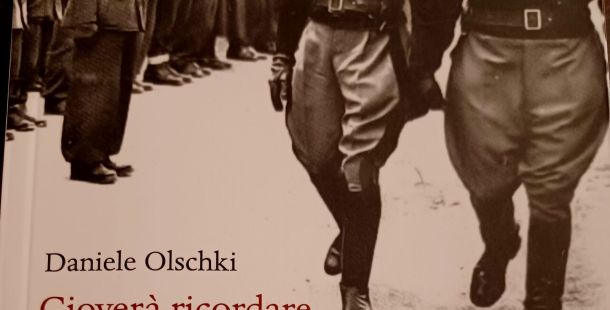






Un articolo magistrale. Grazie Anna