TABUCCHIANA 4. /
TABUCCHI, UNA POETICA COME AUTORITRATTO
Tempo di lettura: 6 minuti
TABUCCHIANA 4. TABUCCHI, UNA POETICA COME AUTORITRATTO
Gérard Genette apre il suo libro, Seuils, dedicato a tutto ciò che dai margini affianca un testo senza farne direttamente parte, con la riflessione e la casistica che accompagna la ‘scienza dei titoli’, la titrologia. A contare, ci dice, sono la lunghezza, la presenza o meno di una doppia titolazione o di un sotto-titolo, ma anche il momento in cui il titolo appare, la sua funzione, il destinatario…
A dire il vero prosegue con esemplificazioni e distinzioni, ma qui (una volta detto che Tabucchi sarebbe stato per lui un caso più che esemplare per lo studio e classificazione di ogni tipo di paratesto) non mi interessa applicare la logica e i suggerimenti della sua intelligente e produttiva narratologia, ma soltanto riflettere, a partire dai titoli e non solo, su cosa abbia mosso uno dei più grandi scrittori del secondo Novecento europeo a servirsi continuamente di ‘soglie’.
Per altro personalmente sono convinta che si trattasse di un gioco (ammesso che sia consentito chiamarlo così) non necessariamente ludico (Tabucchi ha insistito più volte nei suoi racconti sulla serietà e il significato esistenziale e formativo del ludus infantile), ma che rispondeva piuttosto alla necessità di non chiudere i sui testi permettendo, a partire dagli incipit, di lasciarli in qualche modo aperti, affidati a segnali, suggerimenti, ipotesi, insomma a un margine di permeabilità che induce il lettore a un percorso più che a una presa d’atto, mettendolo nella condizione (lui sì, davvero!) di mettersi in gioco.
Chissà che non nasca anche da qui, a parte la suggestione e l’originalità delle storie, l’affezione del tutto particolare che circonda l’opera tabucchiana e il suo autore, e il piacere e le scoperte che ogni rilettura ci offre.
È nota l’attenzione che Tabucchi riservava ai titoli e alle immagini di copertina nella ricerca di una comunicazione che fosse insieme diretta e accessibile, criptica ed evocativa.
Si pensi a sintagmi-titolo che sembrano strappati dalle conversazioni casuali proposte dal racconto proemiale dell’Angelo nero quali si sta facendo sempre più tardi o il tempo invecchia in fretta, accompagnate per giunta, sulle cover, in un caso da un misterioso abbraccio produttivo altrove di congetture e depistaggi, nell’altro da un giovane issato su pericolosi socles à réflexion che di fatto appaiono antifrastici (a meno che non si voglia legarli a una dubbia serenità autoriale) con il titolo che sostituiva un originario e più difficile Controtempo.
Il caso più perturbante e clamoroso, ma forse più significativo per quello che sto tentando di dire è legato all’ultimo, postumo libro di saggi. Per mesi avevo lavorato con Antonio alla scelta dei pezzi e alla costruzione dell’indice con montaggi, smontaggi, spostamenti fino a giungere alla limpida partizione finale che suddivideva i materiali tra Orizzonti, Scrittori, Amici, Cinema, Scrittori di oggi, Commiati, prima di una Conclusione costituita da una lettera auto-indirizzata. A mancare non era che il titolo.
Quando provavo a introdurre il discorso Tabucchi si scherniva rinviando ogni decisione alla fine; per altro da parte mia non era facile insistere, giacché era come dichiarare che ben presto avrebbe potuto non esserci tempo. Mi sono trovata così, poco dopo il 25 marzo del 2012, a consegnare al direttore editoriale della Feltrinelli il libro concluso e approvato dall’autore nel quale spiccava, come clamorosa béance, la mancanza di un titolo.
A guidarci alla sua ricerca (giacché era a noi che spettava ormai intervenire) una frase detta nell’ultima telefonata dello scrittore ad Alberto Rollo nell’annunciare la fine del lavoro. Tabucchi ci invitava a cercare il titolo nel pezzo che in quella raccolta era dedicato a Carlos Drummond de Andrade. Inutile accennare al turbamento e al tremore nello sfogliare quelle poche pagine (che sarebbero diventate poco più di due cartelle a stampa) e all’emozione che ci fece soffermare su un sintagma di Residui: “di tutto resta un poco”.
In un momento clamorosamente segnato dall’assenza emergeva un frammento situato in un luogo dislocato (per giunta quasi alla fine di quel testo), di cui solo due persone erano in prima battuta destinatarie, la cui funzione, travalicando probabilmente necessità e uso, adombrava una sorta di augurio e speranza.
Quelli che affidano alle parole tracciate su carta che trasmettono il risultato di letture e ricerche o che nascono dall’invenzione e dall’insonnia, dalle nevrosi e da sogni ad occhi aperti la possibilità di sopravvivere alla dimenticanza e di lasciare nonostante tutto segni di una durata, tracce di un’esistenza.
Il sottotitolo (Letteratura e cinema), parimenti importante per uno scrittore che di sous-titres faceva ampio uso, deciso, dopo una serie di tentativi, assieme a Maria José de Lancastre, era invece tematico, giacché per un libro di saggi non c’era bisogno di riferimenti al genere o di declinazioni di tipologia.
Perché poi fosse esplicita fino in fondo la convinzione con la quale avevamo accolto il suggerimento dell’autore – un autore che ha disseminato i suoi libri di esergo – assieme a Zè decidemmo di evocarne noi uno, che riportava, nella traduzione di Tabucchi, un ampio stralcio della lirica di Carlos Drummond de Andrade a cui eravamo stati, nonostante la distanza spazio-temporale, condotti.
Come definire allora il paratesto di quel libro? quale peso dare al titolo dell’ultima sezione, quello sì autoriale, che esplicitava dall’interno, rivolgendosi e ricordando amici scomparsi, lo status anche biografico del congedo? A chi attribuire in ultima istanza il titolo del libro e l’esergo, certo non esplicitati direttamente dall’autore ma indicati ai primi destinatari e lanciati loro come un dono di coinvolgimento? Titolazione di terzi: direi di no; piuttosto titolazione per procura, giacché a volte il pudore, la difficoltà, può impedire di parlare direttamente.
Se rileggo ora a distanza di anni le righe su Drummond de Andrade a colpirmi è la concentrazione dei suggerimenti che quel testo nel suo complesso ci invia, quasi si trattasse di una mise en abyme destinata da quel punto a riverberarsi su tutto.
Tabucchi vi parlava della raccolta poetica che aveva tradotto, esigua e minuscola in confronto con la vastità dell’opera di Drummond, ma la considerava (a dispetto delle ridotte dimensioni) sufficiente per costituire una dichiarazione di poetica e un autoritratto. Anzi per la precisione parlava di “un autoritratto che a suo modo è anche una dichiarazione di poetica” e di “una dichiarazione di poetica che a suo modo è anche un autoritratto”.
Era una provocazione quel gioco di differenza e ripetizione operato dallo spostamento del soggetto (o della funzione soggettiva) e del suo complemento predicativo (che oltre tutto, nelle due direzioni, rafforzava il valore testamentario del prelievo, “di tutto resta un poco”, legandolo indissolubilmente all’immagine autoriale), o era fin dall’inizio un invito indirizzato ai lettori a riflettere sul rapporto tra poetica (e suoi segnali) e auto-rappresentazione dell’io?
Non era forse un modo per sottolineare, perfino in un ridottissimo specimen, il gusto tipicamente tabucchiano per lo sfumato, per l’attenuazione delle asserzioni, per la possibile postulazione del dubbio suggerita dal limite intrinseco di un’affermazione ridimensionata dall’anche e dall’a suo modo?
Insomma già in quell’avvio Tabucchi lanciava un segnale lasciandoci liberi di coglierlo o meno, di credervi oppure no, visto che “in una certa misura” (la locuzione con la quale potremmo sostituire gli “a suo modo”) prevedeva e riduceva lo spazio iniziale di movimento. Incorniciare quel suo libro fra i testi di Drummond de Andrade non ci aiuta forse “a mettere meglio a fuoco l’obiettivo, a ritenere un’immagine leggibile, o più ‘riconoscibile’” (sono parole sue) di chi aveva vergato quelle pagine?
Non ci aiuta forse a fare, partendo dalla poetica, l’autoritratto di un intellettuale capace di riconoscere le affinità, di non avere “paura della paura” mentre osservava “ciò che viene dalla vita quotidiana, da questo nostro dover essere, dal piccolo, dall’insignificante, dal niente […]. Un niente testardo […] che non muore, che resiste, che circola nei canali più ingrati della vita […]. Perché ‘di tutto resta un poco’ (Resíduo), ed è con questo poco, che poi è il nostro tutto, che dobbiamo fare i conti”.
Per leggere gli articoli di Anna Dolfi su Periscopio clicca sul nome dell’autrice






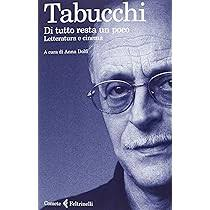










Straordinaria questa avventura alla ricerca del titolo, per poi trovarlo, già fatto e finito, dentro (nascosto) nel testo. Grazie ad Anna per questo racconto dotto e avvincente. Tabucchi è davvero inesauribile.