Presto di mattina /
Poesia e profezia per riedificare perennemente l’uomo
Tempo di lettura: 9 minuti
Presto di mattina. Poesia e profezia per riedificare perennemente l’uomo
A commento di Novogodnee (‘Vigilia del nuovo anno’), poema scritto da Marina Ivanovna Cvetaeva in morte di Rainer Maria Rilke, Iosif Brodskij definisce il poeta come «qualcuno per cui ogni parola non è la fine ma l’inizio», «qualcuno che, avendo pronunciato la parola raj (‘paradiso’) o tot svet (‘l’altro mondo’), deve mentalmente fare il passo successivo e trovare le rime adatte.
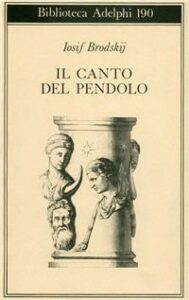 Così nascono kraj (‘paese’) e otsvet (‘riflesso’) e così viene prolungata l’esistenza di coloro la cui vita si è interrotta… [Poeta] è qualcuno che prolunga la prospettiva della sensibilità umana, che mostra un varco, una strada da seguire, a chi non vede vie d’uscita» (Il canto del Pendolo, Adelphi, Milano 1987, 203; 85).
Così nascono kraj (‘paese’) e otsvet (‘riflesso’) e così viene prolungata l’esistenza di coloro la cui vita si è interrotta… [Poeta] è qualcuno che prolunga la prospettiva della sensibilità umana, che mostra un varco, una strada da seguire, a chi non vede vie d’uscita» (Il canto del Pendolo, Adelphi, Milano 1987, 203; 85).
Cercando parole, il poeta dà corpo ad un’assenza, prolunga una presenza, dove ogni parola diventa aurora e non crepuscolo, vigilia e non conclusione inizio senza fine: una via d’uscita.
Non diversamente da una profezia, la poesia è sempre nella possibilità di aprire verso un testo, una parola e un orizzonte nuovi. Perché direbbe Maria Zambrano «La poesia è un aprirsi dell’essere verso dentro e verso fuori al tempo stesso. È un udire nel silenzio e un vedere nell’oscurità. È un uscire da sé, un possedersi per essersi dimenticati, un dimenticarsi per aver guadagnato la rinuncia totale.
Un possedersi per non aver più nulla da dare; un uscire da sé innamorato; un darsi a ciò che non si sa ancora, né si vede. Un ritrovarsi integri per essersi interamente dati. La poesia, configurandosi come uscir da sé dell’anima dal suo steccato e come apertura dell’essere − verso dentro e verso fuori − non può calcolare i passi che dà, né tantomeno soffermarvisi. Ciò che per essa si verifica è qualcosa di assoluto» (Poesia e filosofia, Pendragon, Bologna 2010, 120-121).
Poesia pura: credere alla parola, vivere della parola
Le parole sono nella poesia e nella profezia in status nascendi e in cammino al tempo stesso, oscillando in un movimento di pendolo tra assenza e presenza. Per questo, secondo la Zambrano, il poeta è un mistico, dando luogo a una coincidenza che non di rado si è incarnata nella storia come nel caso di Giovanni della Croce.
Poeta e mistico, con la loro parola, penetrano sempre di nuovo, parola dopo parola, lentamente nella notte oscura dell’inesprimibile per passare dall’assenza alla presenza, così da dare corpo all’indicibile, senza rassegnarsi alla superficiale apparenza.
 Il poeta, il profeta e il mistico vedono l’infinitezza e la consistenza inconsunta di ogni cosa oltre l’oscurità del nulla. Nell’abissale notte della fede sono interpellati dal riverbero di una Parola che non passa, essi sentono tutto il peso di immortalità: «Sento un calore impressionante tutto intorno al cuore – come un peso di Immortalità» (J. Keats, Lettere sulla Poesia, Mondadori, Milano 2014, 164).
Il poeta, il profeta e il mistico vedono l’infinitezza e la consistenza inconsunta di ogni cosa oltre l’oscurità del nulla. Nell’abissale notte della fede sono interpellati dal riverbero di una Parola che non passa, essi sentono tutto il peso di immortalità: «Sento un calore impressionante tutto intorno al cuore – come un peso di Immortalità» (J. Keats, Lettere sulla Poesia, Mondadori, Milano 2014, 164).
Scrive ancora la Zambrano: «Poesia pura significa affermare la poesia, credere in essa, alla sua sostantività, alla sua solitudine, alla sua indipendenza»; significa dire che «la poesia è tutto. Al poeta è sufficiente far poesia per esistere; è la forma più pura di realizzazione dell’essenza umana» (Poesia e filosofia, 98).
Questa espressione − dice la Zambrano − benché sia stata formulata da Mallarmé, prende corpo e si definisce con il poeta Paul Valéry. Formula felice, la definisce, perché «è un acuirsi estremo della coscienza del poeta che, forse per la prima volta, sente chiaramente come funziona la sua poesia. E non trovando con che cosa compararla, sentendo la differenza tra la parola poetica e quella del linguaggio della vita e anche della scienza, parla di “assenze”.
Le cose sono nella poesia per assenza, che è il loro lato più autentico. Infatti, quando qualcosa ci lascia, rimane più vera perché è incancellabile: sua pura essenza. E la stessa realtà si cela a se stessa. Inoltre, con questo gioco di assenza e presenza, le cose ci appaiono immerse nel flusso del tempo; si mostrano a noi come sempre nascenti. La loro presenza è un miracolo, il miracolo originario dell’apparire delle cose. Poesia è sentire le cose in status nascens» (ivi, 129-130).
 Per Henri Brémond, storico del sentimento religioso e critico letterario francese, con l’espressione “poesia pura” è da intendersi un appello nell’interiorità, che precede e prescinde da un senso e da un significato definiti; per tale misterioso incanto, l’intuizione del poeta viene così a coincidere con l’ascesi del mistico.
Per Henri Brémond, storico del sentimento religioso e critico letterario francese, con l’espressione “poesia pura” è da intendersi un appello nell’interiorità, che precede e prescinde da un senso e da un significato definiti; per tale misterioso incanto, l’intuizione del poeta viene così a coincidere con l’ascesi del mistico.
Egli, mettendo in luce i rapporti tra esperienza religiosa ed esperienza estetica, riscontra la stretta connessione che intercorre tra la poesia, l’arte in genere e la preghiera. È solo nell’ambito psicologico che entrambe, le esperienze della preghiera e della creatività poetica, funzionano in modo simile e tuttavia permangono irriducibili tra loro le differenze circa la loro natura propria e singolarità (Preghiera e poesia, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010).
Poesia e profezia per riedificare umanamente “vita d’uomo”
Da pertinaci fumi risalito
Fu allora che intravvidi
Perché m’accende ancora la speranza…
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo
(G. Ungaretti, Vita d’uomo. Tutte le poesie, Oscar Mondadori, Milano 1992, 227; 299-230).
La speranza, che è la forza per tornare a vivere, viene dalla parola. È quella parola che perennemente principia e s’incarna a riedificare umanamente l’uomo. Così la parola profetica è inizio della speranza e il profeta «è un realista delle distanze», nel senso che vede molto vicine le cose distanti e discerne in quelle a portata di mano i prolungamenti e le ramificazioni del loro significato nascosto (M. Flannery O’Connor).
La speranza, come la profezia e la poesia, non può essere descritta ma solo vissuta, perché la speranza è ineffabile come la Presenza di Dio percepita dai mistici: non si rivela nella chiarezza, ma nell’oscurità,
Il profeta è colui che ha a che fare, venendone coinvolto fino all’eccesso, con la sollecitudine di Dio per l’umano e per il mondo: giustizia e compassione. Viene afferrato nel vortice di una parola seducente, irresistibile e trasformante.
“Tu mi hai sedotto” dice Geremia ed “io mi sono lasciato sedurre”. Egli diviene così un traghettatore che tiene unite due rive nella divaricazione abissale, lacerata dell’umano; garante della promessa e della sollecitudine santa e sentinella del suo venire, che nell’attesa ascolta il grido degli oppressi e non cessa di difendere i poveri, ammonire i re, denunciare i potenti, condannare i sacerdoti che riducono la preghiera a una vuota ripetizione di parole e sacrifici.
“Sentinella, quanto resta della notte?”
La speranza profetica, come la parola poetica, non smettere di attendere, di iniziare sempre di nuovo l’attesa di un’altra parola, di un altro mattino, così dopo ancora una notte occorre non stancarsi di vegliare e di attendere e interrogandosi.
«Mi gridano da Seir: “Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella, quanto resta della notte?”. La sentinella risponde: “Viene il mattino, ma presto di nuovo la notte. Se volete fare altre domande, tornate di nuovo”» (Is 21, 11).
 Così il commento del biblista L. Alonso Schökel: «è notte nello scenario della storia, le tenebre non lasciano comprendere né è dato calcolare quando giungerà l’aurora liberatrice (Sal 130,6-7). Ma c’è qualcuno che con gli occhi penetra l’oscurità e misura i tempi: è il profeta.
Così il commento del biblista L. Alonso Schökel: «è notte nello scenario della storia, le tenebre non lasciano comprendere né è dato calcolare quando giungerà l’aurora liberatrice (Sal 130,6-7). Ma c’è qualcuno che con gli occhi penetra l’oscurità e misura i tempi: è il profeta.
A lui ricorrono anche i popoli stranieri e nemici: che ora è? Che sta succedendo in questa lunga notte? Quando finirà? Il profeta non ha una risposta liberatrice. Conosce soltanto un ciclo dominato dall’inesorabile ritorno della notte; per quanto essa cessi e albeggi, siamo nell’ora delle tenebre. Ma invita a domandare di nuovo, casomai ricevesse nel frattempo una risposta precisa del Signore. E l’oracolo torna “al silenzio”, “all’attesa”» (L. Alonso-Schökel, J.L. Sicre Diaz, I profeti, Borla, Roma 2000, 216).
Profeti di pace
Tra questi vi è Olga Karač, candidata al Nobel per la pace, più volte incarcerata dal regime di Lukashenko per aver gridato gli orrori del regime. In un’intervista ad Avvenire (Dorella Cianci, lunedì 29 aprile 2024) ammonisce: «La cultura della guerra getta via la tolleranza e il rispetto per l’altro, ci vuole coraggio per parlare di pace. Non tirarti indietro e non arrenderti, anche se la maggioranza non è d’accordo con te. La situazione è molto difficile: parlare di pace è diventato tossico. Le organizzazioni che lottano per la pace sono sotto attacco».
Olga Karach, 45 anni, è un’attivista bielorussa, politologa e direttrice dell’organizzazione per i diritti umani Our House (‘La nostra casa’), fondata nel 2002 sotto forma di giornale autofinanziato. È attiva nella rete dei difensori dei diritti umani e civili oppressi nel suo Paese dal regime di Lukashenko. Per questo è stata più volte incarcerata e anche torturata. Oggi vive in esilio a Vilnius, in Lituania, da dove prosegue la sua preziosa attività nonviolenta.
«Oggi ci vuole un coraggio speciale per parlare di pace, indipendentemente dal tipo di conflitto militare da citare. La società è polarizzata e radicalizzata. Non appena si dice qualcosa sulla pace, si inizia a essere perseguitati, sospettati dei peccati peggiori, e le conseguenze non sono così innocue. La cosa più sorprendente è che ciò accade non solo nei Paesi baltici, che ora si appoggiano fortemente all’estrema destra, ma anche nei Paesi dell’Europa occidentale.
Qualcosa sembra esserci rotto nel sistema europeo di valori e nelle già inespresse regole dei diritti umani. Dove è finita la libertà di parola, di cui tutti erano orgogliosi? Perché il dialogo politico si è trasformato in un punto di vista dominante, mentre altri punti di vista sono etichettati a priori come sbagliati? La cosa peggiore è che non abbiamo notato come, in due anni, la cultura europea sia radicalmente cambiata da una cultura di pace e nonviolenza a una cultura di violenza e romanticizzazione della guerra».
Come fece nel 2023 alla consegna del Premio internazionale Alexander Langer, la nomination al Nobel è stata un’occasione per Olga Karach di riparlare della situazione in Bielorussia, della violenza e della tortura subita anche dagli obiettori di coscienza, rispetto ai quali essa auspica un programma di assistenza:
«Si tratta di una campagna strategicamente rilevante: la guerra non può continuare se gli uomini si rifiutano di entrare in guerra. Tutti possono farlo, e la scelta personale di ognuno ha un impatto colossale sulla guerra e sulla militarizzazione. Ci vuole coraggio anche per rifiutarsi di andare in guerra, perché la società è strutturata per la guerra».
Poesia e preghiera dimora appassionata del dolore d’altri: “D’un pianto solo mio non piango più”
Il tema della guerra nella raccolta Il Dolore di Ungaretti appare come “un canto aperto, solenne corale” dice Leone Piccioni; una poetica che si illumina fino a divenire preghiera, una poesia orante che è insieme resistenza ed attesa, perché non vana sarà l’ospitalità di amore, la sua dimora. Santità ospitale è quella che accoglie l’altrui dolore la sola che “perennemente” riedifica “umanamente” vita d’uomini.
Il mondo d’abissale pena soffoca;
Ora che insopportabile il tormento
Si sfrena tra i fratelli in ira a morte;
Ora che osano dire
Le mie blasfeme labbra:
«Cristo, pensoso palpito,
Perché la Tua bontà
S’è tanto allontanata?»
Ora che pecorelle cogli agnelli
Si sbandano stupite e, per le strade
Che già furono urbane, si desolano;
Ora che prova un popolo
Dopo gli strappi dell’emigrazione,
La stolta iniquità
Delle deportazioni;
Ora che nelle fosse
Con fantasia ritorta
E mani spudorate
Dalle fattezze umane l’uomo lacera
L’immagine divina
E pietà in grido si contrae di pietra;
Ora che l’innocenza
Reclama almeno un’eco,
E geme anche nel cuore più indurito;
Ora che sono vani gli altri gridi;
Vedo ora chiaro nella notte triste.
Vedo ora nella notte triste, imparo,
So che l’inferno s’apre sulla terra
Su misura di quanto
L’uomo si sottrae, folle,
Alla purezza della Tua passione.
Fa piaga nel Tuo cuore
La somma del dolore
Che va spargendo sulla terra l’uomo;
Il Tuo cuore è la sede appassionata
Dell’amore non vano.
Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo,
Santo, Santo che soffri,
Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli,
Santo, Santo che soffri
Per liberare dalla morte i morti
E sorreggere noi infelici vivi,
D’un pianto solo mio non piango più,
Ecco, Ti chiamo, Santo,
Santo, Santo che soffri.
(Vita d’uomo, ivi, 228-230)
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.

Sostieni periscopio!
Andrea Zerbini
PAESE REALE
di Piermaria Romani
Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.
Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.
(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)













Lascia un commento