PRESTO DI MATTINA /
La voce del silenzio
Ascolta la voce del silenzio
“O silenzio!
strillo di cicale
penetra le rocce”.
(Matsuo Bashō, Poesie, Sansoni, Firenze 1944, 37).
Nel testo a commento di questo haiku si legge che fu ispirato a Bashò [Qui] visitando il tempio di Rûshakuji, vicino alla città di Yamagata.
Situato fra antichi pini e querce sopra numerose e gigantesche rocce muschiose: «Due o tre voci di cicale relativamente basse udite di quando in quando in un luogo quieto danno vie più l’impressione del silenzio (M.)»
Si custodisce il creato come si custodisce la parola di Dio, ascoltandola e vivendola: è il creato la sua parola silenziosa: «Ascolta la voce del creato». Si custodiscono i poveri come si custodisce l’eucaristia, condividendola, celebrandola nella vita: «Ascolta la voce dei poveri».
‘Custodire nel cuore’ è verbo che troviamo nel vocabolario della Sapienza. Il grido dei poveri come la parola silenziosa del creato deve essere macerata, sminuzzata, continuamente ruminata, al pari della parola di Dio − dicevano i Padri del deserto − affinché diventi vita con e nelle nostre vite, storia con e nelle nostre storie.
«Ascolta la voce del creato». È questo il tema scelto da papa Francesco per il suo messaggio nella giornata per la cura del creato. In realtà, più che una sola giornata è un periodo che stiamo vivendo: il tempo del creato, che è iniziato il 1° settembre e si concluderà il 4 ottobre, con la festa di san Francesco.
Senza ascolto profondo, senza crederci, non si attua nessun cambiamento radicale, né in noi, né nel creato e ancor meno nella società. Di qui l’invito all’ascolto quale viatico di conversione, non solo individuale, ma comunitaria;
noi in umanità solidale «Come persone di fede, ci sentiamo ulteriormente responsabili di agire, nei comportamenti quotidiani, in consonanza con tale esigenza di conversione.
Ma essa non è solo individuale: “La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria” (Laudato Sii, 219).
In questa prospettiva, anche la comunità delle nazioni è chiamata a impegnarsi, specialmente negli incontri delle Nazioni Unite dedicati alla questione ambientale, con spirito di massima cooperazione» (Messaggio, Ascolta la voce del creato). Così l’umanità tutta va compresa come soggetto chiamato alla cura della madre terra e dei poveri.
L’ascolto inizia con uno sguardo sul creato, sull’altro, quello dell’enciclica Laudato sii [Qui], che è insieme un’enciclica verde, ma al contempo fortemente sociale, capace di discernere, cioè di vedere nella questione ecologica alla sua radice il problema sociale, e nei poveri la cristologia, il Cristo stesso e la conseguente pratica di un’opzione preferenziale per i poveri.
Un “tempo per il creato” fu proposto dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli sin dalla fine degli anni ottanta. Ma ancor prima papa Paolo VI auspicava un tempo di riflessione necessario a prevenire una “catastrofe ecologica”. Un tempo per coltivare la nostra “conversione ecologica”, rilanciava Giovanni Paolo II.
Quella ecologica, non può che essere infatti una sfida che unisce tutti i cristiani. Al pari di quella della giustizia e della pace fu sempre di più la coscienza e l’impegno che animò il cammino del Consiglio Ecumenico delle Chiese nella seconda metà del secolo scorso.
L’ambito ecumenico conferì uno sviluppo ulteriore alla sensibilità dei temi ambientali, intrecciando – non a caso − il tema della cura del creato con i temi della giustizia e della pace.
In questo solco anche la Conferenza episcopale italiana attraverso le sue commissioni per i problemi sociali e il lavoro, della giustizia e della pace, unitamente a quelle per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, dal 1º settembre 2006, ha iniziato a celebrare annuale la “Giornata per la salvaguardia del creato” che poi prenderà il nome “per custodia del creato”.
Dolce canto e grido amaro
“Il canto delle cicale
non dà segno
di loro vicino morire”.
(Bashō, 10)
Scrive papa Francesco: «Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani.»
Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (LS, 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un invito a fondare la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale» (ivi, 220).
Per i discepoli di Cristo, in particolare, tale luminosa esperienza rafforza la consapevolezza che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1, 3).
In questo Tempo del Creato, riprendiamo quindi a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del «grandioso coro cosmico» di innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio.
Uniamoci a san Francesco d’Assisi [Qui] nel cantare: “Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature” (cfr. Cantico di frate sole). Uniamoci al Salmista nel cantare: «Ogni vivente dia lode al Signore!» (Sal 150, 6).
Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata da un grido amaro. O meglio, da un coro di grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione.
Poi, sono le diverse creature a gridare. Alla mercé di un “antropocentrismo dispotico” (ivi, 68), agli antipodi della centralità di Cristo nell’opera della creazione, innumerevoli specie si stanno estinguendo, cessando per sempre i loro inni di lode a Dio.
Ma sono anche i più poveri tra noi a gridare. Esposti alla crisi climatica, gli “ultimi” soffrono più fortemente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate di caldo che continuano a diventare sempre più intensi e frequenti.
Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle di popoli nativi. A causa di interessi economici predatori, i loro territori ancestrali vengono invasi e devastati da ogni parte, lanciando “un grido che sale al cielo” (Querida Amazonia, 9).
Infine, gridano i nostri figli. Minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta.
Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi. Sin dall’inizio, l’appello evangelico: «Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!» (Mt 3, 2), invitando a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un rapporto diverso con gli altri e con il creato.
Lo stato di degrado della nostra casa comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie e i conflitti bellici. «Vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (ivi, 217) (Messaggio).
“Dall’amaro al dolce”, è l’espressione che frate Francesco al termine della vita ricorda ai suoi come sintesi della propria conversione.
Non solo quella iniziale ma anche quella sperimentata lungo tutta la propria esistenza, vissuta come un continuo passaggio pasquale da una logica autocentrica e autoreferenziale ad una proiezione eccentrica, evangelica; da un pratica di dominio e sfruttamento all’essere servo di ogni creatura.
Un cambiamento radicale è anche quello ecologico, purché parta dall’ascolto del grido amaro della natura e dei suoi più vulnerabili abitanti per poter ritornare al dolce cantico di tutte le creature.
«Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato (conversum fuit) in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo» (Fonti francescane, 110).
Anche l’amaro di Bashō, per l’improvvisa morte, a 25 anni, del suo maestro Jshitada, o “Sengin”, si mutò in una mistica dolce, di poeta itinerante: «il poeta pianse colui che per anni gli era stato maestro e amico. Come voleva l’usanza andò sul monte Koya con una ciocca di capelli del defunto a depositarla nel grande monastero buddista.
La tradizione vuole che per il dolore fosse preso da un amaro desiderio di ritiro; ma di certo, da allora, fu un mistico umile e povero, predicatore della bontà universale. Riuscì a liberarsi con onore da ogni funzione ufficiale e, abbandonata la casa del suo signore, andò a Kyiìto facendosi alunno e domestico di Kigin che aveva avuto per l’addietro occasione di praticare recandosi da lui come messaggero di Joshitada» (Bashō, 50).
L’amaro grido del mare, eco muto
Fuggono Farid e sua madre Jamila dopo l’uccisione del padre Omar in Libia al tempo di Gheddafi. Fuggono per la guerra lasciando il deserto, la loro casa; ma il viaggio per mare sul barcone verso l’Italia non andrà a buon fine. È una storia raccontata con grande sensibilità poetica senza mortificarne tutta la drammatica tragicità da Margaret Mazzantini [Qui], in Mare al mattino, Einaudi, Torino 2011.
 «Farid non ha mai visto il mare, non c’è mai entrato dentro. Lo ha immaginato tante volte. Punteggiato di stelle come il mantello di un pascià. Azzurro come il muro azzurro della città morta.
«Farid non ha mai visto il mare, non c’è mai entrato dentro. Lo ha immaginato tante volte. Punteggiato di stelle come il mantello di un pascià. Azzurro come il muro azzurro della città morta.
Ha cercato le conchiglie fossili sepolte milioni di anni fa, quando il mare entrava nel deserto. Ha rincorso i pesci lucertola che nuotano sotto la sabbia. Ha visto il lago salato e quello amaro e i dromedari color argento avanzare come logore navi di pirati.
Abita in una delle ultime oasi del Sahara. I suoi antenati appartenevano a una tribù di beduini nomadi. Si fermavano negli uadi, i letti dei fiumi coperti di vegetazione, montavano le tende. Le capre pascolavano, le mogli cucinavano sulle pietre roventi.
Non avevano mai lasciato il deserto. C’era una certa diffidenza verso la gente della costa, mercanti, corsari. Il deserto era la loro casa, aperta, illimitata. Il loro mare di sabbia. Macchiato dalle dune come il manto d’un giaguaro.
Non possedevano nulla. Solo impronte di passi che la sabbia ricopriva. Il sole muoveva le ombre. Erano abituati a resistere alla sete, ad essiccarsi come datteri, senza morire. Un dromedario apriva loro la strada, una lunga ombra storta. Scomparivano nelle dune. Siamo invisibili al mondo, ma non a Dio. Si spostavano con questo pensiero nel cuore.
D’inverno il vento del nord che attraversava l’oceano di roccia stecchiva i barracani di lana sui corpi, la pelle si aggrappava alle ossa dissanguata come quella di capra sui tamburi.
… In primavera nuove dune nascevano, rosate e pallide. Vergini di sabbia. Il ghibli infuocato si avvicinava insieme al gemito rauco di uno sciacallo. Piccoli riccioli di vento come spiriti in viaggio pizzicavano la sabbia qua e là. In un attimo il deserto si sollevava e divorava il cielo. E non c’era più confine con l’aldilà…
I dinari dei risparmi di Omar, gli euro e i dollari che nonno Mussa ha guadagnato con i turisti del deserto. Omar conta i soldi, poi toglie una pietra e li nasconde nel muro. Parla con Jamila, chiude le mani intorno alle sue mani strette.
Farid non dorme, guarda quel nodo di mani nel buio che tremano come una noce di cocco sotto la pioggia. Omar dice che devono andarsene. Che avrebbero dovuto farlo da un pezzo. Nel deserto non c’è futuro. E adesso c’è la guerra. Ha paura per il bambino» (ivi, 4-5; 8).
Un altro deserto, un altro grido: il grande sertão
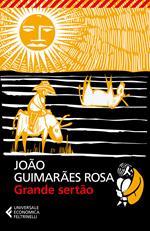 «Ed ecco, il sole, con un balzo, lontano alle nostre spalle, al di sopra dei macchioni, scoppiava, una grandiosità. Giorno spiegato. Terminò la vegetazione da foraggio, e gli arbusti spinosi, come quei cespugli dai virgulti argentati, e simili. Terminava l’erba, in quei paraggi grigiastri.
«Ed ecco, il sole, con un balzo, lontano alle nostre spalle, al di sopra dei macchioni, scoppiava, una grandiosità. Giorno spiegato. Terminò la vegetazione da foraggio, e gli arbusti spinosi, come quei cespugli dai virgulti argentati, e simili. Terminava l’erba, in quei paraggi grigiastri.
E tutto questo, arrivando a poco a poco, dava un’oppressione raddensata, il mondo si stava invecchiando, nel viandante. Terminò il sapé selvatico dell’altipiano. Uno si guardava alle spalle. A quel punto, il sole non lasciava guardare in nessuna direzione.
Vidi la luce, un castigo. Vidi uno sparviere: fu l’ultimo uccello che si scorse. Ed ecco che stavamo in quella cosa – deserto pieno, vuoto soffice, rovesciato. Era una terra differente, insensata, un lago di sabbia.
Dove si sarà trovato il suo soverchio, confinante? Il sole si rovesciava sul suolo, con sale, sfavillava. Di quando in quando, una vegetazione morta, qualche ciuffo di pianta secca – come una chioma senza testa. Si propagava a distanza, in avanti, un vapore giallo. E il fuoco cominciò a entrare, con l’aria, nei nostri poveri petti.
… La continuazione del martirio, da quando spuntò il mattino, del giorno seguente, nella brumalva di quel defunto albeggiare, senza nessuna speranza, senza neppure la semplice presenza degli uccellini.
Ci muovemmo. Io abbassavo gli occhi per non vedere gli orizzonti, che chiusi non mutavano, incombevano. La Landa dell’Onza Rossa concepiva silenzio, e produceva una cattiveria – come persona!
… Le piogge già erano state dimenticate, e lì c’era il midollo tristo del sertão, era un sole sul vuoto. Si avanzava di pochi metri, e si calcava il sabbione, una sabbia che sfuggiva, senza consistenza, spingendo all’indietro gli zoccoli dei cavalli.
Poi, sopravveniva un aggrovigliamento intricato, di arbusti spinosi e stoppia di gravia, assai scabroso, di un verde-nero color serpente. Nessun cammino. Di lì, si passa a un terreno duro rosato o color cenere, screpolato e ruvido – i cavalli, non intendendolo, s’innervosivano».
(João Guimãres Rosa [Qui], Grande sertão, Feltrinelli, Milano 2017, 42-44).
Si diventa consapevoli di sé e del cammino solo con l’irruzione dell’altro. Affinché si ritrovi la strada per la cura del creato occorre sempre di nuovo ascoltare il suo dolce canto e il grido amaro.
Lasciamoci guidare dall’istinto insito nel creato e dallo stupore ancora promettente, il creato sarà per noi come quel contadino che camminava avanti portando il foraggio sul dorso. Senza saperlo, servì da guida a Bashō e a Sora, suo discepolo, alla ricerca dello “stretto sentiero del nord”, che altrimenti si sarebbero smarriti per il vasto deserto della pianura di Nasuno.
Un cambiamento radicale di stile e di sguardo; scrive Chandra Candiani di Bashō: «La nostra fame di spirito, di vastità, può trovare in Bashō una bussola, dentro gli stretti sentieri della vita messa a nudo, la sua asciuttezza, la sua sobrietà ma soprattutto l’incantevole parità del suo sguardo sul mondo: “Sui monti d’estate/ Partendo/ Mi inchino ai sandali di legno”» (Chandra Candiani, Lo stretto sentiero del profondo nord, Einaudi, Torino 2022, xxiii-xxiv).
Traverso la landa d’estate
ci guida un uomo che porta
un fascio di fieno sul dorso.
Sopra il sentiero montano
nasce improvviso il sole
fra il profumo dei fiori di prugno.
(Bashō, 23; 20)
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]

















Wow that was strange. I just wrote an extremely long
comment but after I clicked submit my comment didn’t show
up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted
to say wonderful blog!