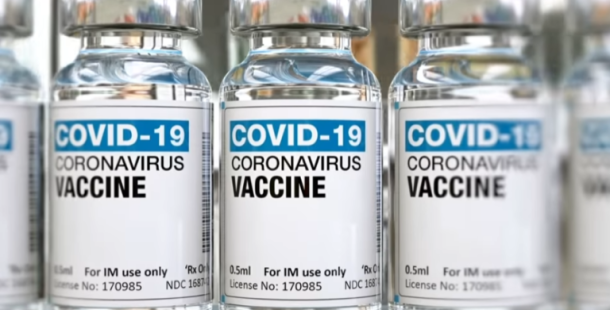Piovono pietre su Fornero e Jobs Act:
il lavoratore non è una merce
L’ultimo decennio ha segnato un arretramento secco sul fronte dei diritti dei lavoratori. Abbiamo assistito alla traduzione in leggi (prima la Fornero, nel 2012, poi il Jobs Act, nel 2015) di un’idea secondo la quale il lavoro è una pura merce, priva di un valore in sè che incorpori la realizzazione attraverso di esso dei valori di dignità e personalità umana. Una merce come tante altre, che si paga ad un prezzo di mercato: più quella merce è sostituibile, più il suo valore si deprezza. Più persone sono disposte a fornire la stessa merce, meno costa procedere alla sostituzione della singola persona, pura fornitrice di forza-lavoro.
Attenzione: l’obiezione secondo la quale i contratti di somministrazione, i negozi a termine, i finti contratti di collaborazione “autonoma” realizzavano già, in abbondanza, questa idea restituisce il clima di progressiva precarizzazione del lavoro incorporato nella pletora delle diverse forme contrattuali.
Ma le operazioni compiute con la Fornero e il Jobs Act hanno fatto compiere alla legislazione un salto di qualità negativo, rendendo in un certo senso precario ab origine anche il rapporto a tempo indeterminato. Non mi soffermo più di un attimo sull’inganno di senso costruito sul termine “flessibilità”, usato per conferire un velo di cosmesi al reale concetto sotteso, che è “precarietà”. Quando la precarietà diventa, come nella Fornero e nel Jobs Act, elemento costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la derubricazione del lavoro a pura merce non è più una variazione sul tema giustificabile, di volta in volta, con le necessità di inserimento graduale nel mondo del lavoro o con le caratteristiche di impieghi che comunque non saranno svolti per tutta la vita. No: la precarietà diventa elemento ontologico del lavoro, deprivando di garanzie e sicurezze un intero percorso professionale, che diventa così soggetto, dall’inizio alla fine, al potere di ricatto della controparte datoriale.
Chi è assunto dal marzo 2015 con il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” sa fin dall’inizio che potrà essere licenziato senza una giusta causa, e che il prezzo che potrà incassare se un giudice riconoscerà l’ingiustizia (e intanto bisogna andarci, da un giudice) sarà un puro indennizzo, sganciato del tutto dalla gravità dell’ingiustizia subita e commisurato solo alla sua anzianità di servizio: una specie di liquidazione impropria (e di importo modesto) per liberarsi di uno scomodo/a. Ciò implica che un datore di lavoro può calcolare in anticipo il prezzo del suo arbitrio, come un qualunque altro costo aziendale. Lo può mettere a budget.
La progressiva traslazione da “prestazione lavorativa” a “performance” è anch’essa un inganno, funzionale ad una sottrazione di tutele.
Se la prestazione sul lavoro di ognuno dei 24 milioni di individui (all’incirca la popolazione occupata in Italia) dovesse essere misurata come si misura una prestazione sportiva professionistica, allora tre quarti dei lavoratori italiani meriterebbero il licenziamento, e tra essi ci saremmo anche noi. Sfortunatamente, questa riduzione a competizione parasportiva di ogni elemento attinente al lavoro finisce per inficiare anche quella parte di valutazione (e di extra-retribuzione) legata al raggiungimento di obiettivi, che si concentra esclusivamente sulla quantità di cose fatte o vendute: se sei un poliziotto, quanti arresti hai compiuto; se sei un assicuratore, quante polizze hai venduto; se sei un primario, quanti posti letto hai liberato.
Non importa realmente in quale modo è stato ottenuto questo risultato: il quanto è oggetto di premio, il come non lo è. Ricordo un solo esempio tra gli innumerevoli che si potrebbero fare: la caserma dei carabinieri Levante di Piacenza (che poi una procura scoprì essere una minicupola dedita allo spaccio e al ricatto) poco prima ricevette un encomio solenne dal comandante della Legione Emilia-Romagna per i risultati conseguiti nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. Sapete perché? Per il numero di arresti compiuti. Peccato che molti di essi fossero arresti abusivi, funzionali alle minacce, ai pestaggi, alle torture.
Lo “scarso rendimento” che può giustificare addirittura un licenziamento esiste nel nostro ordinamento, ed è costruito dalla giurisprudenza di merito. Ma se non si considera come elemento costitutivo della nozione di “scarso rendimento” una responsabilità soggettiva del lavoratore, allora anche un lavoratore malato assente spesso a causa delle cure da sostenere, o una madre assente per gravidanza possono essere imputati di “scarso rendimento”, come dato oggettivo.
Per non parlare poi dei licenziamenti per “giustificato motivo oggettivo” legati alle condizioni economiche, o alle scelte organizzative dell’azienda, che comportano la soppressione di quel posto, o la esternalizzazione di quella funzione.
In tutti questi casi, la legge ordinaria in materia di lavoro degli ultimi vent’ anni, spiace dirlo, sembra scritta spesso da emissari delle aziende. Per questo, non saremo mai abbastanza grati ai padri costituenti per avere scritto la Costituzione e alla Corte Costituzionale per la capacità, tuttora integra, di censurare le nostre leggi quando non sono conformi ai principi costituzionali.
L’ultimo esempio è la sentenza 59 del 2021, con la quale la Corte ha decretato che l’art.18 Statuto lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero nel 2012, è incostituzionale laddove, in caso di licenziamento per motivi economici di cui sia accertata la manifesta insussistenza della causa, preveda che il giudice può scegliere se indennizzare o reintegrare il lavoratore.
Il principio costituzionale violato è quello di uguaglianza (art.3): infatti, quando in un licenziamento per giusta causa il fatto posto a base del provvedimento è inesistente, la reintegra del licenziato è obbligatoria, non facoltativa. Dal momento che il presupposto dell’insussistenza del fatto ha meritato la tutela della reintegra, la Corte afferma che la stessa non può essere facoltativa quando l’insussistenza è legata ad un licenziamento dichiarato come economico. Fuori dai tecnicismi, significa questo: se vengo licenziato senza un motivo, il giudice deve disporre la mia reintegra.
Che poi il lavoratore (non il giudice) possa decidere di far convertire in denaro questo diritto, è quello che fa la differenza tra una somma a titolo di risarcimento (come quella che sostituisce una reintegra nel posto di lavoro) e un indennizzo (come quello del Jobs Act).
Nel primo caso (risarcimento), la cifra deve corrispondere alla ricompensa per un danno ingiusto subito.
Nel secondo (indennizzo), la cifra è un contentino a fronte di un atto che l’ordinamento non considera nemmeno antigiuridico.
Il che rende ancora più evidente (e odiosa) la disciplina puramente indennitaria del Jobs Act, che presuppone che un licenziamento ingiustificato non sia fonte di danno ingiusto verso il lavoratore. Danno sì, ma non ingiusto. Che questa bella impostazione sia stata propugnata non da Margaret Thatcher, ma dall’allora segretario del PD, trascinandosi dietro una buona fetta del partito, restituisce la misura dello smottamento che una parte della sinistra ha compiuto verso il più scellerato dei liberismi, se applicato bovinamente a quella che loro considerano la ‘merce’ lavoro.
La sentenza della Corte purtroppo non risolve automaticamente i problemi di coloro che sono stati assunti dopo il marzo 2015, con un contratto redatto ai sensi di un corpus normativo (Jobs Act) che, appunto, non considera nemmeno il licenziamento ingiustificato come un atto antigiuridico. Tuttavia è un grande passo nella direzione della riconquista del significato costituzionale del lavoro, come strumento di affermazione della personalità e dignità umana: perché una Repubblica che si dichiara “fondata sul lavoro” non può essere fondata su una merce.