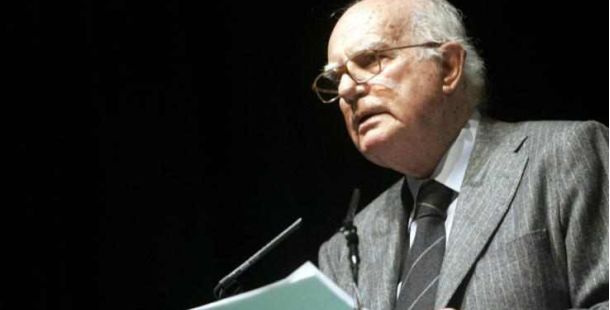PAGINE DI GIORNALISMO
Pensieri sul corpo morto di una terrorista
Dal basso vedevo quell’albero gonfio di foglie e di frutti, “sopra, vede? Cinquanta metri sopra l’albero, ecco quella cascina è Cascina Spiotta, è là che c’è stata la sparatoria”, mi disse un contadino. Risalii il campo un po’ faticosamente, erano due giorni che giravo come un matto per il Piemonte, da Casale Monferrato, ora ad Acqui Terme, posti stupendi che giustamente i romani frequentavano nelle loro vacanze. Erano, quelli, i dolci luoghi delle villeggiature, del benessere, erano le spa di allora: ruscelli zampillanti, acque sulfuree, acque tiepide, gran vino, tortelli (già allora?), gente burbera che parla poco, a volte scontrosa. La sparatoria si era svolta lassù, “dicono che ci sono dei morti”, aveva concluso la sua informazione il contadino, rimettendo poi in moto con due pedalate il ciclomotore e per scomparire dietro la curva cinquanta metri più avanti. Potevo fare la stessa strada, troppo lunga, preferii risalire la collina sotto un sole montagnardo di mezza mattina, sole pesante sulle spalle. Il borsello, come usava allora, era un orpello greve, antipatico, per fortuna ero allenato alla montagna: la mia piccola casa sopra San Pellegrino in Val Brembana era un rifugio sicuro, tranquillo, si udivano soltanto i gridi gioiosi di mio figlio, che giocava con l’amico Tullio, rampollo di montanari. Andava a scuola ma, soprattutto, lavorava sui campi ripidi dov’era nato, tagliava l’erba, la portava alla stalla dove io, la sera, andavo col pentolino a prendere il latte appena munto. Era un bimbetto Tullio, ma già sconciato dal lavoro; quando vedeva una nuvola in cielo si fermava e cominciava a pregare: “goccina santa, goccina santa, vieni goccina santa” ché, se pioveva, era la benedizione di Dio e della Madonna e Tullio smetteva di lavorare. Quella era montagna dura, i campi venivano tosati per dare cibo da ruminare alle bestie, ma anche per impedire che d’inverno persone e case venissero investite e travolte dalle slavine. Venivano giù a velocità incredibile, le slavine, sporche di terra, di rami, di tutto quello che trovavano sulla loro rapida discesa.
La montagna una volta era un luogo di tragedia greca; di fianco a casa mia c’era stato un grande ciliegio al quale i genitori del vecchio Giuseppe, parente di Tullio, attaccavano la corda doppia per portare su e giù dall’alto della collina il fieno, gli strumenti e perfino anche il fratellino di Giuseppe nella sua culla, un bimbo appena nato che la madre si portava al lavoro e, di tanto in tanto, gli dava la tetta. Ma quel giorno maledetto improvvisamente nella rudimentale teleferica si ruppe la corda e il cassonetto della funivia, a velocità vertiginosa, piombò a valle fracassandosi contro il ciliegio. Il fratellino di Giuseppe morì sul colpo: il padre prese la mannaia, tagliò il ciliegio, ne fece assi, con cui costruì una piccola cassapanca per Giuseppe che andava soldato: Giuseppe mi regalò quella bara, dipinta di rosso sangue, e ora il bauletto è a Roma in casa di mio figlio. Strani viaggi fanno le cose.
Salivo, dunque, la collina sempre in direzione dell’albero ricco che vedevo ormai poco più in alto. Intorno non c’era anima viva. Modi di dire, non c’era anima viva, ma quel giorno di caldo precoce e soffocante, era realtà. Quando fui sotto l’ombra protettrice delle fronde coperte di marasche, mi accorsi che ai miei piedi giaceva nell’erba un fagottone, che non era un fagottone, era una giovane donna. Guardai meglio: morta. Una delle tre vittime di quella assurda, feroce battaglia tra carabinieri e fuorilegge (5 giugno 1975). Avevano sequestrato l’industriale Vallarino Gancia e l’avevano portato lassù a Cascina Spiotta. Lo sapevano tutti, ma quegli improvvisati e sciocchi banditi no, non avevano capito che in quei meravigliosi luoghi, dove il lavoro è il lavoro, è fatica, è rinuncia, ma anche possesso e proprietà, tutti sanno tutto di tutti e le voci giravano: “le Br hanno portato a Cascina Spiotta il Gancia e lo tengono prigioniero”. Le voci erano salite fino alle orecchie degli inquirenti: “Si – mi disse il giorno dopo la sparatoria il procuratore capo di Acqui – sapevamo ed è per questo che ho chiesto al generale Dalla Chiesa di mandare su a circondare la casa un piccolo esercito. Ha invece inviato tre uomini…le pare possibile?” chiese a me. Forse lo scontro a fuoco doveva esserci, azzardai. Il suo silenzio fu una risposta eloquente.
E ora questa ragazza con la quale cominciai a dialogare, poverina, mi addolorava vederla lì perduta per sempre alla vita in un silenzio che soltanto di tanto in tanto il vento riusciva a rompere facendo frusciare le foglie e l’erba alta del prato e portando alle mie orecchie voci sconosciute provenienti dalla cascina; poi così com’erano arrivati i rumori cessavano e rimaneva quell’assurdo silenzio dell’estate. Guardavo di tanto in tanto quella ragazza così immobile, soltanto una ciocca di capelli, neri mi pare, si alzava sul capo, mossa da un refolo di vento, pareva voler sottrarsi alla morte. Non farai più l’amore, pensai a voce alta, come se lei potesse sentirmi e quelle parole mi pesarono sul cuore: com’è possibile, chiesi sempre a voce alta morire ammazzati così giovani? Poi, quasi per provocare quel povero essere domandai: si fa così la rivoluzione? Ammazzare e farsi ammazzare una mattina calda e assolata di giugno? La terrorista non si mosse. Ma la sua presenza, sia pure immota, mi spingeva a imbastire un dialogo assurdo: immaginavo la sua inutile fuga dalla cascina, a balzi giù per la collina, gli altri suoi compagni già sparsi sul prato, salvi per il momento, li sentiva sparare mentre scappavano e poi, improvvisamente più nulla, la terra l’attirò per sempre fino a che le radici del ciliegio non fermarono il suo ruzzolare e lei rimase lì a braccia aperte come a chiamare il cielo su di sé. No, le dissi ancora, questa non è rivoluzione. Ai tuoi nemici, quelli che tu avevi indicato come tuoi nemici, a loro tu servivi morta. Strappai dall’albero un mazzetto di ciliegie: ho sete, mi scusai con la morta. Intanto guardavo questo pacifico panorama, la pena che mi aveva riempito il cervello non accennava a diminuire e stavo lì imbambolato quando mi raggiunse un collega trafelato: “l’hanno identificata, è Mara Cagol, la moglie di Curcio”. Mara, le ripetei ora che conoscevo il nome, non si fa così la rivoluzione, tu sei morta per che cosa?
Per quel senso di giustizia sociale che il potere calpesta, al giorno d’oggi – vorrei dirle adesso – il terrorismo giunge da lontano, colpisce dove gli pare, taglia le teste innocenti, indifese e indifendibili. Mara, pensai, sei morta quando ancora la ribellione alle ingiustizie, alle torture dei poteri forti, alle prevaricazioni delle multinazionali aveva contorni romantici, ora viviamo dentro un film dell’orrore. Pensavi di fare la rivoluzione mentre un tuo compagno ti tradiva? A Milano, il giorno dopo, sui muri della città comparve una scritta: “Mara è viva e lotta insieme a noi”. Mara era morta.