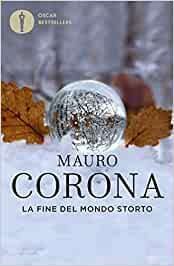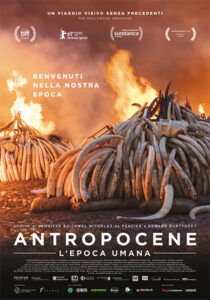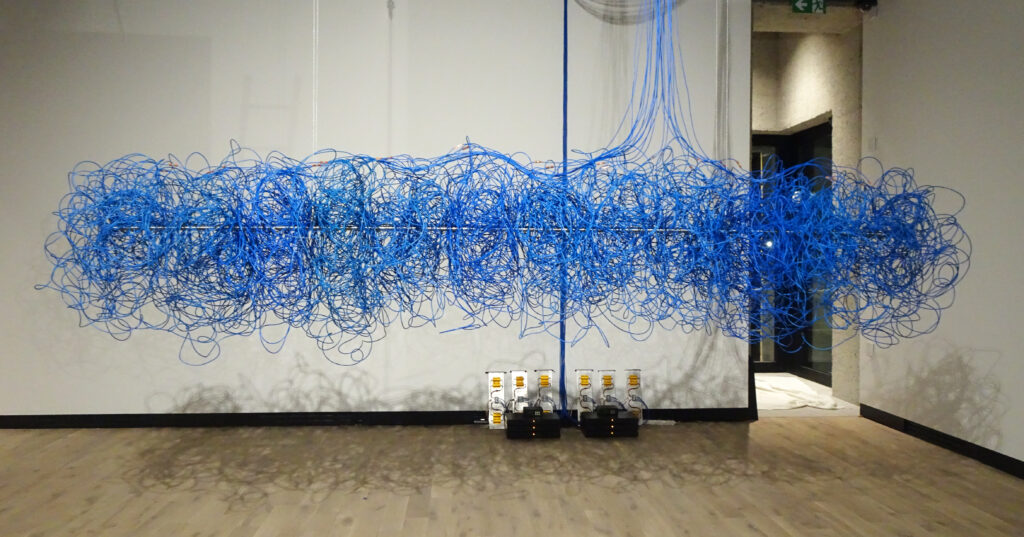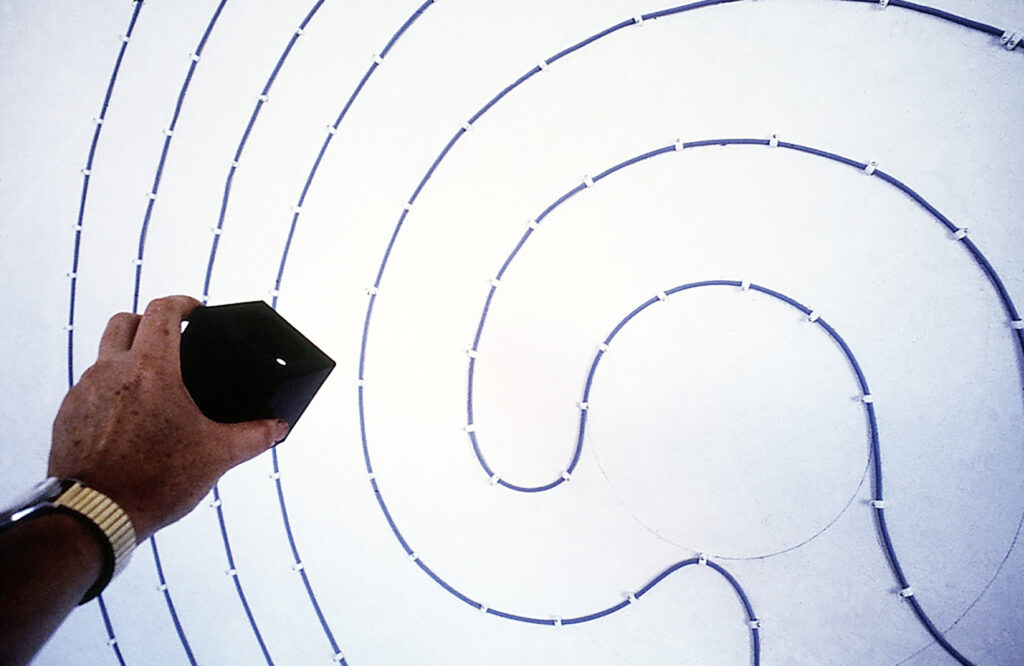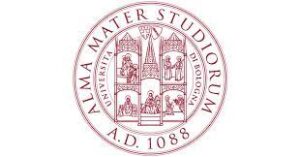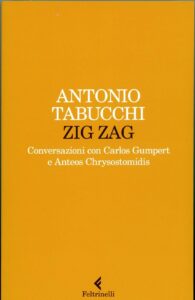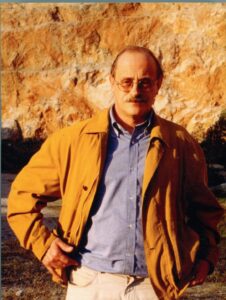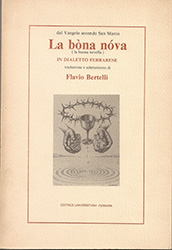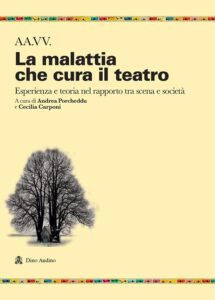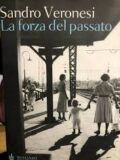Abbiamo ricevuto come Europa per la Pace questa lettera da un italiano che vive in Ucraina e volentieri la pubblichiamo. E’ ricca di dettagli e informazioni sulla vita quotidiana nelle zone non colpite direttamente dalla guerra ed emergono realtà sconcertanti. L’autore ha chiesto di rimanere anonimo perché teme per la sua vita.
L’operazione speciale russa in terra Ucraina ha un sapore diverso in questa zona produttiva nel centro del paese. I contadini delle vastissime aree produttive centrali dell’Ucraina, così come i lavoratori delle imponenti nuove costruzioni nei sobborghi della città di Vinnytsia, vedono la guerra da lontano, quasi non li toccasse, sui siti internet o in TV sull’unico canale governativo ammesso dal governo Zelensky.
Dall’inizio dell’invasione russa sul territorio ucraino, il 24 Febbraio scorso, coloro che vivono e lavorano a ovest dell’importante fiume Dnipro, sono stati solo sfiorati dalle armi della guerra in corso. Dai missili sovietici sono stati colpiti esclusivamente basi militari, siti per l’energia, raffinerie, aeroporti usati dai militari, e caserme dedicate a soldati non solo ucraini. Non si sono viste le distruzioni tragiche di Kharkiv, Luhansk e Mariupol. Quasi fosse un altro paese.
Sarà anche per questo motivo che moltissime famiglie si sono riversate in questa zona, venendo dal sud, dall’est e da Kiev. Alcune hanno preso in affitto qualunque abitazione disponibile in questa vasta area, fosse anche una casa semi distrutta in un paesino sperduto sulla mappa dei campi di grano ucraini. Non tutti coloro che sfuggono dalla guerra vanno oltre confine, in Europa. Sono centinaia di migliaia quelli che hanno scelto la parte centrale del paese quale rifugio sicuro.
Non sapevano però queste famiglie che, mentre i loro connazionali fuggiti in Europa avrebbero trovato aiuti e sostegno morale sincero, la loro sorte era di poco o nessun interesse né agli amici europei, ma anche meno al proprio governo di Kiev.
Di fatto, le famiglie nelle zone rurali a ovest del fiume Dnipro sono state dimenticate da tutti.
Ne fanno spesa e soffrono soprattutto anziani, giovani e malati.
Mentre gas, acqua, elettricità (ed internet) non mancano se non sporadicamente, tutto il resto è quasi impossibile da trovare. Nelle grandi città i generi alimentari scarseggiano, pur non mancando. Ma nelle piccole città, nei paesini e nelle frazioni contadine di questa vasta area manca praticamente tutto. Non fosse per la presenza di contadini e della loro produzione (limitata) di alcuni beni alimentari, alcune zone dell’Ucraina centrale sarebbero rimaste senza cibo. Molti negozi hanno chiuso già un mese fa. Altri restano aperti solo per mezza giornata o per dare sostegno morale agli anziani che vengono quotidianamente a chiedere aiuto.
Aiuti dal governo, zero.
A tutto ciò si aggiunge l’assenza di carburanti ad uso civile. In alcune zone manca completamente, impedendo così l’uso dei trattori, e danni immensi ai piccoli contadini e produttori di grano. In piccole città quali Teplik, Haisyn, Shepetivka e altre, il carburante viene razionato e alle pompe di benzina la fila di auto in attesa inizia al cantar del gallo, e anche prima. Quasi tutte le pompe di benzina di questa area chiudono alle 12 per mancanza di prodotto, ed alcune, specialmente quelle in piccoli paesini, aprono tre volte a settimana. I mezzi pubblici sono limitati a pochi bus al giorno. In piccoli paesini che erano collegati prima della guerra, ora sono del tutto isolati. Molte strade sono impercorribili per l’assenza totale di manutenzione.
Aiuti dal governo, zero.
La sanità è allo stremo. Le farmacie, pur aperte, non hanno molto da offrire. Molte hanno scaffali vuoti, specialmente per prodotti dedicati alla maternità o per gli anziani. Gli ospedali sono allo stremo, e molti hanno chiuso interi reparti per mancanza di medicine e personale competente (senza carburante molti non possono prendere i mezzi di trasporto a lavoro). Le future mamme non sanno dove andare a partorire, poiché molti ospedali hanno delegato tutto ad un unico edificio in Vinnytsia. In caso di emergenze, non ci sono speranze per chi si trova lontano dalla città principale in zona. Alle madri partorienti il consiglio è di prepararsi ad un parto in casa fai da te.
Aiuti dal governo, zero.
Non stupisce quindi che in questa zona molto vasta e rurale, la maggioranza dei cittadini è fortemente contraria alle scelte politiche del governo ucraino. Quasi la totalità delle persone che parlano a porte chiuse ed in privato di quanto sta accadendo incolpa le scelte del presidente Zelensky ed il suo governo filoamericano per non aver evitato la guerra e negoziato con Putin prima della escalation militare. Potrei affermare che tutti sanno o comprendono che questo conflitto è in atto per colpa di scelte politiche fatte oltre oceano e dalla NATO.
Soprattutto fra famiglie che sono fuggite dall’est del paese, e che hanno perso tutto, esiste un astio fortissimo nei confronti di Zelensky e della NATO. Talvolta, ma sempre più spesso, sembra quasi siano filorusse, pur non essendo tali.
Per la mancanza di carburanti e per problemi di materie prime, per tante famiglie non c’è lavoro. Molti uffici sono chiusi. Impossibile trovare notai e avvocati. Le fabbriche hanno chiuso. Se, quindi, per i contadini il problema del cibo viene risolto con gli animali a disposizione, per le famiglie delle piccole città e villaggi rurali la fame è alle porte. Si avvicina la fine dei generi alimentari ogni settimana che passa.
Aiuti dal governo, zero.
I ragazzi in età scolastica sono a casa da fine Febbraio. Le scuole sono chiuse. Sono le famiglie a prendersi il carico dei figli che restano tutto il giorno in casa. Se è vero che esistono corsi online organizzati da molte scuole, è altresì vero che la maggioranza delle famiglie non ha un collegamento internet adatto. È noto che classi di 20 studenti a scuola vengono ora organizzate su piattaforme internet dove però si collegano in appena 5. Gli altri assenti per vari motivi, fra cui l’impossibilità tecnica al collegamento, dovranno vedersela con il futuro.
La presenza dei giovani a casa obbliga alcune famiglie a dedicare loro il tempo che potrebbero dedicare al lavoro saltuario.
Aiuti dal governo, zero.
Quando i militari hanno chiesto di precettare tutti gli uomini di età superiore ai 18 anni, la maggioranza delle famiglie, soprattutto rurali, si è ribellata. A metà marzo i militari sono entrati in forze nelle case per il precetto. Ci sono state anche lotte e qualche ferito. Si è saputo anche di alcuni morti. Molti uomini non intendevano andare a lottare per una guerra che veniva loro imposta su basi errate.
In alcuni paesini, gli uomini e ragazzi giovani, avvisati dell’arrivo dei militari che precettavano, sono fuggiti nei boschi per qualche giorno. I contadini si sono rifiutati lasciare le loro terre ed hanno risolto proponendo una specie di guardia locale notturna, respingendo così le richieste di precettazione.
Altri paesini non sono stati così fortunati. Alcuni paesini a nord hanno subito la visita di paramilitari che non hanno sentito scuse e con la forza hanno portato via i figli maggiorenni, non senza molestie e violenza inaccettabile.
Siccome poi questo paese stupendo è vittima di una corruzione endemica quasi indistruttibile (però è pronta ad entrare nella UE), spesso le famiglie hanno trovato chi, sotto ricompensa in denaro, ha tralasciato l’obbligo di precettazione militare in ufficio.
In molti maledicono per la morte del figlio o marito ad est o a nord, il governo ucraino. Quando in TV appare il presidente, parole che qui non si possono trascrivere vengono a lui indirizzate. C’è da essere anche pragmatici: la morte del marito o figlio per una famiglia vuol dire la fine di un introito finanziario in famiglia.
Aiuti dal governo, zero.
Vi sono poi racconti che destano ilarità. Come, per esempio, quello degli uomini precettati nei pressi di Haisyn, alcuni anche volontari, e trasportati di notte nelle caserme locali. Dopo una buona dormita in caserma, la metà è stata spedita a casa perché mancavano fucili e armi a sufficienza. L’altra metà è rimasta per istruzioni e allenamento. Di quest’ultima, pochissimi hanno resistito al test, mentre la maggioranza è rientrata in serata a casa perché “inutile allo scopo militare”. Si dice che avessero bevuto la vodka locale più del dovuto.
Ma ci sono racconti strazianti per quanto concerne gli anziani. C’è un numero sempre crescente di anziani deceduti in casa perché privi di assistenza sociale e medica in questo periodo. Sono spenti i numeri di assistenza e soccorso in questa zona. Risulta quasi impossibile chiamare una autoambulanza in zone fuori città (sempre per la mancanza di carburanti e personale). Vi sono casi crescenti di anziani affamati che stanziano davanti alle proprie abitazioni chiedendo aiuto o cibo.
Aiuti dal governo, zero.
Quindi, anche se la guerra in corso sembra un lontano avvenimento visto sui media, la popolazione ucraina ad ovest del fiume Dnipro ne soffre le conseguenze e molte famiglie sono in sofferenza, in fame e povertà. Molti paesini, molti contadini, tante famiglie, sono allo stremo.
E mentre uno si aspetterebbe che i miliardi di dollari americani o i miliardi di euro stanziati dalla UE, servissero anche alle famiglie che di fatto vivono ancora in Ucraina, la realtà è che di questi soldi, queste famiglie, questi lavoratori, questi contadini, queste farmacie, queste scuole, questi ospedali, ne hanno visto i numeri in televisione.
Aiuti dal governo, zero.
La beffa in tutto ciò è che il governo ed i militari, chiedono incessantemente aiuti finanziari a tutti ed in tutti i modi, anche violenti. Sulle bollette del gas ed elettricità. Quando si paga il gestore internet online. Quando si fa un prelievo bancomat. Quando ci si collega ad internet. E, purtroppo, passando di casa in casa di messi della caserma locale, che spesso poi segnalano all’ufficio locale chi ha donato fondi per i militari e chi non lo ha fatto. Il resto è noto.
Il governo di Kiev non ha aiutato affatto gli abitanti rimasti in Ucraina. Non ha alzato un dito in loro aiuto, nonostante le presunte dotazioni economiche dei paesi alleati.
Quanto sopra, se non altro, dimostra quanta ipocrisia vi sia non solo in Europa, ma anche in questo paese martoriato e mal governato, non in nome di una pace e di una politica estera atta alla pace, ma in nome di forze politiche, economiche e militari estere (per nominarne due, gli Stati Uniti d’America e la NATO).
Questa cronaca è stata fatta da chi si trova in questi luoghi, vivendo di persona avvenimenti e fatti, e verificando quanto raccontato a mezzo collegamenti personali e conoscenze in uffici menzionati.