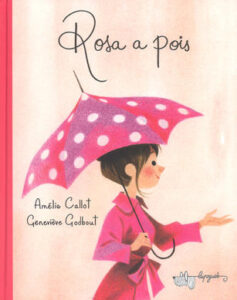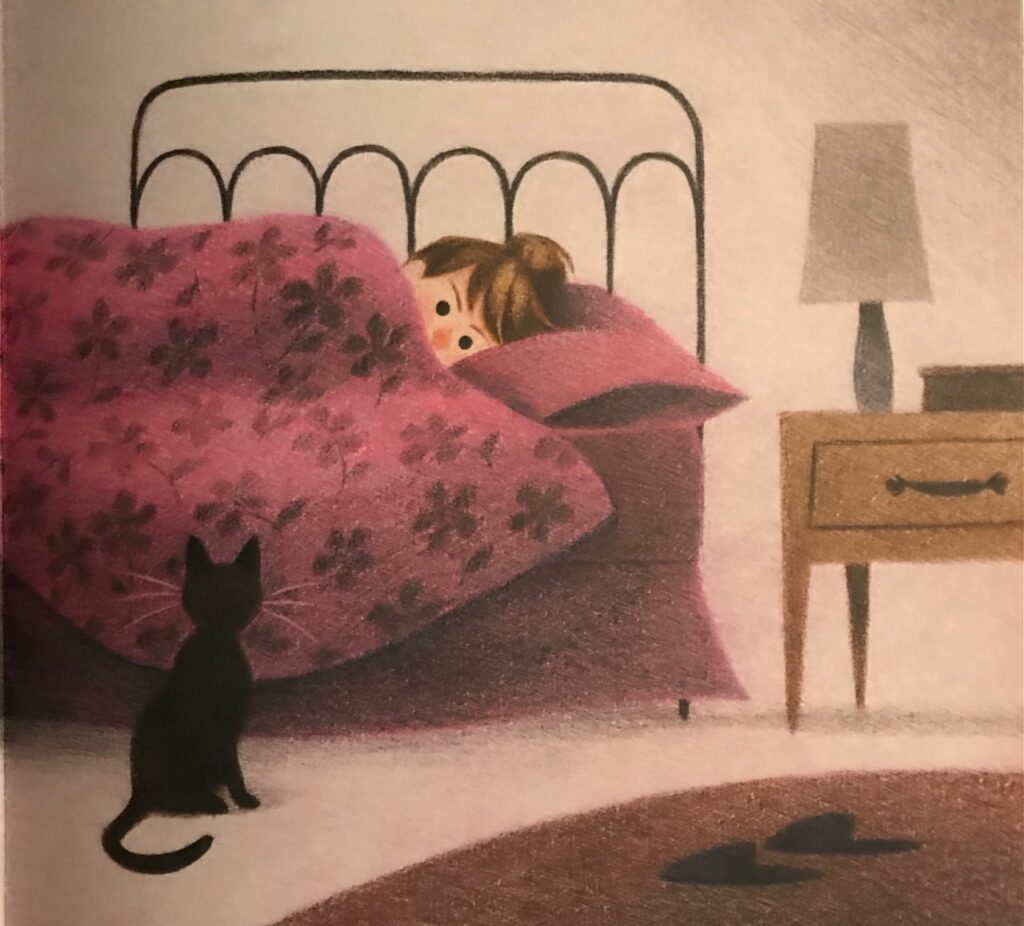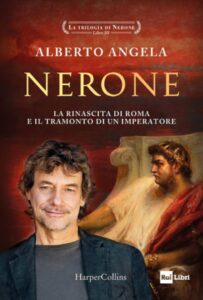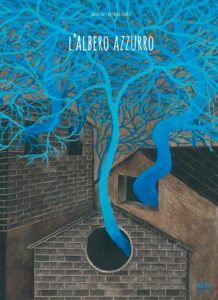Benedikt, il pastore d’Islanda
Benedikt aveva un modo tutto suo di vivere il Natale. Cominciava a prepararsi la prima domenica di Avvento mettendosi in cammino verso i monti. L’obiettivo era di ritrovare le pecore smarrite, quelle che erano sfuggite in autunno ai raduni dei pastori. Pecore perdute nel gelido e buio inverno islandese: «La vita, diceva, è un servizio imperfetto sostenuto dall’attesa, dalla speranza e dalla preparazione».
Nessuno osava andare con lui eccetto due fedelissimi amici: il suo cane Leó e il montone Roccia. A volte lo cercavano anche i mandriani di cavalli quando ne perdevano qualcuno tra i monti. Lo seguivano nella tormenta, certi che, con la sua guida, li avrebbero ritrovati. Stavano con lui per un tratto, finché, ritrovati gli animali se ne tornavano; ma lui proseguiva salendo più in alto oltre le colline innevate verso il suo scopo: ritrovare le pecore smarrite.
Lungo quel tortuoso cammino verso l’imprevedibile come verso l’ignoto, sostava nelle gelide notti prima in una baita di contadini alle pendici dell’altipiano, poi a mezza via in un rifugio che era anche un bivacco di pastori con una stalla per gli armenti ritrovati; e infine lassù dove nessuno osava, appena un buco, giusto una rientranza nella roccia, come una grotta per un pastore, il suo cane Leó e il montone Roccia.
In paese, quei tre, che si avventuravano in una regione diventata a dir poco inospitale e proibitiva, erano chiamati la “santa trinità”. Erano come un mondo, un sodalizio di amici, una benedizione anche, che entrava benefica in un altro mondo fatto di tormente di vento, spilli di ghiaccio e di neve che accecavano. Alleandosi poi con il vento la neve inghiottiva e annullava ogni punto di riferimento, ogni certezza esteriore ed interiore, cancellando ogni traccia di sentiero e finanche la speranza.
Un mondo fatto di vite sgretolate da riunire, esistenze perdute da ritrovare, con il rischio di perdere sé stessi in quel mescolarsi e rimescolarsi, sprofondare e riemergere, nel continuo scomparire ricomparire di orizzonti capovolti del cielo e della terra.
Erano stranieri in terra straniera; e tuttavia, non senza la compagnia di una fragile eppur indomabile speranza in una provvidenza, nascostamente presente, che custodendo i loro sogni, calcava le loro orme facendo silenziosamente strada con loro. Yhwh, Benedetto egli sia, non aveva forse detto all’amico Abramo che sognava una discendenza come le stelle del cielo: «Cammina davanti a me?» (Gn 17,1).
 La storia del pastore d’Islanda inizia così: «Se il tempo lo permetteva, la prima domenica d’Avvento, si metteva in viaggio. Riempiva una bisaccia di provviste, calzettoni di ricambio, varie paia di scarpe di cuoio nuove e un fornelletto da campo; prendeva con sé una latta di petrolio e una bottiglietta d’alcol e se ne andava tra le montagne, che in quel periodo dell’anno erano popolate solo dagli uccelli predatori più resistenti, dalle volpi e da qualche pecora sperduta.
La storia del pastore d’Islanda inizia così: «Se il tempo lo permetteva, la prima domenica d’Avvento, si metteva in viaggio. Riempiva una bisaccia di provviste, calzettoni di ricambio, varie paia di scarpe di cuoio nuove e un fornelletto da campo; prendeva con sé una latta di petrolio e una bottiglietta d’alcol e se ne andava tra le montagne, che in quel periodo dell’anno erano popolate solo dagli uccelli predatori più resistenti, dalle volpi e da qualche pecora sperduta.
Proprio di queste Benedikt andava in cerca, bestie sfuggite ai tre raduni regolari dell’autunno. Dovevano morire di freddo e di fame solo perché nessuno aveva la voglia o il coraggio di cercarle e riportarle a casa? Erano pur sempre esseri viventi. E Benedikt aveva una specie di responsabilità nei loro riguardi.
Il suo scopo era semplice: trovarle e ricondurle a casa sane e salve, prima che la grande festa portasse la sua benedizione sulla terra, e pace e gioia nel cuore degli uomini di buona volontà… Avvento. Negli anni quella parola era arrivata a racchiudere tutta la sua vita. Perché cos’era la sua vita, la vita degli uomini sulla terra, se non un servizio imperfetto che tuttavia è sostenuto dall’attesa, dalla speranza, dalla preparazione?» (Gunnar Gunnarsson, Il pastore d’Islanda, Iperborea, Milano 2020, 8; 10).
Benedikt lavorava in una fattoria d’estate e d’inverno. Badava al gregge in cambio di vitto e alloggio. Aveva iniziato quei viaggi in montagna, quei pellegrinaggi d’Avvento a ventisette anni e aveva già attraversato la regione montuosa per ventisette volte.
I suoi sogni erano sepolti in quegli anni. Ma quali sogni? «Quelli che solo lui e Dio conoscevano. E le montagne, a cui li aveva urlati nella sua disperazione. Ma già al primo viaggio li aveva lasciati lassù. Ben nascosti. O forse no? Non comparivano a volte nella solitudine dei monti, come spiriti inquieti che vivono la loro vita effimera e distorta in un deserto di neve e pietre sgretolate? Era a causa loro che doveva tornare lì ogni inverno? Per vedere se ancora non s’erano dissolti e la terra non li aveva inghiottiti?» (ivi, 12-13).
Il loro cammino in salita, faticoso e rallentato dalla neve era ritmato di filastrocche, salmi e canzoni, e Benedikt aveva la sua:
Landa petrosa, neve e tempesta
Fanno piede sicuro e gamba lesta
Chi al riparo sempre resta
La sua vita perderà.
Piano piano, con prudenza,
lentamente e senza affanno.
Dopo la notte il giorno verrà
Quando lampeggia poi tuonerà.
(ivi 21-22).
Essi «avanzavano lentamente, si muovevano con prudenza, come viene naturale dopo diciotto ore di cammino, anche se avrebbero cavalcato volentieri una folgore, sfidando il pericolo, pur di risparmiarsi l’ultimo tratto di strada» (ivi, 22).
L’unica certezza era che loro tre camminavano insieme, sostenendosi l’un l’altro, uniti nella notte e al chiaro di luna, tra le montagne silenziose. E avevano uno scopo. Uno scopo che tutti e tre conoscevano e a cui acconsentivano ad ogni passo e con un altro passo ancora. Umile, forse, ma pur sempre uno scopo. Far diventare i sogni realtà, farli crescere concreti nella vita: “ritrovare ciò che si era perduto”, portare alla vita ciò che stava per morire.
Spesso, a Benedikt le montagne tenevano il broncio. La neve cancellava ogni traccia, ma «la fortuna che lo aveva tradito il giorno prima, sotto un cielo sereno, tornò ad assisterlo nella bufera. Ne trovò due già di primo mattino, una terza verso sera e un altro paio nel viaggio di ritorno, per cui alla fine erano cinque in tutto.
Cercare pecore nella bufera era come gettare le reti in un mare torbido, ma quella volta la pesca diede i suoi frutti. Perché quando si conosce ogni dettaglio del terreno e i rifugi prediletti dagli animali, e per di più si ha un cane che è un vero papa, si trovano pecore anche alla cieca. Il che non toglie che fu una gran fatica, per Benedikt, Roccia e Leó, avere a che fare con quel gruppo di viandanti.
Le due coppie se ne stavano ognuna per conto suo, rifiutando ogni contatto con altre creature. E un momento partivano di corsa verso punti cardinali differenti, e il momento dopo non c’era più verso di smuoverle, se non a forza di urla e latrati, quando non si dovevano portare di peso attraverso i cumuli di neve. Era spossante» (ivi, 35).
Giunse il momento in cui, sopraffatto dalla fatica, senza più viveri per sé e per gli animali, decise di scendere a valle e chiedere aiuto. Era ormai la vigila di Natale; così, messe al sicuro le pecore smarrite nel recinto del rifugio con il poco foraggio rimasto, le affidò alla custodia di Leo e Roccia per dirigersi silenzioso e mesto verso l’ultima fattoria da cui era partito ai piedi delle montagne.
Egli non sapeva ancora e non immaginava che i suoi sogni avrebbero contagiato altri. Sì, proprio il giovane figlio dei contadini della fattoria di Botn con cui conversava volentieri − pure lui di nome faceva Benedikt – anche in lui si era acceso uno scopo: quello di incamminarsi in cerca di chi si era perduto e provare a ritrovarlo.
Così il vecchio Benedikt, giunto alla baita, avrebbe voluto chiedere al giovane Benedikt di accompagnarlo ancora tra quei monti appena fosse schiarito; ma non lo trovò, perché questi era già partito e lo aveva preceduto andando a carcare proprio lui, insieme alle sue pecore e dopo di lui anche altri si erano messi in cammino.
Il finale della storia del pastore d’Islanda ha il sapore di una parabola evangelica: quella di una festa che è ancora capace di far germogliare i nostri sogni nascosti o andare in cerca di quelli perduti. Che essa continui dipenderà da noi, dai lettori e da quanti, narrandola di nuovo, faranno nascere da essa storie nuove.
Scrivere è andare in cerca di parole smarrite e far rivivere le parole morte con lo scopo di ritrovare i sogni nascosti sulle montagne. Come sementi, sotto la neve essi sono pane. Scrivere allora, −così credo − è essere “pastori dentro”.
Benedikt «raggiunse Botn a tarda sera, accolto come uno che è resuscitato dai morti. Tuttavia non badò alle molte parole di benvenuto – dov’era il giovane Benedikt? Ma il giovane Benedikt non si trovava in casa. Era partito verso le altre fattorie senza spiegare perché. “Sì, volevo chiedergli di venire lassù con me, quando la luna tornerà a farsi vedere”.
No, il giovane Benedikt non era in casa. Il mattino dopo arrivò a Botn la notizia che aveva riunito qualche coetaneo ed era partito per la montagna. E prima di sera era rientrato con il gregge – e avevano messo le scarpe a Roccia, avevano fissato una calzatura di cuoio agli zoccoli che si era ferito a sangue camminando sempre davanti a tutti e spezzando la crosta di neve tagliente.
Fu un vero spettacolo assistere al momento in cui s’incontrarono sull’aia di Botn, il vecchio Benedikt e il suo Roccia. E il giovane Benedikt. “Grazie, tu che porti il mio nome”, disse il vecchio Benedikt, che non era tipo da aggiungere molto di più. Quel giorno alcuni contadini del circondario, che erano in ansia per la sorte del vecchio e ignari del suo ritorno, si erano dati appuntamento a Botn per salire in montagna a cercarlo – e a cercare anche il giovane, naturalmente.
Quest’ultimo era adesso davanti a loro, con le spalle dritte e lo sguardo fermo: “I ringraziamenti vanno a chi li merita”, rispose a chi portava il suo nome da prima di lui. E così finì il cammino dell’Avvento. Il compito era stato portato a termine e Benedikt era tornato tra gli uomini – ancora per un po’» (ivi, 39).
Una piccola appendice gesuana: «Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli» (Mt 18,12-14).
La costellazione del Pastore
E nella notte fasciata di stelle, tra poveri pastori, venne il Pastore di costellazioni
Nostra vicenda
No, in misura nessuna e modo alcuno
a noi è dato raggiungerti:
sei tu che devi scendere e perderti
tu, pastore di costellazioni.
Tua natura non è la divina Indifferenza,
anche se presunzione che altera la mente
e fede inquina e devia, è credere
che umana colpa per quanto orrenda
ti possa offendere.
Tua natura è di essere Amore
inesauribile fonte
di ogni amore:
Amore che te rovina
e noi redime
***
Io sento i tuoi passi inseguirmi
di deserto in deserto, passi
infaticati e discreti
per non impaurire:
Tu, divino Inquieto
che rompe gl’incanti
e distrugge le paci
e non concede tregue …
* * *
E come peccato non te ma noi
– solo noi! – ferisce a morte
e tua pietà scatena, così
non vi è contrizione che valga
– pure se a cuori che piangono
ancor di più con noi tu piangi
d’un pianto che lava la terra –
e solo grazia ci salva!
A noi chiedi appena
volontà d’essere salvati:
il miracolo
di lasciarci amare.
(D. M. Turoldo, Ultime poesie, Garzanti, Milano 1999, 52-53).
Quella del Pastore (di “Boote”=pastore, mandriano di buoi) è una costellazione detta circumpolare, perché resta sempre al di sopra dell’orizzonte in un dato luogo. È visibile tutto l’anno nel cielo del nord, ed è molto ricca di stelle doppie a cui deve la sua visibilità. È facilmente individuabile perché vicina al grande carro come tirato da buoi, l’Orsa Maggiore, che le sta in alto a destra.
La costellazione del Pastore, vicinissima alle tre stelle che stanno alla fine della stanga del grande carro, sembra afferralo, come a volerlo orientare verso la stella polare. Almeno così a me pare, guardando una mappa del cielo stellato. Ma allora il suo lo scopo non è forse quello di indicare il cammino alla ricerca dei sogni e indirizzarli verso un compimento?
«C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,8-9; 12-14).
Perché è apparso ai pastori per primi? Perché il loro sguardo è vicino alla terra, al gregge, dentro alla vita delle pecore; ma lo stesso sguardo è rivolto a scrutare il cielo e oltre, verso le costellazioni, e dunque verso i sogni dell’umanità, verso il suo futuro.
A loro il primo annuncio; loro per primi ad arrivare alla grotta, perché − ha ricordato papa Francesco − «ai pastori spetta il compito di alimentare i sogni della comunità, essi sono chiamati a far sognare altri… Pastori dentro alla vita delle persone, delle comunità, del Paese, dentro allo sguardo di chi è ferito ed escluso, di chi non smette di vedere il futuro da vivere con gli altri e per gli altri».
Così infatti si legge nel racconto di Luca: «E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro» (2, 18-20).
Scrive Giovanni in una mirabile pagina, al capitolo 10 del suo vangelo, che il buon pastore dà la vita per le pecore: «Il buon pastore dà la propria vita per le pecore, non è come il mercenario. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore». Ma il sogno di Dio sulla vita che vince la morte non è perduto perché «il Dio della pace ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù» (Eb 13,20).
Dio nelle scritture è detto “Signore dell’universo”, che traduce l’ebraico Sabaoth “degli eserciti”, ma va compreso nel senso di schiere e costellazioni celesti, prima che di schiere angeliche. Poi nella Genesi il termine lo si trova riferito ai cieli e ad ogni creatura; «quando furono portati a compimento i cieli e la terra e tutte le loro schiere», come a dire tutto il creato e l’intero universo.
Tornare pastori per ritornare a sognare la vita
Ma quando facevo il pastore
allora ero certo del tuo Natale.
I campi bianchi di brina,
i campi rotti al gracidio dei corvi
nel mio Friuli sotto la montagna,
erano il giusto spazio alla calata
delle genti favolose.
I tronchi degli alberi parevano
creature piene di ferite;
mia madre era parente
della Vergine,
tutta in faccende
finalmente serena.
Io portavo le pecore fino al sagrato
e sapevo d’essere uomo vero
del tuo regale presepio
(D.M. Turoldo, Natale, in O sensi miei, Rizzoli, Milano 1997, 230).
Un Natale in compagnia di Benedikt; non solo una poesia, ma pure una benedizione e una preghiera, perché non sia ogni giorno un’abitudine, ma una benedizione:
Insegnami, mio Dio, a benedire e a pregare
sul mistero d’una foglia che muore, sul fulgore d’un frutto maturo,
su questa libertà: vedere, percepire, respirare,
conoscere, aspettare, fallire.
Insegna alle mie labbra alleluia e benedizione
al rinnovarsi del tuo tempo con mattino e notte buia,
perché oggi il mio giorno non sia come ieri,
perché non soffra il mio giorno assuefazione.
(Lea Goldberg, Lampo all’alba. Poesie, Giuntina, Firenze 2022, 92).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]
 Luis sa che questo è possibile. Ama raccogliere cose semplici, foglie, piume, sassi a forma di cuore e fiori: li colleziona in barattoli di vetro e li conserva premurosamente. Tutto ciò che ha visto e vissuto spunta da quella sua colorata collezione.
Luis sa che questo è possibile. Ama raccogliere cose semplici, foglie, piume, sassi a forma di cuore e fiori: li colleziona in barattoli di vetro e li conserva premurosamente. Tutto ciò che ha visto e vissuto spunta da quella sua colorata collezione.