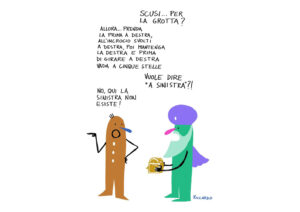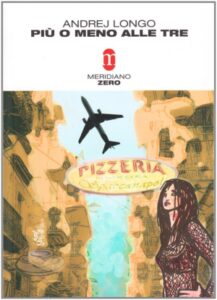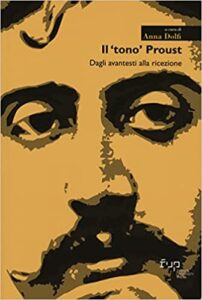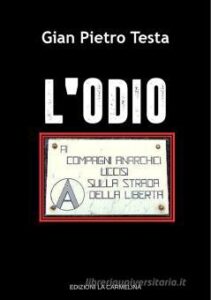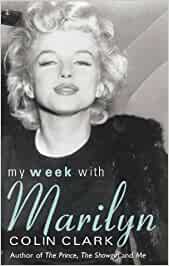Il Sarto di Gloucester
«Mia cara Freda,
siccome vai matta per le fiabe e sei stata ammalata, ho scritto una storia tutta per te, nuova nuova, che nessuno ha ancora letto. E la cosa più buffa è che l’ho sentita raccontare nel Gloucestershire, e che è assolutamente vera, almeno per quel che riguarda il sarto, il panciotto e il “Non ho più filo!”».
 Questa la dedica a Il sarto di Gloucester che era pure, tra le altre, la storia preferita da Helen Beatrix Potter (Londra, 1866 – Near Sawrey, 1943): scrittrice, illustratrice, naturalista britannica e famosa in Inghilterra per la sua attenzione all’ambiente non meno che per i suoi libri illustrati per bambini e i suoi acquarelli.
Questa la dedica a Il sarto di Gloucester che era pure, tra le altre, la storia preferita da Helen Beatrix Potter (Londra, 1866 – Near Sawrey, 1943): scrittrice, illustratrice, naturalista britannica e famosa in Inghilterra per la sua attenzione all’ambiente non meno che per i suoi libri illustrati per bambini e i suoi acquarelli.
Come indicato nella dedica la vicenda si basa su una storia realmente accaduta a un sarto che, lasciato il lavoro incompiuto, lo trovò finito il giorno successivo, completato dai suoi aiutanti nella sartoria. Mancava solo da completare un’asola perché … non c’era più filo.
Nella fiaba, ambientata la settimana prima di Natale, «al tempo delle spade, delle parrucche e delle mantelline a balze dai bordi ricamati, quando i gentiluomini portavano gale ai polsi e panciotti di seta e taffettà gallonati d’oro», un vecchio sarto molto povero e malaticcio, che aveva come amico un gatto sempre affamato di nome Simpkin doveva confezionare una giacca e un panciotto per il sindaco di Gloucester intenzionato a sposarsi proprio a Natale.
Gli rimanevano solo tre giorni e se riusciva in tempo nell’impresa la sua sorte e quella del suo Simpkin sarebbero cambiate in meglio. Scesa l’oscurità e con essa la luce che entrava dalla finestra si affrettò a chiudere la bottega, lasciando sul tavolo i pezzi di stoffa, di seta e di raso già tutti tagliati, modellati e pronti solo da cucire, insieme alle 21 asole da finire del panciotto con la fodera in taffettà giallo. Mancava solo una matassina di filo color ciliegia per finire il tutto.
Tornando a casa si sentì salire la febbre; ma prima di mettersi a letto diede al suo gatto gli ultimi quattro soldi che gli restavano per comprare un soldo di pane, uno di latte, uno di salsicce senza dimenticare con l’ultimo di comprare il filo color ciliegia.
Nel mettersi poi a letto udì degli strani rumori provenire dalle tazzine capovolte sulla credenza e sulla tavola – Tip tap, tip tap, tip tap tip! – si accorse così dei topolini imprigionati dal suo gatto per il pranzo di Natale; decise così di liberarli nonostante pensasse che avrebbe fatto un torto al suo amico.
Non sapeva ancora che quei simpatici topini, che nelle favole ascoltano e parlano come gli uomini, per gratitudine dei ritagli di stoffa «buoni solo per topi» che aveva lasciato in bottega e per l’insperata libertà sarebbero diventati i suoi aiutanti nella sartoria. E avrebbero finito per lui il lavoro.
Non ho più filo, non ho più speranza
«Giacque ammalato per tutto il giorno, e il giorno seguente, e l’altro ancora. Delirava e le sue parole ripetevano: “non ho più filo”. Che ne sarebbe stato della giacca color ciliegia? Nel negozio del sarto in Westgate Street i pezzi di seta ricamata e di satin giacevano sulla tavola – ventun asole! – e chi li avrebbe cuciti, se la finestra era sbarrata e la porta ben chiusa a chiave?
Ma questo non era un impedimento per i topolini bruni: correvano dentro e fuori da tutte le case di Gloucester senza bisogno di chiavi!… Rimase a letto ammalato per tre giorni e tre notti, ed ecco era la vigilia di Natale, e notte fonda. La luna era alta sopra i tetti e i camini e sbirciava oltre l’arco in College Court».
Quando Simpkin rientrò capì subito che qualcosa non andava. Le tazzine erano mute e quando il sarto domandò dove fosse il suo filo, lui tra sé e sé disse: “e dov’è il mio topo?”, così nascose il filo in una teiera e uscì in cerca del suo pranzo natalizio.
Tutto era buio fitto, ma «dal negozio del sarto in Westgate veniva un fascio di luce, e quando Simpkin si arrampicò fino alla finestra per guardar dentro, vide una quantità di candele accese. Era tutto un tagliar di forbici e un fruscio di fili.
Le voci dei topi cantavano forte, allegramente: “Tre topolini sedevano al fuso,/ Ma sotto la porta spuntò un brutto muso:/ Che state facendo, miei bravi signori?/ Cuciamo giacchette di dentro e di fuori. Posso aiutarvi a tagliar quei bei drappi?/ Oh, no, Signor Gatto, se entri ci pappi!» «Miao, miao!» faceva Simpkin. «Diddi rididdi?» lo motteggiavano i topi».
Non riuscì ad entrare, ma dalla finestra appena sollevata sentì, nel ticchettare dei ditali, i topi ripetere un ritornello: «Non ho più filo! Non ho più filo!». Si allontanò allora dalla bottega meditando sulla generosità di quei topi che stavano aiutando il suo amico, povero e affamato come lui, e per giunta ammalato.
Rientrato nella povera stanza trovò il vecchio sarto sfebbrato che dormiva; allora andò a prendere il prezioso dono nascosto nella teiera, guardò alla luce della luna quei fili di seta color ciliegia e pensò che lui, per il suo amico, non poteva proprio essere da meno di quei topi generosi e gioiosamente laboriosi. Così al mattino, appena sveglio, la prima cosa che vide il sarto fu proprio la matassa del filo mancante, accanto al letto.
Fili intrecciati: epifania della gioia
« – Povero me, mi sento uno straccio! – esclamò il sarto di Gloucester. – Però ho il mio filo -. Il sole splendeva sulla neve quando il sarto si levò e si vestì, e poi uscì in strada con Simpkin che gli correva davanti. – Ahimè -, esclamò il sarto, – ho il mio filo, ma non ho più la forza né il tempo per fare una sola asola; perché ormai è la mattina di Natale e il Sindaco di Gloucester si sposerà a mezzogiorno e dov’è la sua giacca color ciliegia? –.
Aprì la porta del suo negozio e Simpkin s’infilò dentro di corsa, come fanno i gatti quando hanno in mente qualcosa. Ma non c’era un solo topo bruno! I ripiani erano tutti perfettamente in ordine, senza più avanzi di filo e scampoli di seta, neppure sul pavimento.
Ma sulla tavola, – che gioia! – esclamò il sarto, lì dove aveva lasciato dei semplici ritagli di seta, giacevano la più splendida giacca e il più meraviglioso panciotto di satin ricamato che mai fossero stati indossati da un Sindaco di Gloucester.
Sul davanti della giacca c’erano rose e viole e il panciotto aveva ricami di papaveri e fiordalisi. Tutto era rifinito, tranne una sola asola color ciliegia, e dove quest’asola mancava era appuntato un pezzetto di carta con queste parole, tracciate in una scrittura minutissima e sottilissima: “non ho più filo”, qui cominciò la fortuna del Sarto di Gloucester: ritornò in buona salute e divenne ricco».
Epifania: vincolo di fraternità
Tre fili, intrecciati
Tre colori abbracciati
Tre magi incamminati
Tre fili intrecciati,
una coda di cometa
Tre colori abbracciati,
un sentiero per la vita
Tre magi incamminati,
una mèta per il tempo
Una cometa come guida
un viaggio nell’amore
un tesoro da cercare
Il filo giallo è l’oro,
una promessa di pace
che ci viene dal passato
Il filo amaranto è la mirra,
la fatica del vivere e del morire
ed è l’ora presente
Il verde è l’incenso
un profumo che sale,
verso il futuro del Vivente.
Tre fili un solo dono
Tre colori una sola vita
Tre Magi una sola via
Una luce illumina
Una parola consola
Un nome che dà gioia
Il figlio di Maria nato a Betlemme
Il figlio di Dio morto sulla croce
Il figlio amato fratello universale
Nessuno può salvarsi da solo
“Non ci si salva da soli”. Queste le parole che continua ancora oggi a ripetere papa Francesco, a partire da quella sera piovosa quando pregò sul mondo per affidarci a Dio, nella solitudine di una surreale piazza san Pietro deserta, silenziosa, senza un filo di speranza se non quella proveniente dal crocifisso lì accanto di San Marcello, che i romani portarono in processione nel 1552 contro la Grande peste.
“Una speranza contro ogni speranza” (Rm 4, 16) invocata da un papa ricurvo, solo, che salendo i gradini della piazza pregava dicendo: «“Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (come in Mc 4,38: i discepoli e la tempesta sul lago). Era il 27 marzo 2020, venerdì santo: l’inizio di una tempesta, e preludio delle ulteriori tempeste che seguirono, la guerra in Ucraina e le molte altre sparse nel mondo, e che indussero il papa a ripetere quelle stesse parole.
Così in questo mese, mese della pace, di nuovo il messaggio di Francesco ha come tema: «Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace». Senza un cammino di fraternità, la tessitura dell’umanità rischia di restare senza filo: “non ho più filo”, non c’è più pace.
Così si legge nel messaggio: «Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori.
Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il nostro mondo?
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo».
Così la via che porta da una vita minacciata ad una vita benedetta passa attraverso un “noi” aperto alla fraternità.
«… Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti direttamente coinvolte.
Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal peccato (È quello che esce dall’uomo che contamina l’uomo; perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono le guerre, cf Mc 7,17-23).
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà.
Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale.
Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune».
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]