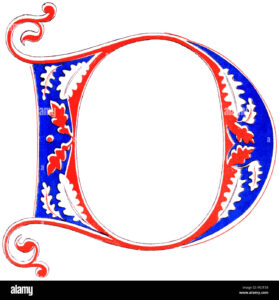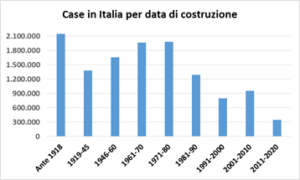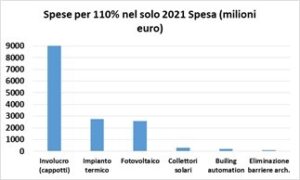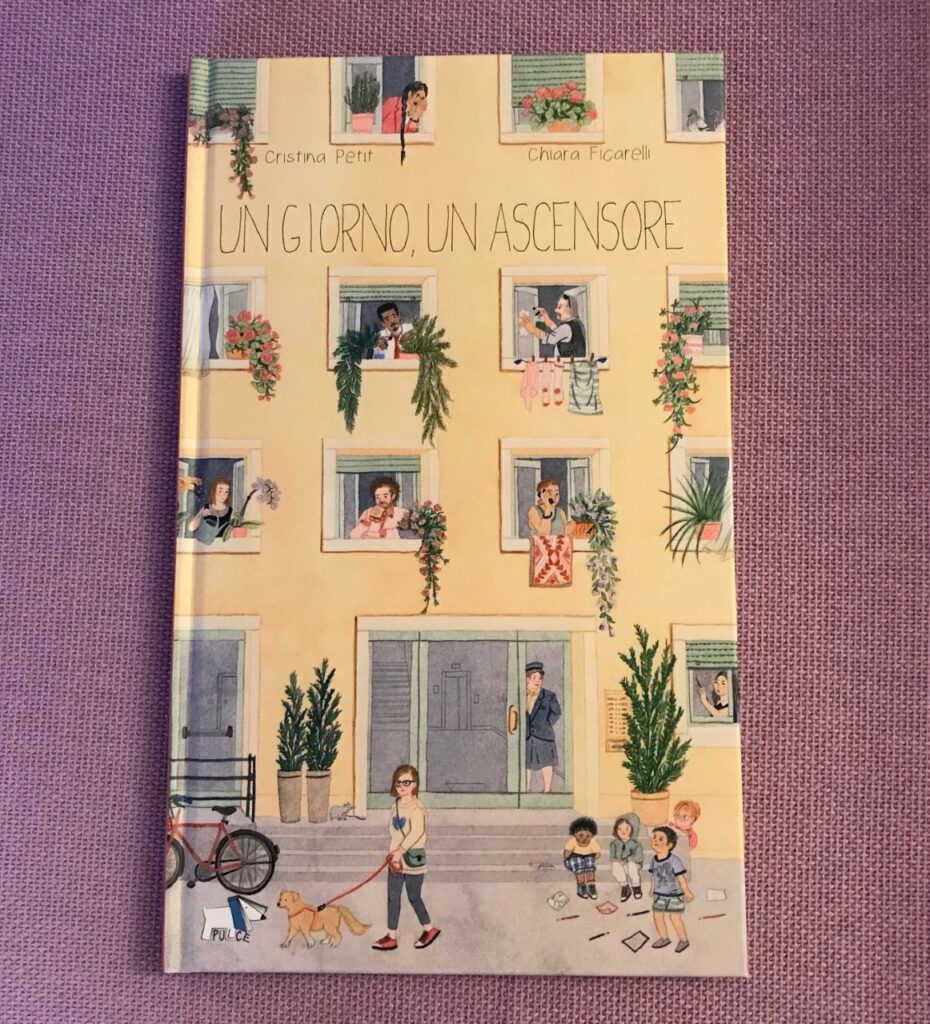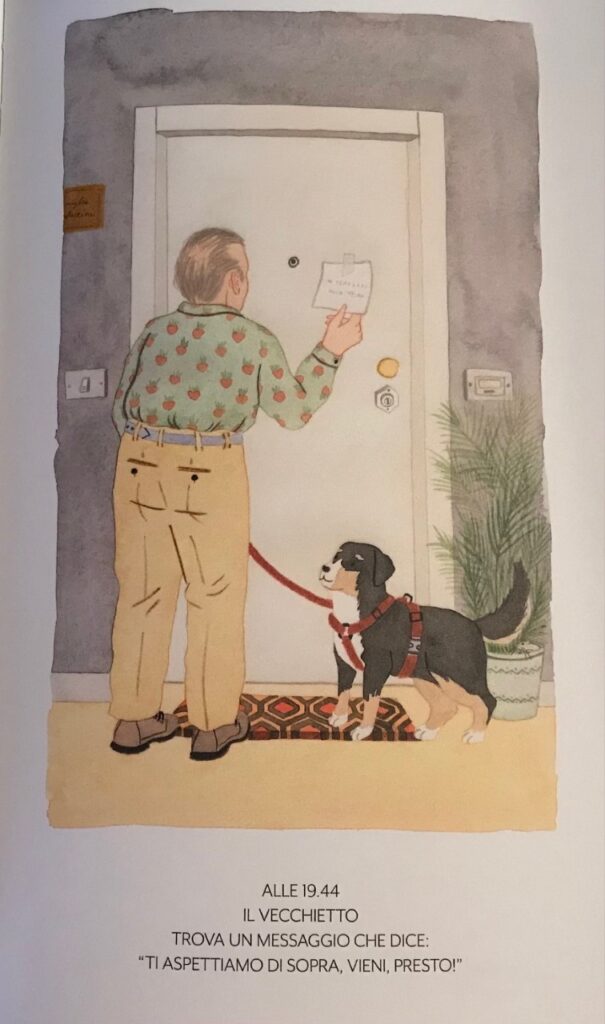Uno
Secondo l’ultimo comunicato di Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri ha «definito il percorso tecnico e politico per arrivare, in una delle prossime sedute del consiglio dei ministri, all’approvazione preliminare del disegno di legge sull’autonomia differenziata». In questo modo è stato messo sui binari il treno che porterà all’approvazione dell’insano progetto dell’autonomia differenziata sulla base della proposta di “legge di attuazione” dell’art. 116, 3 comma Costituzione presentata dal ministro Calderoli. Grazie all’attivismo del ministro leghista, il dibattito sull’autonomia differenziata è uscito fuori dalla clandestinità ed è diventato di pubblico dominio. Per questo è importante chiarire all’opinione pubblica in cosa consista l’autonomia differenziata e quali sono i pericoli che si prospettano.
La possibilità di concedere alle Regioni non a statuto speciale «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», la cosiddetta “autonomia differenziata” trova origine nella riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001. La riforma ampliò notevolmente l’autonomia legislativa delle Regioni. L’art. 117 definì (nel secondo comma) gli ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato e assegnò (nel terzo comma) alle Regioni la competenza concorrente in 23 materie, precisando che «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato». Gli effetti di questa riforma hanno determinato un contenzioso, che ha tenuta impegnata la Corte Costituzionale per oltre un ventennio, per tracciare i confini esatti fra la competenza delle Regioni e quella dello Stato per ciascuna materia. E tuttavia nella riforma c’è un criterio che rende modificabile il confine per le Regioni che siano interessate ad acquisire maggiori forme di autonomia, cioè più potere. L’art. 116, terzo comma, infatti, recita: «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate nel secondo comma del medesimo articolo alle lettere l, limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n ed s, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata». È bene precisare che si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo costituzionale, che non può essere avulsa dalla tela dei rapporti fra organi costituzionali e diritti dei cittadini come delineati nel testo costituzionale. Se le Regioni ottenessero la competenza piena in tutte le materie di competenza concorrente e nelle materie di competenza esclusiva dello Stato (norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali), verrebbe surrettiziamente ribaltata la norma che ha tracciato i confini fra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni, senza ricorrere al procedimento di revisione della Costituzione, di cui all’art. 138. Verrebbe pregiudicata anche l’eguaglianza dei cittadini, in aperto contrasto col principio fondamentale di cui all’art. 3. Per non parlare dell’istruzione dove la possibilità di attribuire alle Regioni la competenza sulle norme generali si scontra con la disposizione di cui all’art. 33, che statuisce: «La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione».
Due
Le disposizioni di cui al terzo comma di cui all’art. 116, sono compatibili con l’impianto costituzionale solo ove se ne dia un’interpretazione restrittiva. Vi sono materie che non possono essere parcellizzate per esigenze specifiche di un territorio: scuola, autostrade, ferrovie, salute, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di produzione e trasporto dell’energia, chiamano in causa un indivisibile interesse nazionale. Invece, le richieste delle Regioni capofila – Veneto, Lombardia e, in misura ridotta, Emilia Romagna – hanno di mira tutte e 23 le materie di competenza concorrente e persino le due o tre materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. In altre parole si è aperto un processo politico che mira ad utilizzare il “baco” inserito nell’art. 116 della Costituzione come una breccia per squarciare l’intero impianto costituzionale e ribaltare il principio fondamentale dell’unità della Repubblica, trasformando l’Italia in una serie di repubblichette semi-indipendenti. Non a caso la legge Calderoli è stata denominata “lo spacca Italia”. Si tratta di un progetto “sovversivo” dal punto di vista della legalità costituzionale e particolarmente insidioso per le sue modalità procedurali. Infatti l’autonomia differenziata, una volta concessa, sarà potenzialmente irreversibile. Questo perché il processo di determinazione dell’autonomia differenziata si fonda sulle intese stipulate fra il Governo e la Regione richiedente e, raggiunta l’intesa, il Parlamento non può modificarla, ma solo approvarla in blocco o rigettarla. Una volta deliberata, inoltre, la legge che approva le intese non può essere sottoposta a referendum abrogativo. Né l’intesa potrebbe essere modificata con una nuova legge perché occorrerebbe il consenso della Regione interessata, senza il quale l’intesa raggiunta è destinata a durare in eterno.
L’art. 117 della Costituzione, inoltre, precisa che spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Sono passati oltre venti anni e questa funzione non è stata mai esercitata per ragioni oggettive, visto che in Italia ci sono forti differenziazioni nella erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, per cui trovare un punto di equilibrio accettabile per tutti imporrebbe di mobilitare ingenti risorse che, in tempi di austerità, sarebbe stato difficile trovare. Ora, l’esigenza di procedere alla determinazione dei LEP è stata considerata un presupposto necessario per poter attribuire alle Regioni le risorse necessarie per l’esercizio delle nuove competenze trasferite dallo Stato. Per risolvere questo problema, che si trascina da vent’anni, il Ministro Calderoli ha innestato il turbo, facendo inserire nella legge di bilancio una decina di commi con i quali si prevede una procedura accelerata che, entro il dicembre del 2023, dovrebbe portare alla determinazione dei LEP, che avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Come si è visto, la Costituzione prevede che devono essere le assemblee elettive, con legge, a determinare quali prestazioni e quali livelli essenziali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Nel disegno Calderoli, inserito nella legge di bilancio, invece, è il Governo che stabilisce i diritti che devono essere garantiti ai cittadini e il loro ambito di applicazione. Quello che è ancora più assurdo è che si pretende di fare questa operazione a costo zero. Il risultato sarà che l’asticella dei diritti civili e sociali sarà necessariamente determinata a un livello piuttosto basso. In questo modo verranno cristallizzate le disuguaglianze che affliggono il nostro paese, soprattutto a svantaggio del Meridione e delle Isole. Questo perché lo stesso disegno di legge Calderoli, nella norma relativa al trasferimento delle funzioni e delle risorse (art. 4), stabilisce che «le risorse necessarie per le funzioni relative a ciascuna materia o ambito di materia sono determinate in base al criterio della spesa destinata a carattere permanente (cioè la spesa storica) sostenuta dallo Stato nella Regione per l’erogazione dei servizi pubblici corrispondenti». Secondo gli ultimi dati, la spesa pubblica pro capite è pari a poco meno di 19.000 euro in Lombardia, viaggia sui 16.000 in Veneto, mentre si ferma a poco più di 14.000 in Sicilia, in Calabria a 15.000, in Campania a 13.700 euro. La determinazione dei LEP a costo zero non inciderà su questa situazione di disuguaglianza, ma la consoliderà. Pertanto il finanziamento della maggiore autonomia prefigura un drenaggio di risorse a favore delle regioni economicamente più forti. In sintesi, la proposta di legge di attuazione presentata da Calderoli apre la via, da un lato, alla frammentazione del paese in repubblichette semi-indipendenti e, dall’altro, a un sicuro aumento delle diseguaglianze e dei divari territoriali, tra cui in specie quello strutturale Nord-Sud.
Se il processo di spostamento della competenza legislativa dallo Stato alle Regioni venisse portato a compimento, per tutto ciò che riguarda le scelte fondamentali inerenti il sistema produttivo e la vita civile nel nostro paese, come l’istruzione, i trasporti, le comunicazioni, le reti dell’energia, le condizioni di lavoro e dei lavoratori, l’ecologia, l’ambiente, la sanità, al posto di una disciplina legislativa ne dovremmo avere venti, ognuna con efficacia territoriale limitata. Al posto del contratto collettivo di lavoro, torneremo alle gabbie salariali. Di fronte a una nuova pandemia, avremo l’impossibilità di determinare delle regole di profilassi comuni. Non sarà possibile programmare una politica energetica per la transizione ecologica e la decarbonizzazione dell’economia. Venti mini Stati regionali faranno decollare la spesa pubblica legata al costo degli apparati amministrativi. Si tratta di una scelta insensata, inefficiente, costosa e caotica.
Tre
L’insieme delle considerazioni fin qui svolte ha indotto il Coordinamento per la democrazia costituzionale a presentare una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, sostenuta da circa 120 costituzionalisti, docenti universitari di varie discipline, studiosi, sindacalisti, esponenti della società civile, recante una modifica degli art. 116, comma 3, e 117.
La scelta di una legge di iniziativa popolare trova la sua ragione in una recente (2017) modifica del regolamento del Senato (art. 74) che assicura si giunga al dibattito in aula. Un riscontro si è avuto da ultimo con la legge costituzionale n. 2 del 7 novembre 2022, che ha introdotto nell’art. 119 il riconoscimento dell’insularità, iniziando il suo percorso in Senato come legge di iniziativa popolare sostenuta da 200.000 firme raccolte in Sicilia e Sardegna. Dunque, è oggi possibile creare un contesto in cui le forze politiche siano chiamate a prendere chiara e pubblica posizione sull’autonomia differenziata nella sede appropriata, dove un confronto sul tema non c’è finora mai stato, pur essendo il tema dal 2018 una priorità nell’agenda di tutti i governi. E sarebbe battuto il tentativo del ministro Calderoli di ulteriormente emarginare il Parlamento.
Nel merito, la proposta punta a correggere i punti deboli prima evidenziati nell’impianto degli articoli 116, comma 3, e 117, togliendo così il fondamento normativo alle scelte perseguite dal ministro Calderoli. Quanto all’art. 116, comma 3, viene cancellata la natura pattizia, causa della potenziale irreversibilità dell’autonomia una volta concessa, recuperando una opportuna flessibilità. Viene altresì sottolineata la connessione a specificità proprie del territorio, per evitare la bulimia di competenze che nulla hanno a che fare con la regione richiedente, e viene introdotta la possibilità di referendum nazionali sia approvativi nel momento della concessione dell’autonomia che successivamente abrogativi. Nell’art. 117 vengono spostate dalla potestà legislativa concorrente a quella statale esclusiva le materie strategiche per il sistema-paese, l’unità e l’eguaglianza nei diritti, dalla scuola e università alla tutela della salute e al Servizio sanitario nazionale, al coordinamento della finanza pubblica, al lavoro, alla previdenza, alle professioni, all’energia, alle grandi reti di trasporto e navigazione, ai porti e aeroporti di rilievo nazionale e interregionale. Inoltre, i livelli “essenziali” delle prestazioni vengono ridefiniti come livelli “uniformi”. Infine, si introduce una clausola di supremazia riferita all’unità giuridica ed economica della Repubblica e all’interesse nazionale.
Il treno dell’autonomia differenziata lanciato da Calderoli ormai è partito ma può essere ancora fermato. Bisogna far conoscere a cittadini/e cosa c’è in fondo a questo processo: se lo conosci, lo eviti. La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare può essere firmata con lo SPID sul sito www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it.
Domenico Gallo
Magistrato è presidente di sezione della Corte di cassazione. Da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo e del movimento per la pace, è stato senatore della Repubblica per una legislatura ed è componente del comitato esecutivo del Coordinamento per la democrazia costituzionale. Tra i suoi ultimi libri “Da sudditi a cittadini. Il percorso della democrazia” (Edizioni Gruppo Abele, 2013) e “Ventisei Madonne Nere” (Edizioni Delta tre, 2019).