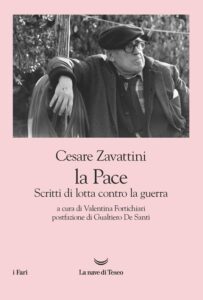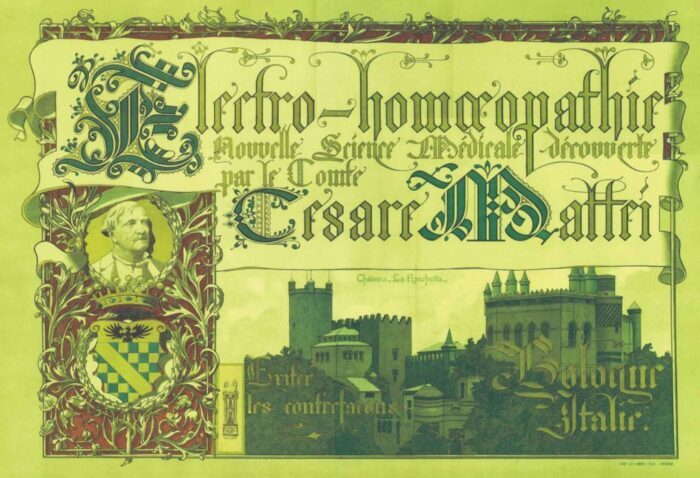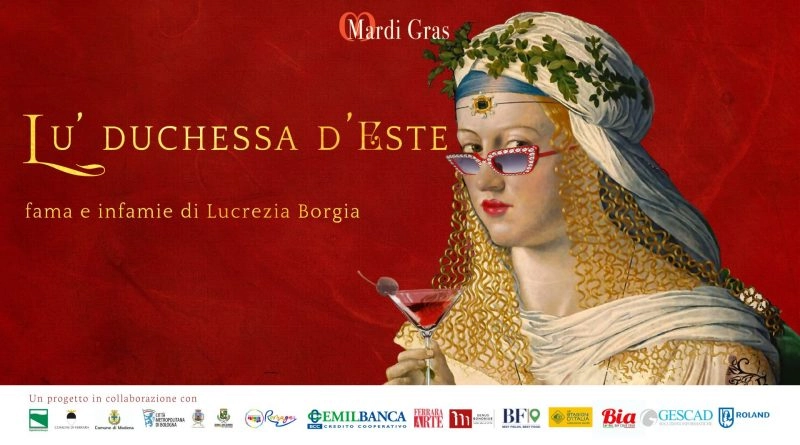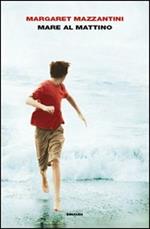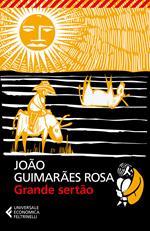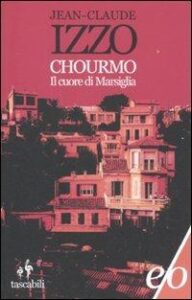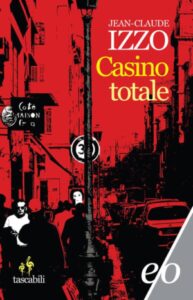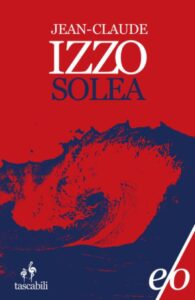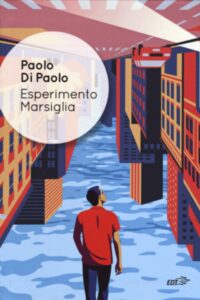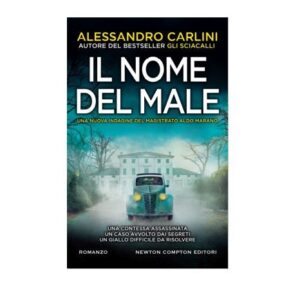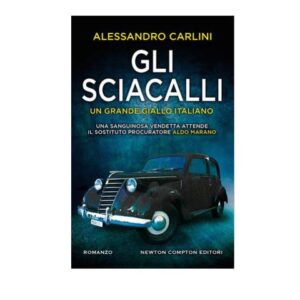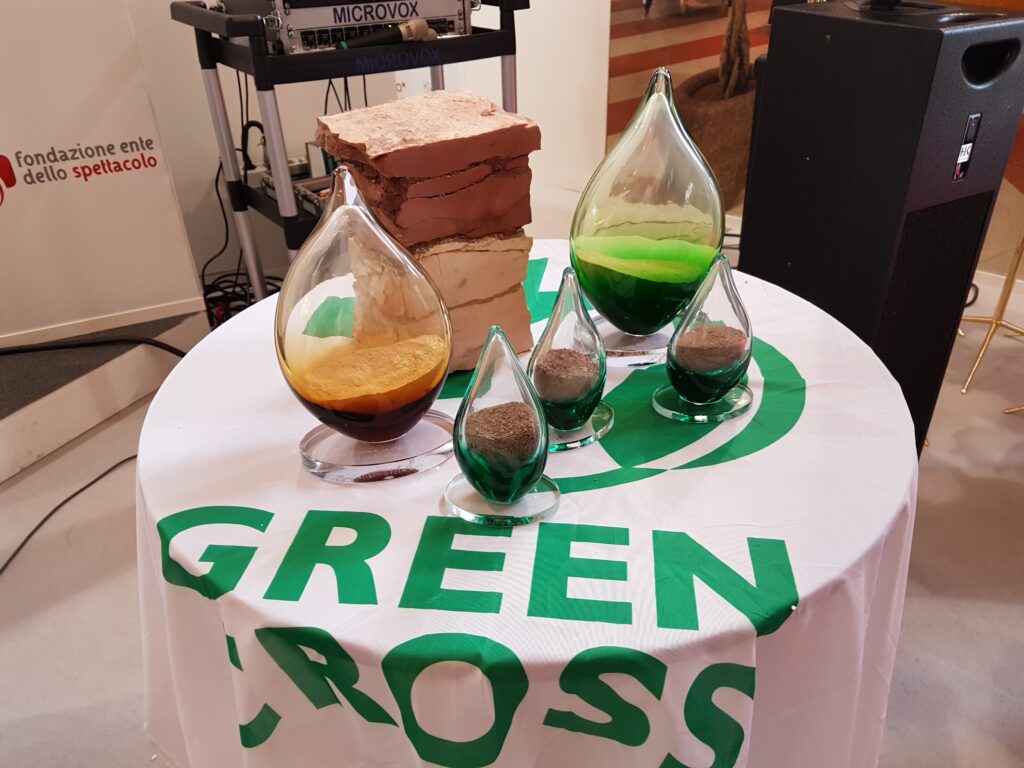Ci SIAMO: Interno Verde Danza
A Ferrara dal 16 al 18 Settembre
Dopodomani si comincia. Dal 16 al 18 settembre, nell’ambito dell’amatissima ed attesissima manifestazione Interno Verde, che abbiamo presentato su periscopio la settimana scorsa, la danza uscirà dal teatro ed entrerà nei giardini di Ferrara con Interno Verde Danza 2022: cinque spettacoli di danza contemporanea in vari suggestivi spazi della città, preceduti, per la prima volta, da una grande festa in Castello con le esibizioni di nove scuole di danza cittadine.
La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è inserita nel Festival di Danza Contemporanea 2022 (che da ottobre continuerà al Teatro Comunale), ed è organizzata dal Teatro Comunale di Ferrara con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara, in collaborazione, appunto, con Interno Verde.

Palazzo Schifanoia e il suo inebriante e profumato giardino, il Giardino ‘segreto’ delle Sibille di Casa Romei e il sontuoso ed elegante loggiato della Palazzina Marfisa d’Este diventano per un intero fine settimana (sabato 17 e domenica 18 settembre, con più repliche nella giornata), un palcoscenico a cielo aperto con ospiti originali e bellissime scenografie.
Interno Verde Danza 2022 propone performance site-specific di danza contemporanea ideate e realizzate da cinque tra le migliori compagnie italiane: MM Contemporary Dance Company in prima assoluta nel Giardino delle Sibille a Casa Romei con Short Stories di Michele Merola, Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto a Palazzo Schifanoia con MicroDanze / Urban Settings, CollettivO CineticO a Palazzina Marfisa d’Este con O+< Scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo, al Ridotto del Teatro Comunale (spostati dal Chiostro di San Paolo per possibili avverse condizioni meteo) Nicola Galli presenta Il mondo altrove e C.G.J. Collettivo Giulio e Jari con Evento.
Danza, storia, arte e architettura si collegano tra loro. D’altronde, Ferrara, sin dal XV secolo, ha un legame particolare con la danza grazie alla figura pionieristica di Domenichino da Piacenza, primo teorizzatore dell’arte coreutica che, con la sua attività alla corte degli Este, riuscì a far riconoscere alla danza la stessa dignità della musica e della pittura.
Eccovi allora alcuni dettagli sugli eventi nello specifico. Se siete curiosi, troverete vari link agli artisti, cliccando sui nomi rispettivi.
 Venerdì 16 settembre ore 20 – Loggiato del cortile del Castello Estense, Open Day Scuole di Danza
Venerdì 16 settembre ore 20 – Loggiato del cortile del Castello Estense, Open Day Scuole di Danza
Le Scuole di Danza del territorio presentano le proprie coreografie. Hanno aderito all’iniziativa: la Scuola di Danza di Luisa Tagliani, il Cigno Danza M2 di Melania Durca, Dance Nation di Fabrizio Lolli, Scuola di Danza Classica Arabesque di Elena Souchilina, Gruppo Teatro Danza di Anna Lolli, Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara – direzione artistica di Silvia Bottoni, ASD Vigarano Danza di Anna Rita Smai, Hip Hop Room di Sabrina Lopez e Zenit E-Motion a Bondeno di Marika Ferrarini.
Sabato 17 e domenica 18 settembre ore 11, 17.30 e 18.30, Casa Romei – Short Stories – MM Contemporary Dance Company
Ferrara ospita la prima assoluta di Short Stories di Michele Merola (una coproduzione del Teatro Comunale di Ferrara).

Interpreti saranno sei danzatori della MM Contemporary Dance Company, compagnia di danza contemporanea attiva dal 1999 e diretta dallo stesso Merola.
Short Stories nasce per adattarsi a luoghi non convenzionali come un cortile, un prato, un giardino naturale, una radura.
La coreografia, nelle sue varie sezioni, dialoga con il giardino ‘segreto’ di Casa Romei (quello delle Sibille) e con gli affreschi e la storia dell’edificio costruito dal mercante Giovanni Romei alla metà del XV secolo, tanto da creare un rapporto sinergico tra corpi, spazi e pubblico presente. Il luogo si trasformerà poeticamente in un teatro a cielo aperto, pur mantenendo la sua peculiarità e la sua anima. Il lavoro coinvolge i corpi danzanti in un disegno continuo, costruito su ripetizioni e differenze, momenti di assoli, duetti e partiture corali, musicalmente sostenute da loop e lunghissimi rallenty generati dal sound della musica dal vivo, composta ed eseguita da Federica Furlani. I danzatori faranno perdere il senso del confine che separa pubblico e spazio scenico.
Prima della performance, Andrea Sardo, direttore del Museo di Casa Romei, illustrerà la Sala delle Sibille in collegamento con il giardino, per dar modo a chi vi assiste di cogliere e godere delle connessioni artistiche tra l’evento danzato e lo spazio che lo ospita.

Sabato 17 e domenica 18 settembre ore 11.30, 16 e 19, Palazzo Schifanoia, MicroDanze/Urban Setting – Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
Nei suggestivi spazi interni ed esterni di Palazzo Schifanoia, residenza di “delizia” dei duchi estensi e luogo simbolo di Ferrara, la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto propone MicroDanze / Urban Setting, progetto di performance “danzate” ideato da Gigi Cristoforetti che sfugge alla dinamica del palcoscenico, alla distanza che separa lo spettatore dall’interprete, creando un continuum tra chi guarda e chi è guardato sollecitando un’esperienza emotiva ed estetica. Il Nuovo Museo Schifanoia e parte del suo giardino dialogheranno con il lavoro di coreografi – nazionali e internazionali – che hanno concepito otto pezzi brevi di sei-otto minuti da danzare in spazi ristretti, ai quali è possibile assistere come se si stesse visitando – appunto – un museo. Filo conduttore è la ricerca sulla danza come forma dell’abitare, in relazione con le pratiche artistiche contemporanee che si radicano in un territorio.

Le MicroDanze rappresentate a Interno Verde Danza sono inserite in un suggestivo percorso curato da Lara Guidetti e sono: Active Motivation di Elena Kekkou, Pensieri di Carta di Hélias Tur-Dorvault, Eppur si muove di Francesca Lattuada, Turn the Tide di Roberto Tedesco, Knight Rider di Yannis Nikolaidis, Strôma di Giovanni Insaudo, Forget me not di Konstantinos Rigos, Fantasmagoria di Markella Manoliadi. Nell’ottica di trasmissione e valorizzazione del lavoro, il progetto coinvolge giovani talentuosi danzatori selezionati da Aterballetto.
Sabato 17 e domenica 18 settembre, ore 11, 17.30 e 19, Ridotto del Teatro Comunale (spostati dal Chiostro di San Paolo per possibili avverse condizioni meteo), Evento – C.G.J. Collettivo Giulio e Jari
Sabato 17 e domenica 18 settembre ore 11.30, 18 e 19.30, Ridotto del Teatro Comunale (spostati dal Chiostro di San Paolo per possibili avverse condizioni meteo), Il mondo altrove – Nicola Galli
Al Ridotto del Teatro Comunale due saranno gli appuntamenti. Si inizia nel chiostro piccolo con C.G.J. Collettivo Giulio e Jari, che propongono Evento, di e con Giulio Petrucci e Jari Boldrini, con musica di Simone Grande. Per gli artisti “le relazioni umane sono esperienze condivise intessute di ricordi”. La relazione e l’intesa tra i performer esprime il coraggio di vivere pienamente e apertamente l’unicità di un legame irripetibile, per condividerlo. Evento nasce, dunque, dal desiderio di trasmettere un’esperienza del corpo senza alcun filtro. Il motore è il fulmineo scambio di informazioni tra i due danzatori: i tempi ritmici rispondono a un impulso visivo e la geometria dello spazio muta ripetutamente.

A seguire, nel chiostro grande di San Paolo, Nicola Galli presenta Il mondo altrove, creazione coreografica in forma di rituale danzato, che celebra secondo una logica scenica il moto di un mondo inesplorato. Quattro figure sciamaniche, finemente adornate, conducono una cerimonia magica e senza tempo, un dialogo gestuale che diviene espressione di sostegno vicendevole, dono perpetuo, comunione universale e celeste. Nel tracciare un percorso ideale tra Occidente e Oriente, il lavoro di Galli è liberamente ispirato ai rituali indigeni dell’America del Sud, ai simboli e alle tradizioni del teatro Nō giapponese, e all’ossessiva, per certi versi mistica ed eccentrica ricerca musicale del compositore Giacinto Scelsi intorno all’idea sferica del suono.

Sabato 17 e domenica 18 settembre ore 11, 17.30 e 19, Palazzina Marfisa d’Este, O+< Scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo – CollettivO CineticO
Il giardino di Palazzina Marfisa d’Este, con la decorata Loggia degli Aranci, è lo spazio e il luogo con cui si confronta CollettivO CineticO con O+< Scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo, creazione di Francesca Pennini, con Teodora Grano (danza), Angelo Pedroni (dj live) e Andrea Amaducci (grafica live).

In O+< la danza è costruita e decostruita secondo una continua precarietà. Una sorta di tappeto bianco rettangolare occupa lo spazio. Sul grande foglio il corpo di nero vestito della performer danza, mentre il writer osserva, strizza gli occhi, immortala frame che velocemente trasforma in disegni sull’enorme tela. È come se il movimento venisse bloccato, ritratto, schizzato sul foglio che si riempie di segni in base alla presenza della danzatrice che entra in dialogo con lo spazio bianco monodimensionale: il tratto si fa corpo, mentre il corpo si fa tratto nell’azione pittorica di Amaducci.
Un programma ricchissimo, dunque. Di che inebriarsi, al profumo dei giardini in fiore.

Immagini cortesia dell’Ufficio stampa del Teatro Comunale di Ferrara