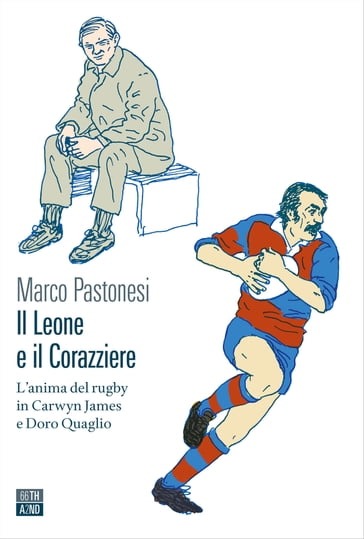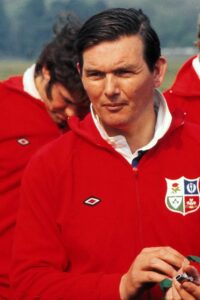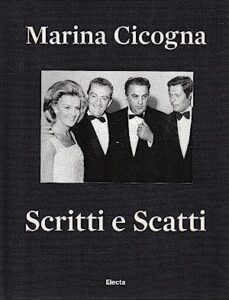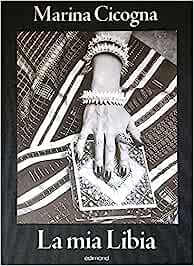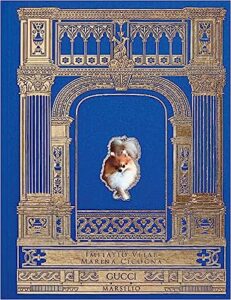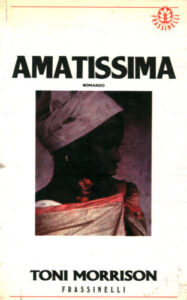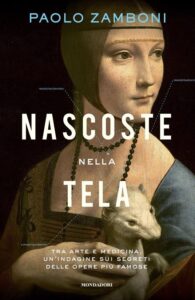Presto di mattina. Esili e dimore del cuore
La parola ha esili e dimore nel cuore dell’uomo
Dove mai può aggrapparsi la mattina
e descrivere il suo volo la speranza?
Per quali vie l’apprensione arriva
alla patria della pace e lì stramazza?
Sognano i sogni come unirsi al vento
e planare su una immota, quieta spiaggia.
La febbre si fa fuoco e non rallenta,
preme sul sangue finché non si sparge.
E la vita, la vita è questo aprirsi
verso l’altro, dolorosamente.
È bussare alle porte, fino a ferirsi.
È sapere che la morte rozzamente
verrà a cercarci. E a un tempo sentirsi
vivi per sempre, puntigliosamente.
(Osvaldo Pol)
Osvaldo Pol, gesuita argentino e poeta (1935-2016) si considerava in questo mondo uno straniero, in esilio, e forgiava le sue parole, di notte, dove la luce annida. Quando nel 1981 pubblicò una sua raccolta poetica dal titolo De destierros y moradas/Esili e dimore, papa Francesco, che allora insegnava letteratura nel liceo del collegio dei gesuiti, scrisse la prefazione:
«sono lieto di presentare questo libro di sonetti dove, in linguaggio poetico, si esprime la sapienza teologica, che è il frutto più apprezzato dalla Compagnia di Gesù nel suo impegno accademico. Può sembrare paradossale che un poeta parli, con linguaggio della terra, di esiliati dalla terra. Può sembrare paradossale ma non lo è, perché la parola poetica ha dimore di carne nel cuore dell’uomo e – al tempo stesso – sente il peso di ali che ancora non hanno spiccato il volo. Arduo dilemma, questo, che santa Teresa esprime poeticamente e misticamente: “Com’è duro quest’esilio!”» (La Civiltà Cattolica, 2021, Quaderno 4106, 189;191).
Per conoscere il cuore
La poesia come la letteratura fanno vedere legami anche là dove sembrano non esserci, rivelano una profondità nuova in una realtà apparentemente uniforme e senza spessore. Così per papa Begoglio l’esperienza creativa e l’immaginazione sono determinanti anche per la fede e la sua comunicazione: «Il romanzo, la letteratura legge il cuore dell’uomo, aiuta ad accogliere il desiderio, lo splendore e la miseria. Non è teoria. Aiuta a predicare, a conoscere il cuore» (Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, Rizzoli, Milano 2016, XX).,
Egli pensa pure che avere immaginazione aiuta a non irrigidirsi, rendendo capaci di libertà interiore, di misericordia e di dolcezza e in questo tempo di paradigmi rigidi, polarizzazioni contrapposte, crisi climatica ed economica, «abbiamo bisogno della genialità di un linguaggio nuovo, di storie e immagini potenti, di scrittori, poeti, artisti capaci di gridare al mondo il messaggio evangelico, di farci vedere Gesù.» (CivCat, Q4145, 2023).
Fame di un significato
Dal 25 al 27 maggio 2023 si è tenuto a Roma un convegno organizzato da La Civiltà Cattolica con la Georgetown University di Washington DC sul tema L’estetica globale dell’immaginazione cattolica, per riflettere su come la fede cattolica plasmi l’immaginazione e dia vita all’espressione artistica. Hanno partecipato oltre 40 poeti, narratori, sceneggiatori, arrivati a Roma da Canada, India, Irlanda, Italia, Kenya, Nigeria, Polonia, Regno Unito, Stati Uniti, Uganda. Tra loro anche il regista Martin Scorsese.
Quali sono i modi in cui la fede interroga la vita, esplora la condizione umana e risponde alla fame di significato? E in che modo gli artisti mettono in discussione l’eredità intellettuale, sociale o politica in cui questa fede è vissuta nel mondo contemporaneo? Come ispira l’orizzonte del cattolicesimo il lavoro creativo degli artisti?
Questo convegno è stato così l’occasione per papa Francesco di ritornare su temi a lui familiari per riaffermare come la letteratura e la poesia siano luoghi molto significativi oggi per interrogarci, lascar parlare Dio attraverso di essi e parlare di lui. Come a dire che anche la letteratura e l’arte sono “loci theologici”/ luoghi della teologia insieme alla scrittura, alla tradizione, alla liturgia, al magistero, alla storia e alla ragione, fonti da cui attingere il sapere e la riflessione su Dio e il suo mistero in rapporto all’uomo.
Nel discorso rivolto ai convenuti il 27 maggio Francesco ha ricordato come la letteratura e la poesia, muovendo alla contemplazione, siano una “spina nel cuore” che apre al cammino. Per questo la fede non può fare a meno di esse per comprendersi ed esprimersi nella forma di un sapere e di una testimonianza:
«So che in questi giorni avete riflettuto su quali siano i modi attraverso i quali la fede interroga la vita contemporanea, cercando così di rispondere alla fame di significato. Questo “significato” non è riducibile a un concetto, no. È un significato totale che prende poesia, simbolo, sentimenti. Il vero significato non è quello del dizionario: quello è il significato della parola, e la parola è uno strumento di tutto quello che è dentro di noi».
Spina nel cuore per lo sguardo, l’ascolto, la voce, il grido
Una spina che non mortifica ma vivifica è l’esperienza artistica, perché ferendo essa libera la vita dai luoghi chiusi e sospinge verso spazi aperti. Lungi dall’anestetizzare, la letteratura e la poesia rendono sensibili all’umano e allo spirito dimorante in esso, generano partenze e ritorni, esili e dimore nel cuore:
«Ho amato molti poeti e scrittori nella mia vita, tra i quali ricordo soprattutto Dante, Dostoevskij e altri ancora. Le parole degli scrittori mi hanno aiutato a capire me stesso, il mondo, il mio popolo; ma anche ad approfondire il cuore umano, la mia personale vita di fede, e perfino il mio compito pastorale, anche ora in questo ministero. Dunque, la parola letteraria è come una spina nel cuore che muove alla contemplazione e ti mette in cammino. La poesia è aperta, ti butta da un’altra parte».
Nelle sue molteplici forme l’arte apre gli occhi. Così gli artisti e gli scrittori sono occhi che guardano e sognano, tanto che − citando Paul Claudel − Francesco afferma: «Il vostro è un “occhio che ascolta”. L’arte è un antidoto contro la mentalità del calcolo e dell’uniformità; è una sfida al nostro immaginario, al nostro modo di vedere e capire le cose.
E in questo senso lo stesso Vangelo è una sfida artistica, con una carica “rivoluzionaria” che voi siete chiamati a esprimere grazie al vostro genio con una parola che protesta, chiama, grida. Oggi la Chiesa ha bisogno della vostra genialità, perché ha bisogno di protestare, chiamare e gridare».
Sguardo, ascolto, voce e grido a far argine con l’ispirazione e l’inquietudine da essi generati all’indifferenza, alla rassegnazione, alla banalità, alla scontentezza dell’uniformità del pensiero e per risvegliare dal sonno malato e dall’addomesticamento delle ideologie.
Di questo è convinto il papa: «gli artisti sono la voce delle inquietudini umane. Tante volte le inquietudini sono sepolte nel fondo del cuore. Voi sapete bene che l’ispirazione artistica non è solo confortante, ma anche inquietante, perché presenta sia le realtà belle della vita sia quelle tragiche. L’arte è il terreno fertile nel quale si esprimono le «opposizioni polari» della realtà, le quali richiedono sempre un linguaggio creativo e non rigido, capace di veicolare messaggi e visioni potenti».
L’artista guarda, ascolta sogna e dà voce al grido di chi non ha voce; dà la parola al loro silenzio; dà spesso, cromatismo, figura simbolica all’invisibile, «profetizza, annuncia un modo diverso di vedere e capire le cose che sono sotto i nostri occhi. Infatti, la poesia non parla della realtà a partire da princìpi astratti, ma mettendosi in ascolto della realtà stessa: il lavoro, l’amore, la morte e tutte le piccole grandi cose che riempiono la vita. E, in questo senso, ci aiuta a “carpire la voce di Dio anche dalla voce del tempo”».
Un’esperienza debordante quella artistica
Un’esperienza debordante – ricorda papa Francesco – perché dà corpo, vita, immagine, scrittura e parola al sentire umano: quello inesprimibile, indicibile «delle tensioni dell’anima, della complessità delle decisioni, della contraddittorietà dell’esistenza.
Ci sono cose nella vita che, a volte, non riusciamo neanche a comprendere, o per le quali non troviamo le parole adeguate: questo è il vostro terreno fertile, il vostro campo di azione. E questo è anche il luogo dove spesso si fa esperienza di Dio. Un’esperienza che è sempre “debordante”: tu non puoi prenderla, la senti e va oltre; è sempre debordante, l’esperienza di Dio, come una vasca dove cade l’acqua di continuo e, dopo un po’, si riempie e l’acqua straripa, deborda».
Il suo invito agli artisti e agli scrittori è allora quello di «andare oltre i bordi chiusi e definiti, essere creativi, senza addomesticare le vostre inquietudini e quelle dell’umanità. Ho paura di questo processo di addomesticamento, perché toglie la creatività, toglie la poesia. Con la parola della poesia, raccogliere gli inquieti desideri che abitano il cuore dell’uomo, perché non si raffreddino e non si spengano.
Questa opera permette allo Spirito di agire, di creare armonia dentro le tensioni e le contraddizioni della vita umana, di tenere acceso il fuoco delle passioni buone e di contribuire alla crescita della bellezza in tutte le sue forme, quella bellezza che si esprime proprio attraverso la ricchezza delle arti… È un lavoro evangelico che ci aiuta a comprendere meglio anche Dio, come grande poeta dell’umanità. Vi criticheranno? Va bene, portate il peso della critica, cercando anche di imparare dalla critica. Ma comunque non smettete di essere originali, creativi. Non perdete lo stupore di essere vivi».
Una sfida e una responsabilità
L’immaginazione artistica al servizio della fede implica, soprattutto nel nostro tempo, una sfida e una responsabilità: di «non “spiegare” il mistero di Cristo, che in realtà è inesauribile; ma farcelo toccare, farcelo sentire immediatamente vicino, consegnarcelo come realtà viva, e farci cogliere la bellezza della sua promessa.
Perché la sua promessa aiuta la nostra immaginazione: ci aiuta a immaginare in modo nuovo la nostra vita, la nostra storia e il futuro dell’umanità!… La vostra opera ci aiuta a vedere Gesù, a guarire la nostra immaginazione da tutto ciò che ne oscura il volto o, ancor peggio, da tutto ciò che vuole addomesticarlo. Addomesticare il volto di Cristo, quasi per tentare di definirlo e di chiuderlo nei nostri schemi, significa distruggere la sua immagine. Il Signore ci sorprende sempre, Cristo è sempre più grande».
Affiora qui lo stesso orientamento prospettico, l’ispirazione spirituale e pastorale di papa Francesco in questi suoi primi 10 anni di pontificato: non spiegare, ma avere occhi che guardano, immaginano, sognano; mani e cuore per fare della realtà della vita la nostra responsabilità e la nostra ostinazione a continuare ad immaginare il nuovo nascosto nel vecchio, il futuro nel presente, nell’Evangelo la gioia.
Una poesia che brucia tra le mani
Gli alunni del liceo dei gesuiti a Santa Fe in Argentina, al tempo in cui Bergoglio insegnava letteratura, gli chiedevano di leggere autori moderni, preferendoli ai classici, inducendo così il futuro papa ad aggiungere a quelle letture anche la pratica della scrittura creativa.
Tra i poeti moderni prescelti per quell’esperienza didattica, e non solo, un ruolo centrale venne assegnato a Federico Gracía Lorca, la cui poesia gli “bruciava tra le mani”. L’espressione è di Carlo Bo, ispanista, francesista e critico letterario, nell’introduzione a tutte le opere da lui tradotte in due volumi per l’editrice Guanda (Poesie, Parma 1964).
Da dove originava un tale fuoco? «La poesia che gli bruciava nelle mani gli veniva sempre dalla realtà, dall’altro, non la considerava sua, limitandosi a considerare patrimonio personale la sua forza di adesione e di partecipazione, il suo “bruciare”». Per Gracía Lorca l’atto del guardare si intreccia in lui con quello del “prendere e fare”. Un dire facendo: è questa reciprocità relazionale uno dei tratti più peculiari del poeta andaluso, in grado per questo di allargare il mondo poetico radicandolo nel reale.
Scrive ancora Carlo Bo: «Da una parte uno spirito che si prepara a ricevere, dall’altra un mondo che già trasmette e verso cui il poeta si protende, con l’ambizione di raccogliere tutto, tutto quello che si può guardare e sentire», (ivi, XIV). Il suo è uno sguardo immediato alla realtà che diviene poi prospettico, uno sguardo allungato senza rinunciare all’uno o all’altro ma tenendoli insieme.
Interrogato su ciò che per lui fosse poesia disse: «Guardare, guardare …», non dando tuttavia una definizione, ma rimandando ad una pratica ad un esercizio poetico in atto. Come a dire, commenta ancora Carlo Bo che «il poeta per prima cosa deve fare: lasciamo agli altri – ai critici e ai professori – il compito della definizione. C’era, dunque, in partenza una grande volontà di fare e possiamo anche aggiungere: un senso della strada, assai più preciso di quel che non risulti a prima vista» (ivi, XIII).
Una conversione all’umanità sofferente
C’è pure in Gracía Lorca – ricorda sempre Carlo Bo – una dimensione “patetica”, di condivisione sofferente, ma “senza drammaticità”. Una sofferenza che si compì al termine della sua vita, quando venne ucciso dai falangisti, seguaci di Francisco Franco nella guerra civile spagnola.
Gracía Lorca così ricordava in un’intervista questa sua prossimità alla sofferenza d’altri: «“Gli ebrei, i siriani, e i negri. Soprattutto i negri! Con la loro tristezza sono diventati l’asse spirituale dell’America. Il negro che è così vicino alla natura umana pura e all’altra natura. Il negro che tira fuori musica perfino dalle tasche! Fuori dell’arte negra, non resta negli Stati Uniti che meccanica e automatismo”.
E come spiegare questa conversione all’umanità sofferente? Perché si è accesa, e in modo cosi aperto e sconvolgente, la sua partecipazione?» gli domanda l’intervistatore. Risponde: “Credo che l’essere nato a Granada mi porta alla comprensione simpatica dei perseguitati. Del gitano, del negro, dell’ebreo … del moro che tutti noi portiamo dentro. Granada sa di mistero. Di cosa che non può essere e però è. Che non esiste ma conta. O conta proprio perché non esiste, perde il corpo e conserva il profumo”.» (ivi, XXVII-XXVIII)
Guardare, guardare: Garcia Lorca desiderava «che tutti potessero guardare e che non ci fosse privilegio per una parte degli uomini, che per tutti ci fosse la possibilità di mettere in equilibrio il giglio e il fango» (ivi, XXXIV).
Il Canto del miele
Sia Ezechiele nelle sue visioni profetiche che Giovanni nell’Apocalisse sono invitati a nutrirsi di un piccolo libro. È il simbolo della vocazione profetica, della Parola di Dio che si incarna nella vita del profeta: «Io lo mangiai: fu per la mia bocca dolce come il miele» (Ez 2,8-9; 3,1-3). Ma la Parola non è solo da ingerire. Essa va digerita, assimilata tramite una ruminazione difficile e dolorosa.
L’immagine di Ezechiele viene ripresa in Apocalisse 10,10: «Presi quel piccolo libro dalla mano dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza».
Non solo dolcezza dunque, ma anche inquietudine genera la Parola di Dio. Dolce e amaro è il Verso/Verbo incarnato, perché messaggero di salvezza e, al contempo, di giudizio che mette allo scoperto cosa si ha nel cuore. La parola di Cristo consola e contesta insieme, libera e apre contese dentro e fuori di ciascuno. Una lotta per la luce che genera pervasiva inquietudine, un sofferto e stridente contrasto con ciò che oscura dentro di noi l’autenticità della vita e con ciò che fronteggia fuori di noi: l’ostile e violento incalzare di coloro che non amano la luce.
Così è pure della parola poetica: dolce e amara, patetica e gioiosa, luminosa e oscura, generativa in noi di forti emozioni, di sentimenti sofferti e di dolci risvegli, perché come il sole del mattino è il miele, lo canta la parola: grazia d’estate, frescura autunnale, foglia appassita e frumento. Impresa d’amore e suo canto è il miele che tesse l’infinito nel finito, epopea di un dire amando.
L’umiltà della parola primigenia è seminata così nel verso primitivo del poeta, profezia di un futuro sereno, di quiete dopo la tempesta.
È questo Il canto del miele
Il miele è la parola di Cristo,
l’oro fuso del suo amore.
La perfezione del nettare,
la mummia [balsamo] della luce del paradiso.
L’arnia è una stella casta,
pozzo d’ambra che alimenta il ritmo
delle api. Seno delle campagne
vibrante d’aromi e di ronzii.
Il miele è l’epopea dell’amore,
la materialità dell’infinito.
Anima e sangue dolente dei fiori
condensata attraverso un altro spirito.
(Cosi il miele dell’uomo è la poesia
che sgorga dal suo cuore dolente,
da un favo con la cera del ricordo
formato dall’ape più segreta).
Il miele è la bucolica lontana
del pastore, la zampogna e l’olivo,
fratello del latte e delle ghiande,
regine supreme del secolo d’oro.
Il miele è come il sole del mattino,
ha tutta la grazia dell’estate
e l’antica frescura dell’autunno.
È la foglia appassita ed è il frumento.
O divino liquore dell’umiltà,
sereno come un verso primitivo.
(ivi, 57).
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.