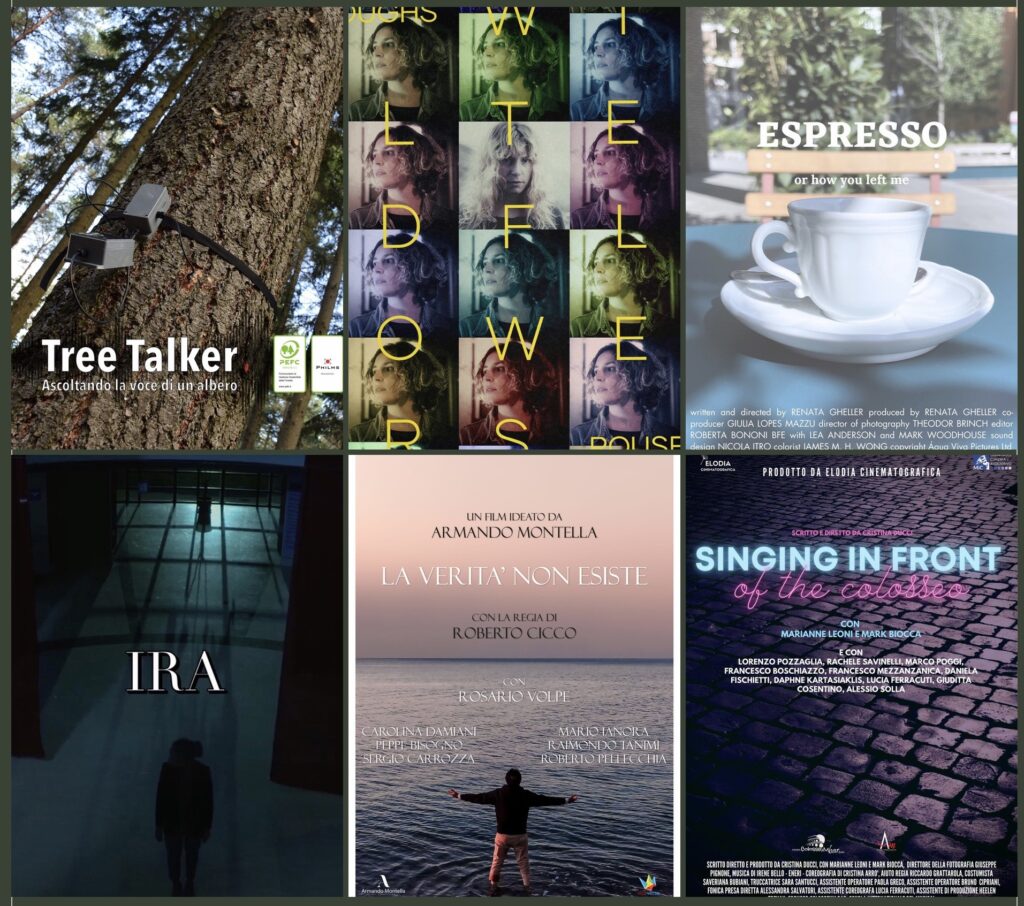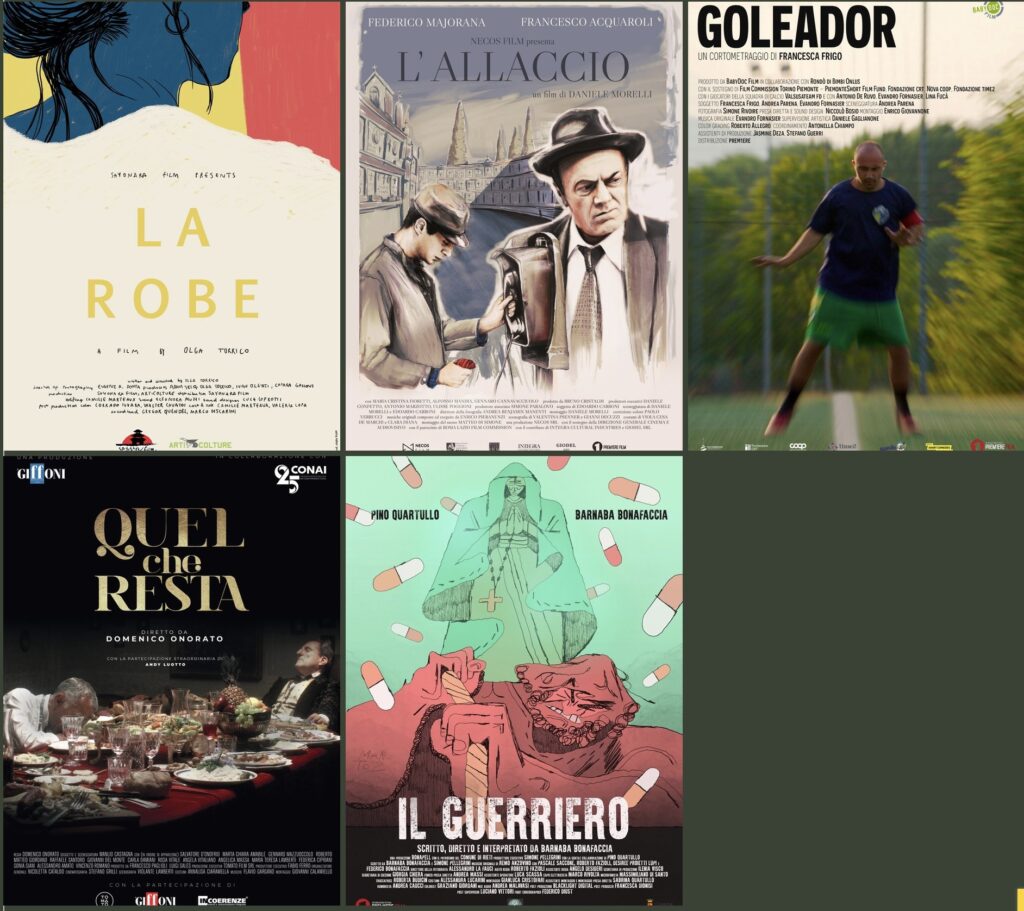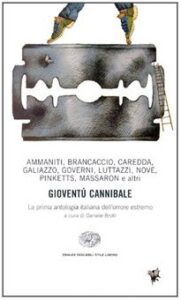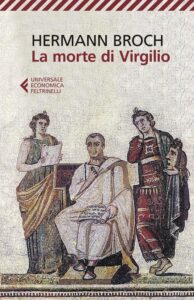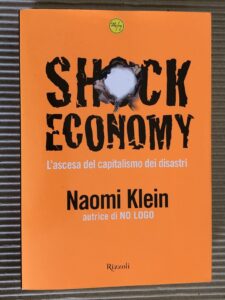Julian Assange non ha bisogno di essere presentato. La sua lotta è la nostra lotta, la lotta per la libertà di espressione, una libertà che oggi è sempre più minacciata dalla disinformazione dilagante e dalla “dittatura dell’opinione” che sempre più invade e corrompe le nostre democrazie. Chi controlla l’opinione pubblica controlla il mondo; i mezzi per manipolarla sono sempre più sofisticati e nelle mani di governi, oligarchi e società monopolistiche.
Quest’anno, l’Accademia delle Arti di Berlino, un’istituzione fondata 300 anni fa, ha dedicato a Julian Assange il suo Premio Konrad-Wolf (in memoria di un regista dell’ex DDR che fu presidente dell’Accademia per molti anni).
Poiché Julian Assange si trova da quattro anni nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra, lottando contro la sua estradizione negli Stati Uniti (dove rischia l’ergastolo o addirittura la pena di morte!), il premio dell’Accademia è stato ritirato dalla moglie, Stella Assange, avvocatessa che si batte per i diritti umani.
 Stella e Julian Assange (Foto di Actvism, Munique)
Stella e Julian Assange (Foto di Actvism, Munique)
Nel corso di questo reportage, vedrete diverse foto scattate durante la cerimonia di premiazione.
PRESSENZA ha anche avuto l’opportunità di intervistare Stella in esclusiva sulla situazione attuale di Julian.
.Stella Assange ha sottolineato in particolare il ruolo positivo di Lula da Silva, che ha parlato ripetutamente di Julian Assange durante le conferenze stampa. Lula ha anche affrontato il caso di Julian nel suo discorso di apertura dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York lo scorso settembre, dove ha chiesto la sua liberazione, tra gli applausi della stragrande maggioranza dei rappresentanti politici di tutto il mondo presenti.
Intervista di Vasco Esteves a Stella Assange a Berlino il 22/10/2023
Qual è l’attuale situazione legale di Julian? Si è tenuta l’udienza pubblica a Londra per prendere la decisione finale sulla sua estradizione negli Stati Uniti? Ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo? E questo ricorso potrebbe impedire la sua estradizione?
Non c’è ancora stata un’udienza pubblica, stiamo aspettando. Questa potrebbe essere l’ultima tappa nel Regno Unito della sfida legale di Julian contro l’estradizione. Se non supera questa fase, le vie legali nel Regno Unito saranno esaurite per lui. Prima di poter ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Julian deve attendere che siano esauriti tutti i ricorsi nazionali.
Questo ricorso ritarderà o meno l’estradizione negli Stati Uniti?
La decisione spetta alla Corte Europea. In primo luogo, bisogna vedere se accetterà o meno il caso (non è automatico); in caso affermativo, potrà far scattare il cosiddetto articolo 39, che consiste nell’ordinare al Regno Unito di non procedere all’estradizione mentre la sua richiesta viene decisa. Ci sono quindi diverse fasi da seguire. La Corte Europea può ordinare l’applicazione dell’articolo 39 e il Regno Unito dovrà adeguarsi. Ovviamente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è l’ultima istanza legale all’interno del sistema del Consiglio d’Europa. Una sentenza a favore di Julian potrebbe impedire la sua estradizione.
I governi del Portogallo e del Brasile hanno fornito aiuto o espresso solidarietà a Julian Assange?
Per quanto ne so, il governo portoghese non si è mosso in questo senso, ma il presidente brasiliano Lula da Silva si è espresso più volte sul caso di Julian, citandolo nel suo discorso di apertura all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York lo scorso settembre. Ha anche parlato ripetutamente di Julian in conferenze stampa.
Passiamo ora alla Germania. Annalena Baerbock, capolista dei Verdi alle ultime elezioni, si era espressa a favore del rilascio di Julian PRIMA delle elezioni. Ora però, come Ministro degli Esteri tedesco, non affronta più la questione… Ha parlato con lei? E come spiega il suo cambiamento di posizione?
Non ho ancora parlato con la signora Baerbock, ma ho parlato con il Ministero degli Esteri tedesco. Il governo della Merkel aveva inviato degli osservatori per monitorare con discrezione il caso di Julian; non mi risulta che l’attuale governo abbia fatto altrettanto. Credo che il Ministero degli Esteri tedesco, anche sotto il precedente governo, abbia rilasciato solo una dichiarazione in cui esprimeva preoccupazione per la situazione umanitaria di Julian. Per quanto riguarda il Commissario per i Diritti Umani dell’attuale governo federale, non sono a conoscenza di alcun tipo di posizione pubblica formale sulla questione.
Testo del manifesto: “Julian Assange libero! I criminali di guerra sono liberi, i giornalisti investigativi rischiano la pena di morte. Mettete i criminali di guerra in prigione!”. (Foto di PRESSENZA)
Altri Paesi (come l’Italia) stanno facendo molto di più per attirare l’attenzione sulla situazione di Julian, ad esempio conferendogli la cittadinanza onoraria di Napoli, di altre città e ora anche della capitale, Roma. Cosa manca qui in Germania?
Penso che anche la Germania sia molto favorevole a Julian a livello di base. Anche la stampa tedesca è stata molto positiva nell’analisi del caso. C’è stato, credo, un documentario molto buono della ARD [canale televisivo pubblico]. Lo SPIEGEL ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che il caso dovrebbe essere archiviato e mi ha intervistato e così via.
Ma a livello istituzionale la Germania è in ritardo rispetto ad altri grandi Paesi europei. L’Italia, ovviamente, è un ottimo esempio di mobilitazione attraverso le istituzioni per esprimere posizioni politiche. Come spiega questo fenomeno e cosa ne pensa?
Non conosco bene la situazione tedesca, ma vedo i risultati. Forse i tedeschi sono un po’ introspettivi e vogliono prima valutare la situazione e gli eventuali errori. Penso che l’Italia abbia un sistema democratico più efficace. Non intendo sminuire il sostegno, che in Germania è molto forte, ma non vedo qui lo stesso tipo di situazione dell’Italia.
A Berlino da anni si svolgono regolarmente iniziative e veglie per Julian. Cosa possono fare i berlinesi per esercitare ancora più pressione riguardo alla sua causa?
Il movimento per la liberazione di Julian è un movimento globale che cresce nel tempo. Ognuno ha reti diverse, amicizie, relazioni familiari, contatti sui social media o posizioni in questo o quel settore. Ci sono persone che vanno in piazza in una piccola città per organizzare una protesta individuale “Free Julian Assange”, disegnando con il gesso le dimensioni della sua cella e rimanendo lì per circa un’ora la domenica. Per me è un segno di determinazione e impegno ed è fonte di ispirazione. E quando chi non è a conoscenza di un caso vede altre persone molto impegnate, soprattutto quando si tratta di un caso di ingiustizia così grave, pensa: “Beh, se questa persona ci tiene così tanto, allora forse dovrei farlo anch’io!”. Questo è molto efficace. Il movimento “Free Assange” non è centralizzato. Ogni giorno ci sono proteste, mobilitazioni e così via. Quindi penso che dobbiamo organizzarci per andare avanti, per raggiungere le persone in posizioni di potere – scrivendogli, parlando direttamente con loro e ricordandogli cosa dovrebbero fare se non stanno facendo la cosa giusta.
Viviamo in un mondo in cui una sorta di “dittatura dell’opinione” sta crescendo e distruggendo le nostre democrazie dall’interno. Il maccartismo e la guerra fredda sono tornati, anche nelle nostre menti. I politici occidentali si scagliano continuamente contro i crimini di guerra degli altri (Russia, Hamas, ecc.), ma i loro crimini di guerra (che Julian Assange ha contribuito in modo decisivo a svelare) vengono ignorati o banalizzati… e chi li ha denunciati continua a essere spietatamente perseguitato. Cosa ne pensa e come si sente in una situazione come questa?
Penso che dobbiamo riconoscere che c’è un conflitto di interessi molto significativo per molti di questi grandi Paesi occidentali, che sono anche i maggiori esportatori di armi. Di fatto, traggono vantaggio dalle guerre! Per quanto riguarda la limitazione della libertà di espressione, Julian ha firmato una dichiarazione proprio la settimana scorsa. Si chiama “Dichiarazione di Westminster” ed è stata sottoscritta da circa 140 persone: giornalisti, attivisti, ma soprattutto persone di destra e di sinistra. Persone che affermano che oggi esiste un’industria della censura, un’industria del controllo della narrazione e che dobbiamo tornare a una cultura della libertà di espressione. Senza la libertà di espressione non possiamo sperare di promuovere la pace, perché gli strumenti per controllare la comunicazione sono troppo forti, quindi dobbiamo lottare per queste due cose allo stesso tempo.
Una domanda personale: che cosa ha imparato su di sé combattendo il sistema?
È importante non avere paura e lottare per ciò in cui si crede. La paura è il nostro più grande nemico. Dobbiamo essere in grado di comunicare liberamente. Sto lottando per mio marito. Credo che molte persone vogliano vederlo libero, non solo per motivi umanitari, ma anche perché capiscono che la sua libertà riguarda anche loro. Credo di aver imparato che ogni persona può svolgere un ruolo importante nell’influenzare il mondo che la circonda e cercare di cambiarlo in meglio. Ogni piccolo gesto che compiamo modella l’ambiente che ci circonda, anche se non ce ne rendiamo conto immediatamente. Abbiamo un impatto. E facile scoraggiarci e pensare che non possiamo cambiare le cose, che chi ha il potere è lassù in alto e non ci ascolta… ma non è così!
Grazie, Stella, per questa intervista!
 Stella Assange con un gruppo di sostenitori a Berlino (Foto di Christian Deppe)
Stella Assange con un gruppo di sostenitori a Berlino (Foto di Christian Deppe)
Traduzione dall’inglese di Thomas Schmid
Revisione di Anna Polo
In copertina: Stella Assange riceve a Berlino il Premio Konrad-Wolf a nome del marito Julian. (Foto di Pressenza)