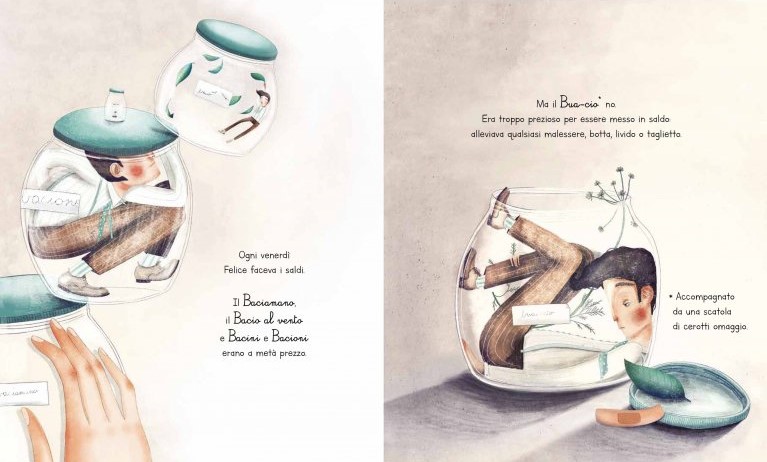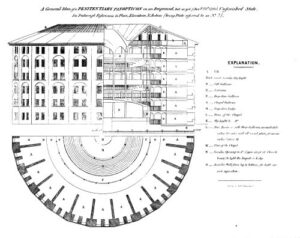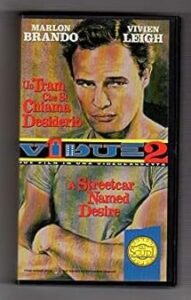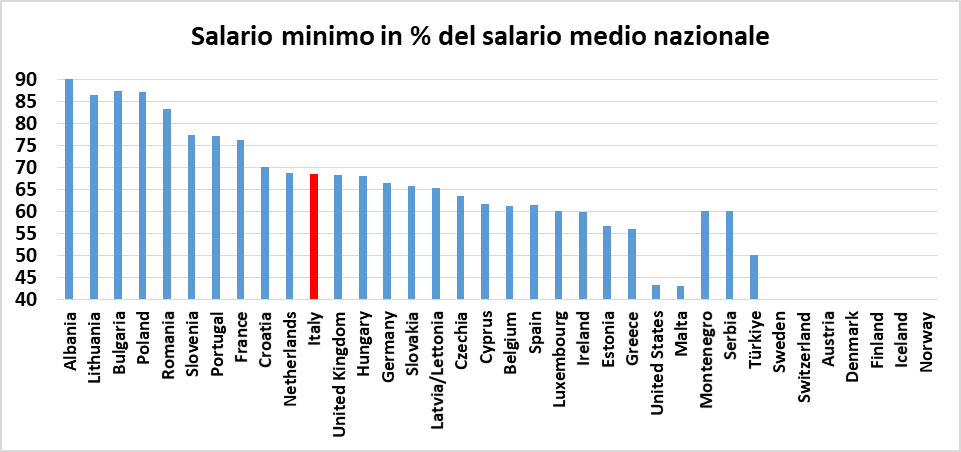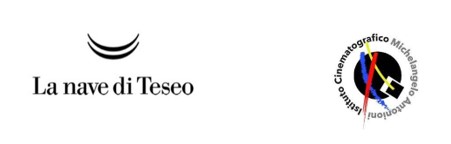L’OPERAZIONE BERGOGLIO: DAL PALAZZO ALLA TENDA
Sono trascorsi dieci anni dall’elezione di papa Francesco (13 marzo 2013).
Scrive Alberto Melloni che “non bastano per fare il bilancio di un papato” (QN, 12 marzo 2023), perché la conclusione dei pontificati spesso si caratterizza per alcuni finali colpi di reni. È accaduto, per esempio, con la Pacem in terris di Giovanni XXIII (aprile 1963) e la Declaratio di rinuncia di Benedetto XVI (febbraio 2013).
Due avvenimenti che, per importanza, portano a condividere la tesi secondo la quale per tentare un bilancio occorre attendere la fine di un pontificato.
Eppure, continua lo storico, un decennio è sufficiente per disegnare “nitide le parole-chiave di papa Bergoglio”.
Ma ancor prima, può essere utile comprendere il significato di quella scelta compiuta dal conclave nel marzo di dieci anni fa, e proprio alla luce della “operazione Bergoglio”, potrebbero risultare maggiormente contestualizzate le sue parole-chiave, ossia la sua direzione di marcia.
Per farlo occorre risalire all’uscita di scena del suo predecessore, Benedetto XVI.
Come è noto, il nome del cardinale gesuita argentino, arcivescovo di Buenos Aires, compare come candidato nel conclave del 2005, ma risulta ben presto chiaro che l’unica vera candidatura è quella del prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, strettissimo collaboratore del suo predecessore, papa Wojtyla.
Come scrive ancora Melloni “il disordine che ha travolto Ratzinger è stato uno dei mandati del conclave”. Lo storico che insegna all’Università di Modena-Reggio Emilia, nel breve spazio di un articolo di giornale non ha modo di argomentare quel “disordine”, eppure paiono chiari i riferimenti, innanzitutto, all’ondata di scandali e fallimenti che hanno investito la chiesa durante il suo pontificato (abusi sessuali, le finanze, gli intrighi di curia compresa la fuga di carte dalle stanze vaticane, il tentativo di riavvicinare i lefebvriani …).
Numerosi osservatori vedono però molto altro e di molto più profondo in quelle clamorose dimissioni. Ci sarebbe, cioè, la fragilità e l’obsolescenza di una strategia ecclesiale e di un paradigma pastorale complessivi giunti inesorabilmente al loro capolinea, di cui Ratzinger è stato, forse, l’ultimo e più autorevole, oltreché integerrimo interprete.
 Fra queste analisi, trovo particolarmente convincente quella che fa lo storico Daniele Menozzi (Il papato di Francesco in prospettiva storica, 2023).
Fra queste analisi, trovo particolarmente convincente quella che fa lo storico Daniele Menozzi (Il papato di Francesco in prospettiva storica, 2023).
Provo a farne sintesi.
Il punto di partenza cruciale da cui prende le mosse questa analisi risiede nel significato del termine “aggiornamento”, chiesto da papa Giovanni XXIII (“balzo in avanti”), con la convocazione del concilio Vaticano II e con il suo famoso discorso di apertura di quell’assise; Gaudet Mater Ecclesia (11 ottobre 1961).
Innanzitutto occorre chiedersi il perché di una richiesta tanto esigente, specie se si pensa che Roncalli venne eletto come un papa di transizione.
L’urgenza avvertita dal pontefice bergamasco era che la chiesa doveva ritrovare la capacità di rendere comprensibile all’uomo contemporaneo il messaggio cristiano.
C’era, in sostanza, la consapevolezza di una distanza, una progressiva incomprensione, nel rapporto tra la chiesa e il mondo.
Le ragioni di fondo di questo solco venivano individuate nella lunga egemonia della cultura intransigente sospinta per secoli, sorretta da una corposa sponda teologica e da una incontestata postura pastorale, che però stava rivelando i segni inequivocabili di un sostanziale fallimento.
Credo che per capire la portata di questo tema sia utile ripercorrere brevemente le parole della teologa Marinella Perroni in una relazione svolta nel settembre 2021 su invito del vescovo della diocesi calabrese di Cassano allo Jonio, mons. Francesco Savino (Una chiesa sinodale: “c’è un tempo per demolire e un tempo per costruire” (Qo 3,3). Un discernimento generativo).
«L’ultima grande riforma della chiesa, che ne ha definito la forma identitaria ad intra come ad extra, cioè il suo impianto istituzionale nonché il suo modo di rapportarsi al mondo, risale all’epoca medievale, più precisamente all’XI secolo. (…) Con la riforma gregoriana, voluta da papa Gregorio VII (1073-1085), la chiesa latina a partire da una concezione teocratica del potere e dalla conseguente convinzione della superiorità del papato su ogni autorità temporale, non soltanto si lancia in uno scontro permanente con re e imperatori, ma rafforza sé stessa grazie all’affermazione di un ferreo centralismo romano e di una rigida struttura clericale.
Da allora la chiesa latina non ha più saputo riformare sé stessa. (…) Quando diciamo che la chiesa deve liberarsi dal clericalismo, affermiamo di fatto che (…) deve trovare la forza di una riforma che la faccia finalmente uscire da mille anni di storia che l’hanno vincolata a modelli ideologici e istituzionali del tutto incompatibili con il mondo degli uomini e delle donne del nostro tempo, figli della cultura democratica e delle lotte per i diritti umani, attenti alle esigenze e alle spinte tecnologiche, aperti ai richiami della spiritualità, ma allergici a riconoscersi in enclaves militanti o devozionali (p. 3-4).»
Del tutto analoga alla lettura della biblista Perroni è quella dell’ecclesiologo Severino Dianich, che nella riflessione La Chiesa dopo la Chiesa (Il Regno 14/2013), scrive:
«Mentre si sviluppava l’assetto liberale della società e cresceva l’aspirazione dei popoli a essere governati democraticamente (aspirazione che diventerà drammatica sotto le dittature del Novecento) e mentre si diffondeva una cultura protesa all’esaltazione della dignità della persona umana e della sua libertà, nella Chiesa persisteva il rifiuto della laicità dello stato e il sogno di poter restaurare dovunque lo stato confessionale, che le avrebbe assicurato l’esercizio di un vero potere, anche se indiretto, sullo stato e i suoi organi legislativi.
(…) Le frequenti condanne da parte del magistero di tesi filosofiche, di progetti politici, di tante espressioni delle arti e del costume non sono riuscite, di fatto, a scalzare neanche di poco l’affermarsi di una cultura che, pur portatrice di molti valori evangelici (corsivo mio), veniva contrapponendosi alla predicazione e alla politica ecclesiastica della Chiesa cattolica. Questa posizione perennemente antagonista ha allargato, invece, sempre più il fossato fra i non credenti e la comunità cristiana (p. 466).»
Con il suo discorso di apertura del concilio Vaticano II papa Roncalli – per tornare all’analisi di Menozzi – “forniva una diagnosi della situazione e proponeva una soluzione”:
Erano i “profeti di sventura”, che nei tempi moderni vedevano solo disastri e rovine, ad aver allontanato i contemporanei dalla fede cattolica. In effetti, lanciando anatemi contro diverse conquiste di un uomo moderno che, sottraendosi alla guida ecclesiastica, rivendicava la capacità di costruire in piena autonomia una convivenza più prospera e felice, essi mitizzavano i tempi della cristianità rispetto a un presente connotato negativamente.
Stigmatizzando il rimpianto del passato – un monito in cui si può facilmente leggere un implicito riferimento al medievalismo della cultura intransigente -, Giovanni XXIII mirava a ovviare al pericolo di una Chiesa che, separandosi dalla società moderna, rischiava di ridursi alle dimensioni di una setta (p. 19-20).
Vale la pena, qui, aprire un inciso che aiuta a darci la cifra della posta in gioco che si apriva con l’invito di Roncalli a compiere quel balzo in avanti, rappresentato dalla formula dell’aggiornamento.
Era invitabile che, non essendo questa lettura patrimonio dell’intera ecclesia, si sarebbero ben presto espresse le resistenze a queste aperture e, soprattutto, alle conseguenze che esse implicavano. Resistenze che si manifestarono durante tutte le quattro sessioni del Vaticano II, che animarono successivamente il dibattito postconciliare e che tuttora danno voce a posizioni anche di aperto dissenso ecclesiale, fino a posizioni di aperta opposizione all’attuale pontefice come non si sono mai viste nella storia recente.
 Esprime bene questo passaggio lo storico Andrea Riccardi (La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, 2021):
Esprime bene questo passaggio lo storico Andrea Riccardi (La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo, 2021):
«Quando ci si concentra sul presente, il confronto corre al passato prossimo, quando la situazione era migliore, più folto il numero dei fedeli e di ecclesiastici. Chi è fisso sul presente è spinto a confrontarsi con ieri e a restare immobile, quasi che la sfida del futuro sia troppo ardua per le proprie forze e ci si deve accontentare di tenere sull’oggi. Questo è scivolare nell’ ‘irrilevanza’ (p. 225).»
A proposito della persistenza di tali posizioni e segnatamente delle più recenti e vivaci contestazioni, si possono ricordare quelle provenienti dagli ambienti più tradizionalisti con l’applicazione dello stesso schema interpretativo riservato a tutti i papi del postconcilio: l’allontanamento dall’ortodossia cattolica.
La pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Letitia (2016), ossia il documento di sintesi dei due sinodi sulla famiglia (2014 e 2015), fu l’occasione della famosa lettera che quattro cardinali (Raymond Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmüller e Joachim Meisner) indirizzarono al pontefice e alla Congregazione per la dottrina della fede, per metterne sotto accusa l’impianto dottrinale.
Un secondo esempio fu, nel 2017, una “correzione filiale” sottoscritta da esponenti della galassia anticonciliare, che individuava sette posizioni eretiche nell’insegnamento del papa.
Su questi episodi lo storico Menozzi è ancor più netto nell’analisi, classificandoli come:
«l’occasione per mettere in mostra l’inconsistenza culturale di simili posizioni. In effetti ben più che alla millenaria tradizione cattolica i circoli tradizionalisti si richiamano alla riformulazione dell’eredità della Controriforma che ha compiuto l’intransigentismo cattolico otto-novecentesco. L’identificazione di queste recenti elaborazioni teologiche con la millenaria tradizione della Chiesa ne rileva tutta la fragilità intellettuale (p. 6).»
Tale repertorio di rilievi critici sarebbe tuttavia parziale se non si comprendessero anche quelli provenienti dagli ambienti progressisti. Sulla scorta delle resistenze della Santa sede a riconoscere alcune istanze delle chiese locali (l’ordinazione di diaconi permanenti sposati, la revisione del celibato per il sacerdozio, l’apertura alle donne di ruoli ministeriali)
«qualche commentatore ha caratterizzato come immobilistica la linea di Francesco. (…) Altri hanno sostenuto che la curia romana ha architettato (…) la costruzione della fittizia immagine di un papa rivoluzionario, per ottenere, con la complicità di alcuni organi d’informazione e dello stesso Francesco, il vero obiettivo cui mirava il conclave che nel marzo 2013 lo ha eletto: impedire ogni reale riforma del cattolicesimo. (…) non meno pungente la polemica di quanti scorgono nel governo di Bergoglio un disinteresse per la modernità occidentale (p.7).»
Tornando nel solco della svolta impressa da papa Roncalli con l’apertura del concilio che si svolse tra il 1962 e il 1965, è risaputo che il Vaticano II nel corpo complessivo dei documenti (quattro Costituzioni, nove Decreti e tre Dichiarazioni), non è riuscito a tradurre quell’impulso che evocava una nuova pentecoste in un indirizzo unitario all’aggiornamento ecclesiale auspicato.
Paolo VI, subentrato a Giovanni XXIII (morto nel giugno 1963):
«preoccupato di assicurare la più larga adesione possibile alle decisioni conciliari, ha favorito soluzioni di compromesso che, se hanno consentito di rendere evidente l’unanimità morale della Chiesa attorno alle deliberazioni conciliari, non hanno però contribuito alla chiara indicazione delle strade su cui doveva incamminarsi il cambiamento (Menozzi, p. 20).»
Per rendersi conto del travaglio che hanno attraversato i documenti conciliari, dagli schemi iniziali fino alla loro approvazione conclusiva, passando par le fasi ugualmente sofferte degli emendamenti, basta percorrere i cinque volumi della Storia del concilio Vaticano II curata da Giuseppe Alberigo (1995).
Seguendo l’efficace sintesi di Menozzi
«si può dire che nei documenti del Vaticano II si sono delineati in ordine al cruciale tema del rapporto con il mondo moderno due diversi orientamenti. Da un lato si è prospettata una linea di apertura ai contemporanei caratterizzata dal criterio di una rilettura del Vangelo alla luce dei segni dei tempi. Secondo quest’ottica la Chiesa restituiva efficacia alla sua azione pastorale nella misura in cui imparava (corsivo mio) dalla storia quali erano gli elementi del messaggio evangelico capaci di intercettare le istanze del presente e i bisogni profondi dell’uomo moderno. Dall’altro (…) una prospettiva di aggiornamento della dottrina cattolica basata sull’inquadramento al suo interno di alcuni principi e valori della modernità (p. 21).»
Anche la seconda strada di questo bivio, si badi bene, non era esente da elementi di novità, dal momento che fu a lungo osteggiata dall’autorità ecclesiastica durante la stagione di Pio XII.
La base teologica e filosofica di questa opzione risale a Jacques Maritain, che la elaborò in chiave neo-tomista tra le due guerre mondiali.
«Il filosofo francese affidava ai cattolici il compito di costruire un retto ordine della vita collettiva: si basava sulla conformazione del consorzio civile a una legge naturale (corsivo mio) valida per tutti, sempre e ovunque, di cui la Chiesa era proclamata interprete e depositaria. Tale progetto restava dunque all’interno di una logica di cristianità. Ma nella legge naturale (ecco il passaggio cruciale) Maritain e i suoi seguaci facevano ora rientrare alcuni prodotti politico-culturali della storia moderna – ad esempio il diritto alla libertà religiosa e, più in generale, i diritti umani – che erano stati a lungo da essa esclusi (pp. 21-22).»
Il punto focale di questa analisi è che il papato post-conciliare avrebbe scelto proprio questa seconda via, per tradurre la spinta roncalliana dell’aggiornamento nella concreta azione di governo e come strategia pastorale complessiva.
Lo stesso Paolo VI nello spazio compromissorio dei documenti conciliari ha cercato un punto di equilibrio, il più avanzato possibile, “ma alla fine – scrive Menozzi – ha compiuto una chiara opzione”.
Esempio emblematico di questo passaggio decisivo, secondo il docente emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è dato dall’emanazione della famosa enciclica Humanae vitae (25 luglio 1968), nella quale papa Montini scrisse: “Nessun fedele vorrà negare che al magistero della Chiesa spetti di interpretare anche la legge morale naturale” (n. 4).
Un principio autoritativo che veniva fatto risalire al mandato cristologico affidato a Pietro e agli apostoli che “li costituiva anche custodi ed interpreti autentici di tutta la legge morale, non solo cioè della legge evangelica, ma anche di quella naturale”.
Sarebbe stato questo, dunque, il timbro ultimamente identificativo successivamente sviluppato dall’intero pontificato post-conciliare, con il conseguente mandato ai cattolici di contraddistinguere e qualificare loro presenza nel mondo sulla base dell’affermazione nel consorzio civile e politico della dottrina della legge naturale custodita in via esclusiva dalla chiesa.
Una strategia ecclesiale che avrebbe conosciuto il suo “più ampio dispiegamento durante il governo di Benedetto XVI” (p. 23).
«Ratzinger ha prospettato non solo la tesi che gli ordinamenti pubblici, per essere moralmente leciti, anzi per essere autenticamente umani, devono prevedere soltanto la tutela di quei diritti umani che l’autorità ecclesiastica iscrive nella legge naturale. Ha anche richiesto che l’impegno politico e sociale dei fedeli venga indirizzato allo scopo di far sì che le legislazioni positive degli Stati siano conformi alla dottrina cattolica, che sola è in grado di garantire la reale dignità dell’uomo (p. 23).»
L’inadeguatezza di questa linea – “non a caso qualificata come progetto di neo-cristianità” – si manifesta nella difficoltà di consentire un dialogo con la modernità, dal momento che la stessa autorità ecclesiastica la individua nella “rivendicazione – scrive Menozzi – dell’emancipazione dalla tutela ecclesiastica nella definizione degli istituti fondamentali della vita collettiva”.
Difficoltà che cresce di evidenza nella cosiddetta post-modernità «caratterizzata dalla rivendicazione della facoltà per ogni individuo di autodeterminare le forme dell’esistenza non solo in relazione agli assetti politici, sociali e culturali della vita collettiva, ma anche in rapporto alle più profonde strutture antropologiche del soggetto (il corpo, la nascita e la morte, l’identità sessuale, ecc.) (p. 24).»
Avrebbe così origine in questa sfasatura la situazione paradossale secondo la quale la declinazione dell’aggiornamento conciliare, impostato e perseguito per ricondurre il mondo contemporaneo alla chiesa, avrebbe finito per apparire obsoleto e provocare un ulteriore allontanamento.
La stessa idea di una chiesa minoranza creativa di fronte alla complessità globale e all’estrema secolarizzazione da contrastare, che Joseph Ratzinger propose a Subiaco (2005) poco prima del conclave che lo elesse papa, era una proposta che implicava il portato consequenziale dei valori non negoziabili (Andrea Riccardi, La Chiesa tra centri e periferie in Il cristianesimo al tempo di papa Francesco, 2018, p. 8).
Una linea che avrebbe avuto, come una sorta di coerente linea parallela, la cosiddetta Benedict option, ossia l’opzione del ritiro polemico del cristianesimo dalla sfera pubblica in seguito alle sconfitte patite nelle culture wars degli ultimi decenni, come avvenuto nel contesto laicale nordamericano (Massimo Faggioli, I laici nella Chiesa di Francesco in Il cristianesimo al tempo …, p. 233), per realizzare un cattolicesimo dei pochi ma buoni.
L’obsolescenza di una tale strategia ecclesiale sarebbe all’origine della “crisi del paradigma di aggiornamento adottato dal papato post-conciliare” (Menozzi, p. 24).
In questa luce andrebbero rilette le clamorose dimissioni di Benedetto XVI (2013), ben oltre, quindi, il problema degli scandali nella chiesa, ossia nella presa d’atto che quella strada dell’aggiornamento, scelta e percorsa fino all’estremo tentativo, non è stata in grado di stabilire un vero ponte tra fede e storia.
Una strada che, a posteriori, è definibile più un ammodernamento che un vero e proprio aggiornamento.
 Il problema è stato, e rimane, come ha scritto Giovanni Miccoli (La Chiesa dell’anticoncilio, 2011), il rapporto con la storia:
Il problema è stato, e rimane, come ha scritto Giovanni Miccoli (La Chiesa dell’anticoncilio, 2011), il rapporto con la storia:
«La questione centrale sta ancora una volta nel tipo di rapporto che la Chiesa di Roma intende stabilire con la storia; (…) riconosce di farne interamente parte (…) o se ne sottrae, perché portatrice, intangibile dalle contingenze umane, di un messaggio che ha saputo mantenere inviolato e inalterato nel corso di duemila anni? (p. 401).»
È in questo quadro teologico-pastorale complessivo che trova spiegazione più profonda l’operazione Bergoglio, vale a dire nella ripresa di quella linea del rinnovamento conciliare attenuata o abbandonata dai suoi predecessori e basata sulla convinzione “che la Chiesa non solo non è al di fuori e al di sopra della storia (…); ma soprattutto dalla storia impara le vie più idonee per annunciare il Vangelo” (Menozzi, p. 26).
Leggi la 2° parte su Periscopio
NOTA:
Questo saggio di Francesco Lavezzi, insieme ad altre Cronache Ecclesiali del medesimo autore è stato recentemente pubblicato in “Quaderni Cedoc SFR 49” a cura di Andrea Zerbini
Per leggere gli articoli di Francesco Lavezzi su Periscopio clicca sul nome dell’autore