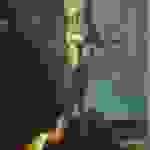L’eredità della Achmatowa e la responsabilità dei giornalisti
Nella prefazione di una lunga Requiem per le vittime dello stalinismo, la poetessa russa Anna Achmatowa (Bol’soj Fontan, 1889 – Mosca, 1966) ricordava un incontro durante la coda davanti alla prigione di Leningrado/Pietroburgo. “In un modo o in un altro qualcuno mi aveva riconosciuto. Allora si destò la donna con le labbra livide che era in piedi dietro di me, che naturalmente non aveva mai sentito il mio nome, e mi domandò, sussurrandomi all’orecchio: “E lei sarebbe in grado di descrivere tutto questo?”. E io dissi: “Sì”. Allora qualcosa come un sorriso sdrucciolò su quello che era stato il suo viso”.
Grazie a Dio, oggi lo stalinismo, almeno quello di una volta, non esiste più, ma ci sono altri modi di combattere e di perseguire la libertà di stampa e d’opinione in tutto il mondo, anche in Europa, anche in Germania, anche in Italia. Ma nonostante il degrado di una democrazia vera ed ideale, non si può paragonare il grado di terrore politico che si ebbe durante lo stalinismo degli anni dei Gulag a quello che oggi abita la freddissima Corea del Nord, la Cina dei comunisti capitalisti o la Russia di Putin, degli oligarchi ricchissimi con l’incavatura della democrazia occidentale. Ma il ricordo di Anna Achmatowa, dell’episodio davanti al carcere staliniano, resta utile per il giornalista che non voglia disperare davanti a eventi drammatici.
Ogni giornalista ha l’enorme opportunità, ma anche la responsabilità, di tradurre con la scrittura quello che altri, le vittime inermi e ammutolite, non riescono o non possono più esprimere. Sembrano parole patetiche ma il giornalista le deve sempre riprendere nelle situazioni drammatiche, quando si imbatte nei limiti della sua professione. Oggi, si parla molto e sempre di più di una rivoluzione nel mondo mediatico attraverso la comunicazione online e sui social network. Davvero l’attuale cambiamento del nostro modo di comunicare con gli altri, con i più vicini e in tutto il mondo, è radicale. Sopratutto per le generazioni più vecchie, talvolta ha effetti anche sconvolgenti, quasi come un terremoto delle loro abitudini. Perciò, noi come giornalisti off e online abbiamo quasi come un precetto, quello che le persone in coda davanti alla prigione staliniana hanno domandato alla Achmatova: “Lei sarebbe in grado di descrivere la nostra crescente precarietà nei tempi di crisi?” “Si”, diceva la Achmatowa. E qualcosa come un sorriso sdrucciolò su quello che era stato il suo viso.”