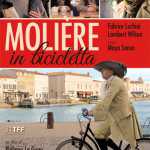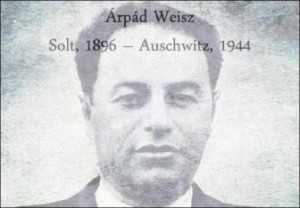Il ‘Castello’ dell’ospedale di Cona ovvero le avventure dell’utente V.
Mi avvio a portare i referti al nuovo ospedale Sant’Anna di Cona, una strana sensazione m’invade mentre dalla superstrada si staglia l’ormai nota sagoma dell’immensa costruzione. La memoria involontaria immediatamente mi fa scattare il ricordo di letture lontane e fondamentali. Penso tra me e me che devo rileggere le pagine iniziali del Castello, il grande romanzo di Franz Kafka. E così faccio: “Nel complesso, il Castello, come appariva da lontano, corrispondeva all’aspettazione di K. Non era un vecchio maniero feudale né un palazzo nuovo e sontuoso, ma una vasta costruzione, composta da pochi edifici a due piani [….] Chi non avesse saputo che era un Castello, l’avrebbe scambiato per una piccola città”.
La vicenda dell’agrimensore K. a questo punto si confonde con quella dell’utente V. Speravo in cuor mio di non fare la fine del povero K. che teme di essere risucchiato dagli incomprensibili ordini che gli vengono imposti dl misterioso padrone del Castello fino a farlo sentire responsabile di colpe non commesse e di cui ignora il senso. Ma ero ben munito. Una chiarissima mappa consegnatami con solennità dalla clinica privata da cui provenivo con spiegazione di cosa dovevo fare e le tappe da seguire mi rende relativamente tranquillo. Così -secondo indicazione- all’ingresso 2 entro nella sala dove si pagano i ticket e per prima cosa sbaglio il biglietto per la fila: non la C dedicata alle visite private, ma l’A era quella da prendersi.
Mi accorgo che ho 45 ‘utenti’ davanti a me. Solo due sportelli su sei svolgono quel servizio. E attendo sempre più immedesimandomi nell’agrimensore K con rovellìo di pensieri: “Ho portato tutto? Pago in contanti o col bancomat ?” mentre bruscamente mi risveglio sentendo un diffuso lamento che secondo la più straordinaria invenzione dantesca dei dannati che vengono battuti da Caron dimonio dagli occhi di bragia si diffonde per la sala. “La macchina del bancomat si è inceppata! Bisogna attendere il tennico” E la signora a me vicina balbetta “E ora come faccio a dirlo a mia figlia?”. Mi sento invaso da un eroico senso del dovere: trovo la figlia, la informo, consolo la signora che con gesto meccanico e tenerissimo per nascondere l’agitazione si aggiusta il fazzoletto di seta artificiale sul capo. Mi offro di andare a prendere una carrozzella, ma lei schermendosi vuole solo che le porga il braccio per alzarsi. Che dignità! E mi risiedo invaso da cupi pensieri.
S’avvicina una guardia giurata e a voce alta confida a una infermiera presente come gli avessero sbagliato tutto; che era entrato nelle stanze secrete e minacciato di denunciare gli ufficiali del Castello. Ahimè! Non so trattenermi e a una gentilissima addetta domando quanto tempo presume visto che entro le 13 dovevo andare lassù nell’inviolabile regno dell’anatomo-patologia dove si spegne ogni furore umano e di lotta. Un “Mah” sussurrato mi riabbatte al mio posto.
Infine a un’ora e 25 minuti dal mio ingresso mi siedo davanti allo sportello 6. Una signora ancor disponibilissima sebbene recasse i segni della precedente utente a cui aveva dovuto risolvere intricati problemi di appuntamenti mi accoglie con un pallido sorriso e a lei, trepidando, porgo ‘l’impegnativa’. Si srotola da quel momento un’allucinante sequenza di interrogativi fra me, la signora e il computer che ci gettano nella disperazione. Quale codice bisogna inserire? Rientro nella categoria degli aventi diritto all’esenzione oppure no? La macchina, carogna, non dà risposte. Telefonata convulsa alla clinica privata con esito negativo e dopo esserci guardati negli occhi la signora si ribella e decide di mettere sulla mia pratica (come poi si rivelerà giusto) esentato. Sono passati 22 minuti 18 secondi.
La fila si è notevolmente ingrossata facendomi provare un senso di colpa immotivata come al protagonista del Castello; occhi rancorosi mi guardano di sottecchi mentre la povera signora mi mostra una triste mela mangiucchiata a metà e mi rivela in confidenza che ancora deve recarsi al bagno; ma le leggi del Castello non permettono questi diversivi. Stressato ma orgoglioso d’aver vinto il potere ottuso della macchina infine, come spiega la mappa, prendo l’ascensore di sinistra allo snodo (1 o 2? Boh!). E’ solo quello che porta direttamente al sancta sanctorum della patologia ovvero al terzo piano. Passi vellutati, sussurri e non grida, officianti assorti nel loro compito.
Consegno a una deliziosa signora (ma i maschi dove sono finiti?) le boccette e alla sua domanda “Viene lei a ritirarli?” Rispondo con un atterrito no! E doverosamente riferisco a quale reparto a quali medici vada mandata la risposta: naturalmente sbagliando tutto. Dopo quattro telefonate ci si accorda, mostrando pazienza quasi superiore a quella provocata dalla più comune e invasiva domanda del Castello di Cona: “Dov’è l’uscita? Rientro nell’ansimante caos del reparto.
Esce lei l’amatissima primario che mi sostiene e m’incoraggia da anni. Ci baciamo come accade da anni tra sguardi cupi e labbra strette degli altri “utenti”, m’infilo nella stanza sgabuzzino della giovane medico che deve segnare sulla mia cartella gli ultimi dati. E’ ancora allegra nonostante la massa di lavoro svolto da parecchie ore (sono le 13 meno otto minuti. Il mio ingresso è stato alle 9 e 25) le consiglio il film ‘Grand Budapest Hotel’ per risollevarsi. E mentre un affettuosissimo giovane portantino con un’immensa cresta in testa, degna del copricapo dei soldati greci, coccola una signora sofferente stesa sul lettino, m’avvio, sollevato a mia volta, verso la macchina.
Ma è la fila 6 o la fila 9 dove l’ho lasciata? Non importa: prima o poi ci arriverò.