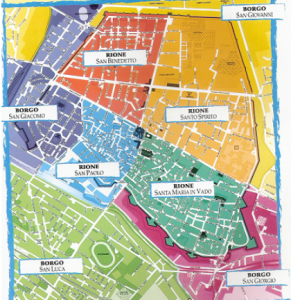Molti eventi ci mostrano che siamo nel bel mezzo di cambiamenti epocali, per fronteggiare i quali ci servono nuove idee, nuove strutture, nuove istituzioni, un modo nuovo di pensare alla società e un diverso modo di rapportarsi con l’ambiente. Servono nuove istituzioni che portino fuori dalla pericolosa contrapposizione tra Stato e mercato, pubblico e privato; serve un modo di pensare flessibile che sappia riconoscere e confrontarsi con la complessità evitando la chiusura in sfere e settori separati intenti a raggiungere ognuno una propria efficienza che si traduce troppo spesso in spreco collettivo privatizzando i guadagni e socializzando le perdite. Occorre ripensare anche alla qualità degli ambienti di vita in stretta relazione ai bisogni umani che contraddistinguono la condizione sempre presente di fragilità umana.
Uno degli effetti positivi della crisi degli ultimi anni è quello di aver reso quanto mai urgente e necessario un cambiamento da lungo tempo auspicato, ma del quale tuttavia non è ancora chiara la direzione né i possibili effetti sui cittadini. Purtroppo in Italia manca ampiamente la capacità di ragionare per scenari, di immaginare un futuro possibile, di pensare in orizzonti di lungo periodo, di ipotizzare come potrà essere l’ambiente in cui vivremo nei prossimi anni. Il futuro prossimo dipende certo da molte variabili esogene e poco controllabili, ma dipende anche dai sogni e dalla volontà delle persone, dalle azioni finalizzate di organizzazioni ed istituzioni. Senza questa visione e senza strategia, il futuro semplicemente sarà imposto da altri attori e da altre forze alle quali si potrà solo reagire in termini di accettazione, fuga o rifiuto. Questo è particolarmente vero a livello di cittadini, del territorio sul quale vivono le persone ed operano le amministrazioni locali. A questo livello, si possono certo immaginare molti possibili scenari ma, tra questi, in linea più generale, due diversi e contrapposti possono aiutare la riflessione:
Possiamo descrivere il primo scenario (spinto dalla speranza e dalla responsabilità) come caratterizzato dal fiorire dei beni comuni, in cui gli spazi vivibili sono a misura di persona, e dove la proprietà privata (la casa innanzitutto) trova senso e valorizzazione all’interno di un ambiente urbanistico e sociale abilitante. Uno scenario caratterizzato dalla responsabilità dei cittadini, da aspetti comunitari diffusi e da un uso sociale delle tecnologie, dal primato del potenziamento delle capacità delle persone rispetto alla crescita forzosa del Pil, inteso come misura indubitabile del benessere delle comunità;
Sempre sinteticamente, il secondo scenario (spinto dalla paura e dall’avidità) potrebbe al contrario verificarsi in seguito al trionfo del privato e dalla distruzione definitiva dei beni collettivi, dove le persone “che possono” vivono in luoghi privati (abitazioni innanzitutto) completamente blindati e sorvegliati, ma inseriti in “non luoghi” insicuri e degradati, percorsi di transito videosorvegliati ed ipervigilati. Uno scenario che alimenta la paura e l’insicurezza, spingendo sempre più verso la giuridificazione dei rapporti umani e la perdita di libertà sostanziale.
I germi di entrambi gli scenari sono ben visibili a chi osserva le nostre città e i nostri paesi e, purtroppo, sembrano indicare un’inclinazione piuttosto inquietante verso il secondo, come attesta la costante distruzione di territorio (8 mq al secondo, come riporta La Stampa), la richiesta di maggiore video-controllo da parte dei cittadini, la cementificazione sistematica e l’inesorabile aumento del traffico privato, la produzione e gestione della paura da parte dei media e del mondo della politica. Per fortuna lo scopo della “scenarizzazione” è, anche, quello di aiutare a prendere decisioni strategiche che spostino il sistema verso uno stato piuttosto che un altro. Se pensiamo di collocarci, per puro esperimento mentale, in uno degli scenari, non possiamo prescindere dal fatto che tutti siamo (siamo stati o saremo) in stato di fragilità e bisognosi di cura: lo siamo stati per definizione quando eravamo bambini; lo siamo quando cadiamo ammalati o quando ci troviamo in stato di disabilità, anche temporanea; lo diventeremo, molto probabilmente, da anziani. Alcuni, i meno fortunati, lo sono per tutto il ciclo di vita, ma il rischio connesso alla fragilità incombe sempre su tutti ed in ogni momento. Basta un incidente, una malattia, una disgrazia, un tracollo finanziario.
Il modo in cui finora si è pensato di affrontare questi problemi di fragilità nel nostro sistema di welfare, ha coinciso con la creazione di servizi sempre più specializzati e specialistici che richiedono una precisa identificazione dei target e si basano, da un lato, sulle competenze di categorie di esperti e, dall’altro, sono orientati all’individuazione di sempre nuovi bisogni necessari a giustificare la loro stessa esistenza.
Come conseguenza di ciò, si è assistito negli ultimi decenni ad un aumento complessivo dei livelli di patologizzazione e ad un sostenuto incremento dei costi che appaiono oggi insostenibili. Anche l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha messo in risalto l’esigenza di modificare questo paradigma di riferimento, spostando l’attenzione da un modello di tipo medico (centrato sul problema personale, la cura medica, il trattamento individuale) ad uno di tipo sociale (centrato sul problema sociale, l’integrazione e l’inclusione, la responsabilità individuale e collettiva). Ragionare in termini di fragilità significa adottare un pensiero strategico che ponga l’accento sulle capacità e sul sistema anziché sulle carenze e sul singolo soggetto. Su questo riferimento generale si basa anche il noto modello Icf (International classification of functioning), ancora interpretato da molti come mero sistema di classificazione delle disabilità, è in realtà una strategia per costruire mondi a misura di fragilità umane ovvero ambienti a misura di bambini, di anziani e di disabili. Si badi: ambienti e non semplicemente servizi.
Come potrebbe essere strutturato un simile ambiente? Che caratteristiche dovrebbe avere partendo dal presupposto che ogni comunità ha la possibilità, per così dire, di crearselo su misura?
•Dovrebbe essere innanzitutto uno spazio sicuro, dove i soggetti in stato di fragilità possono muoversi con agio e sicurezza;
•dovrebbe essere un luogo di socialità intergenerazionale e interculturale che aiuti a rompere le separazioni tra gruppi sociali;
•dovrebbe essere un luogo comunitario ed aggregante dove le persone possono vedere facilitata la possibilità di collaborazione e di aiuto, che renda più facile la soluzione di possibili conflitti;
•dovrebbe essere uno spazio che funziona come una piattaforma abilitante, adatta a far emergere o a costruire le capacità delle persone piuttosto che un luogo specializzato (ed invivibile) di consumo o di produzione separato dal contesto.
Un territorio a misura di fragilità umane è innanzitutto un ambiente accogliente per tutte le persone, un bel posto dove vivere; esso presuppone probabilmente una mobilità pedonale e ciclistica, buon trasporto pubblico, bellezza ed estetica, presenza delle infrastrutture essenziali alla socialità e al comportamento civile. Presuppone, in altre parole, una pianificazione urbanistica (partecipata, che parta dal basso) a livello di sistema, la centralità dei beni comuni e il ridimensionamento di modelli di sviluppo basati esclusivamente sulla speculazione edilizia, sul dominio assoluto del mercato immobiliare, su tv e auto privata, sul consumo forzoso, sulla fretta e sulla presunta carenza di spazi, sulla manipolazione sistematica dei bisogni.
Che vantaggi comporta l’agire in un contesto ambientale e sociale a misura di fragilità umane? In un ambiente che, per essere a misura di bambini, disabili e anziani, è – a fortiori – a misura umana? Esso favorisce l’aumento e il rafforzamento delle reti fiduciarie, supporta e sostiene lo sviluppo di capitale sociale, contribuisce a rafforzare le istituzioni sociali che dovrebbero tutelare e potenziare i beni collettivi, contribuisce a costruire comunità e ne rafforza la resilienza, ha robuste implicazioni per la crescita sostenibile. Si tratta di un ambiente che motiva le persone ad attuare quei cambiamenti che sono indispensabili in una società responsabile ed umana, la cornice indispensabile per diminuire l’ormai non più sostenibile costo associato alle vecchie modalità di erogazione di servizi.
Modificare la struttura dell’ambiente di vita nella direzione delle fragilità umane è un passo imprescindibile (certamente non l’unico) per costruire nuove capacità e generare nelle persone che ci vivono la motivazione indispensabile per mettere a punto ed usare sistemi premianti per i comportamenti virtuosi. E’ tuttavia un passo che richiede molta consapevolezza da parte delle amministrazioni, grande coraggio e visione da parte della politica, molto senso strategico da parte di quei settori istituzionali (come ad esempio i servizi sociali e sanitari) da sempre più vicini al tema della fragilità umana e del bisogno.
Difficile forse, ma che cosa è in fondo la democrazia se non la capacità di esprimere uno stato che sia in grado di assegnare diritti alle istituzioni dei beni comuni e non solo ai mercati, alle lobby più potenti e alle imprese multinazionali private? Che sia in grado di garantire la giustizia senza causare necessariamente la giuridificazione forzosa dei rapporti sociali?
Si può fare! Passaparola
Dal blog di Bruno Vigilio Turra valut-azione.net