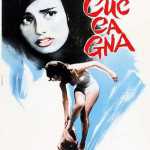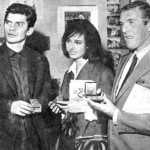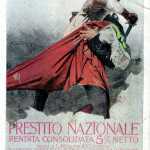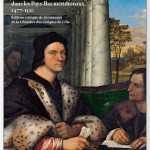San Vito, 22 novembre, di nuovo verso Bologna (seconda parte) by Wu Ming 1
Agguato di un predone solitario, nascosto tra gli arbusti della pieve di San Vito. Due centimetri più a destra e mi avrebbe spaccato il naso, ma già mi spostavo all’indietro e il bastone mi ha sfiorato. Ci aveva messo tutta la forza, e ha perso l’equilibrio.
L’ho visto cadere male e battere un gomito su un sasso.
– Ouch! – ha fatto, come nei fumetti che trovi nei fossi, mezzi sciolti. Storie imputridite. Ho trovato anche mazzette di euro. Consumate, e comunque inutili. Almeno qui.
Si è rimesso in piedi, ora mi fissa curioso. E’ magro (chi non lo è?), ha occhi verdi e capelli incolori. I cenci che indossa mi ricordano qualcosa. Li riconosco: divisa e pastrano da
carabiniere.
– Non sei di queste parti, si vede.
– E da cosa? Io sono nata qui, anche se adesso vivo lontano.
Sente la voce e come coniugo il verbo, s’illumina: – Ah, ma sei una donna! Non si capiva mica!
Alzo il cappuccio e abbasso la sciarpa. Vede che ho una certa età, vede le rughe e il suo sorriso un po’ si attenua, ma non scompare.
– Vivi lontano? E cosa sei tornata a fare?
– Potrei risponderti che sono affari miei. – rispondo, ma lieve, senza metterci ostilità.
Ridacchia. – Sarebbe più che lecito. E se ti chiedo come ti chiami? Va bene anche un nome qualsiasi.
Gliene dico uno, il mio. Mi porge la mano, la stringo, è fredda.
– Io sono Matteo. – mi dice.
– Sei un predone, Matteo?
– Moche moche! Io pensavo che c’eri tu, predone! Proprio perché non ti ho mai vista prima.
– Sono solo una che passa.
– Viaggi da sola. Non hai paura?
– Come tutti. Né di più, né di meno. Ma tu cosa facevi tra i cespugli?
– Andavo di corpo. – risponde pronto, senza esitare. – O meglio, non avevo ancora cominciato. E adesso m’è andata indietro.
Comunque, tornerà. – E ride ancora, stavolta più sonoro.
Per un po’ stiamo in silenzio. Ci guardiamo intorno. Lungo via Ferrara non più asfaltata, i platani sono immensi. Grandi rami che nessuno ha più potato s’intrecciano ovunque e formano un tetto, là in alto. La vecchia statale sembra ormai una galleria. In basso, qualcuno continua a estirpare le erbacce, sposta i rami caduti, riempie le buche più grosse. La carreggiata è sassosa ma percorribile.
– Già che ci sono ti chiedo un’altra cosa, prometto che non ti fa incazzare, va bene?
Gli offro un cenno d’assenso.
– Bon. Cosa fa il governo? Ce n’è ancora uno, dove stai tu?
– No. Lo spettro del governo è sempre a Sud.
– Lo immaginavo. Qui si fa viva solo la Commissione. – L’ex carabiniere che credevo un bandito alza le spalle. – Ci aiutano, per modo di dire. Vai a capire il perché.
– Lo fanno in cambio dei servizi che rende il governo. Dormi dentro la chiesa? – gli domando.
– Dormo dove decidono i piedi. E cos’è che fa il governo, esattamente?
– Pattuglia le coste, i confini d’Europa. Lo Ionio, il Tirreno… Ferma e respinge gli illegali.
– Cioè li ammazza. Io lo so come vanno certe cose, c’ero in mezzo. – E a questo punto ci vorrebbe una pausa, un momento pensoso, ma l’uomo tira diritto: – Pazzesco, c’è ancora qualcuno che vuole venire in ‘sto pantano?
– Parti d’Italia tirano avanti, e comunque in Africa è peggio. Ma sai, molti non lo fanno per fermarsi qui, è che l’Italia è l’anello debole. Loro arrivano, se ci riescono, e salgono, se ci riescono.
Vanno su in Europa.
– A far che? C’è ancora del lavoro? – mi chiede.
– Penso di sì, qualcosa del genere.
Poi una domanda la faccio io: – Ogni quanto si fa viva la Commissione? Sono giorni che attraverso la provincia e non ho ancora visto un funzionario.
– Dipende. Arrivano in elicottero. Sono gli unici ad avere carburante. Alcuni sembrano cinesi.
In elicottero? In questi giorni ho visto alianti e deltaplani, ho visto mongolfiere e perfino un dirigibile, ma nessun elicottero, mai. E col rumore che fanno, non mi sarebbero sfuggiti.
Forse, ho pensato ad alta voce, perché Matteo ribatte: – Ne arrivano, ne arrivano. Atterrano nelle piazze dei paesi, consegnano le razioni, fanno riunioni coi consigli comunali…
– Consigli comunali? Sono ripartite le elezioni?
– Beh, per modo di dire… I commissari non volevano, ma la gente s’organizza. Io lo so bene, son consigliere pure io.
– Ah, sì? E di quale comune?
– Gambulaga.
– Non faceva comune, ai miei tempi.
– Tutto cambia. Soprattutto i tempi. Hai qualcosa da mangiare?
Nella sacca ho le rane pescate ieri. Sono tante, le ho cotte allo spiedo, carne sciapa ma croccante. E ho un mazzo di radicchio selvatico. Matteo mi mostra una borraccia amaranto. – C’è anche da bere. Acqua pulita, depurata con l’allume della Commissione.
E così mangiamo insieme, sul limitare del boschetto dietro la pieve.
– Tira vento. – dico. – Perché non entriamo in chiesa?
– E’ pericoloso, là dentro. C’è Dio. Qui fuori siamo al sicuro.
Accetto la risposta, senza chiedere ulteriori spiegazioni.
– Stai tornando a casa tua? – domanda Matteo. Il consigliere comunale che stava per uccidermi ha voglia di parlare.
– Sì. Vicino a Bologna. Casalecchio.
– Fino a Casalecchio a piedi?
– Dopo Ferrara circola qualche mezzo. E tanti cavalli. Chiederò un passaggio, come per venire qui. In un campo ho visto mongolfiere ancorate. Vedrò se si possono usare, sarebbe ancora meglio.
– Non c’è più nessuno che spara ai palloni?
– Penso di no. Succedeva solo ai primi tempi.
– E hai soldi per il passaggio?
– Quelli ormai servono a poco. La Commissione li cambia in voucher, ne ho qualcuno. Per un po’ ci concentriamo sul cibo, le mandibole lavorano, la lingua mescola, si attivano i succhi gastrici.
– Per Ferrara sei passata?
Il sogno di qualche notte fa. Città irreale. In mezzo alla nebbia scura di una mattina d’inverno, un fiume di gente passa sulle Mura e sono davvero tanti, più di tutti i morti di ogni tempo. Tengono bassi gli sguardi e ogni tanto sospirano. Cavalcano il
Montagnone e poi giù per Alfonso d’Este, fin dove il Po di Volano passa sotto il ponte. Vedo uno che conoscevo, e lo chiamo: “Rizzi! Tu eri con me a Udine, davanti al monumento ai caduti. Il cadavere che hai sepolto nell’orto ha cominciato a buttare le gemme? Secondo te farà i fiori, quest’anno? Oppure la ghiacciata ha rovinato il giardino? Mi raccomando, tieni lontano il cane. Quello scava, gli uomini gli piacciono!”
– …per Ferrara sei passata? Io non ci vado da otto anni, e sono solo venti chilometri.
– Sì, ma non mi sono fermata. Mi hanno detto che è pericolosa.
– L’ultima volta che ci sono stato, – riattacca Matteo – la Crisi era molto recente. Al mercato nero, benzina ne trovavi ancora, e sono andato in motorino a vedere il Petrolchimico. Era tutto un viavai di funzionari della Commissione, capirai, tutte quelle sostanze tossiche, pronte a sversarsi e far morire tutto… Gli impianti reggevano, e ho sentito che resistono ancora oggi. Un po’ di produzioni erano già dismesse prima della Crisi, e quella
volta mancavano già un tot di silos, pieni di ammonio o non so che. Portati via, chissà dove.
– In Africa, mi sa.
– Eh, già. – dice, ma non aggiunge nulla.
Seguono minuti di pace, dai pori essuda la stanchezza, i muscoli spurgano tossine, e anche la mente si ritempra. La vista si aguzza e le orecchie cessano di ronzare. Il compagno di pranzo mi lancia occhiate, ma sono io la prima a riprendere il discorso.
– Hai detto che qui la gente si organizza. Raccontami: cosa fa un consiglio comunale?
– Bah. – dice in un piccolo scoppio. – Non molto. Decide come distribuire gli aiuti, raduna i volontari per estirpare le erbacce dai campi… Scrive ai parenti dei morti… Io facevo il carabiniere, si vede, no? Quando è scoppiata la Crisi ero a Cosenza. Per tornare
ho preso un treno come quelli che vedevi nei documentari, tipo in India, con la gente anche sul tetto… Ci ho messo due giorni, si fermava in paesini che non avevo mai sentito nominare… Tu che lavoro facevi?
L’altro sogno ricorrente. Ho ventotto anni, sto scrivendo il mio primo romanzo. Racconta la vita di giovani seminaristi negli anni del Concilio Vaticano II. I loro amori proibiti, le dispute
teologiche, i loro conflitti, la morte di uno di loro. Vengono da famiglie contadine, devote ma non troppo, e devo dipingere uno sfondo di religiosità popolare. Mi serve la dimensione
“antropologica” dei cambiamenti avvenuti allora. In realtà sto prendendo due piccioni con una fava, perché uso i materiali della mia tesi di laurea. Non si butta mai via niente.
Nel sogno, chissà perché, incontro le persone intervistate tre anni prima. Mi raccontano tutto, di nuovo, da capo, contente come sono di vedermi. Mi congedo da loro soddisfatta, conscia che sarà un bel libro, poi… Scopro che, dietro di me, ogni volta arranca lei, la Storica. Morde la mia polvere, ma sono sempre io. Ho ancora venticinque anni e sono indietro con la tesi. Arrivo tardi e nessuno vuol più parlare con me, perché sono gia stata li.
– …lavoro facevi?
– La scrittrice. – rispondo a Matteo.
– La scrittrice? E cosa scrivevi?
– Romanzi. O almeno li chiamavano così.
– Romanzi. – E si ferma a pensare. – Ne leggevo anch’io, ma scritti da donne mi sa di no. Leggevo polizieschi, roba così.
– Sì, prima della Crisi andavano molto. Ma oggi, chi li leggerebbe?
– E’ vero. Adesso cosa fai?
Le parole precedono il pensiero: – Faccio ancora la scrittrice, in un certo senso, però non scrivo più.
– Che strana frase. Cosa vuol dire?
– Che oggi non scrivo: vedo.
– In che senso?
– Il futuro. Vedo il futuro.
Pausa.
– Sei… com’è che si dice… un’indovina?
– Non so se è quella la parola.
– Però vedi il futuro. E’ per quello che hai evitato la randellata?
E allora sai dirmi cosa ci aspetta?
– No. No a entrambe le domande. Non mi occupo di futuro spicciolo.
– “Spicciolo”. Tu parli e io non ti capisco. E che strano verbo, “occuparsi”… Non lo sentivo da un sacco di tempo.
– Sì, mi occupo di qualcosa. Del futuro anteriore. Quello che viene dopo il futuro spicciolo. Lo vedo e lo racconto.
– A chi?
– Ho una famiglia, e molto numerosa. Racconto il futuro anteriore, insieme lo vediamo, e tutti stiamo meglio. Dipendono da me, e sto tornando da loro.
– Mi sembra giusto. – commenta. – Insomma, ti sei presa, mmm, una vacanza. Lo so che la parola non è quella, voglio dire che avevi bisogno di staccare un po’, di vedere il posto dove sei nata, è così?
La semplicità che era difficile a dirsi.
– Sì. E’ proprio così. – Poi, saltando mille passaggi: – Ti ricordi come si dice in ferrarese “cinciallegra”?
Matteo non sembra sorpreso. Tace, si concentra. Guarda i rami degli alberi e il tetto della pieve. Si alza in piedi, beve un sorso dalla borraccia e cammina in tondo, lento. Lentissimo. Io non ci sono più, è perso nei ricordi d’infanzia. Nemmeno i suoi, probabilmente: quelli di sua madre. Quelli di sua nonna, e più in là. Infine si blocca e spalanca gli occhi. Punta in alto l’indice della destra, rigido e diritto come l’asta di una bandiera. Si gira verso di me ed esclama:
– Arzestula! Ma perché me l’hai chiesto? C’entra col futuro anteriore?
E in quel momento la sentiamo, l’Arzèstula, e la vediamo anche, sul ramo di un frassino spoglio dietro la pieve. Gialla e nera, perfetta nella forma, struggente meraviglia dell’Evoluto.
Restiamo a bocca aperta, qui, adesso.
Racconto apparso nell’antologia “Anteprima nazionale. Nove visioni del nostro futuro invisibile.” A cura di Giorgio Vasta, Minimum Fax, Roma 2009.
© 2009 by Wu Ming 1, [vedi]