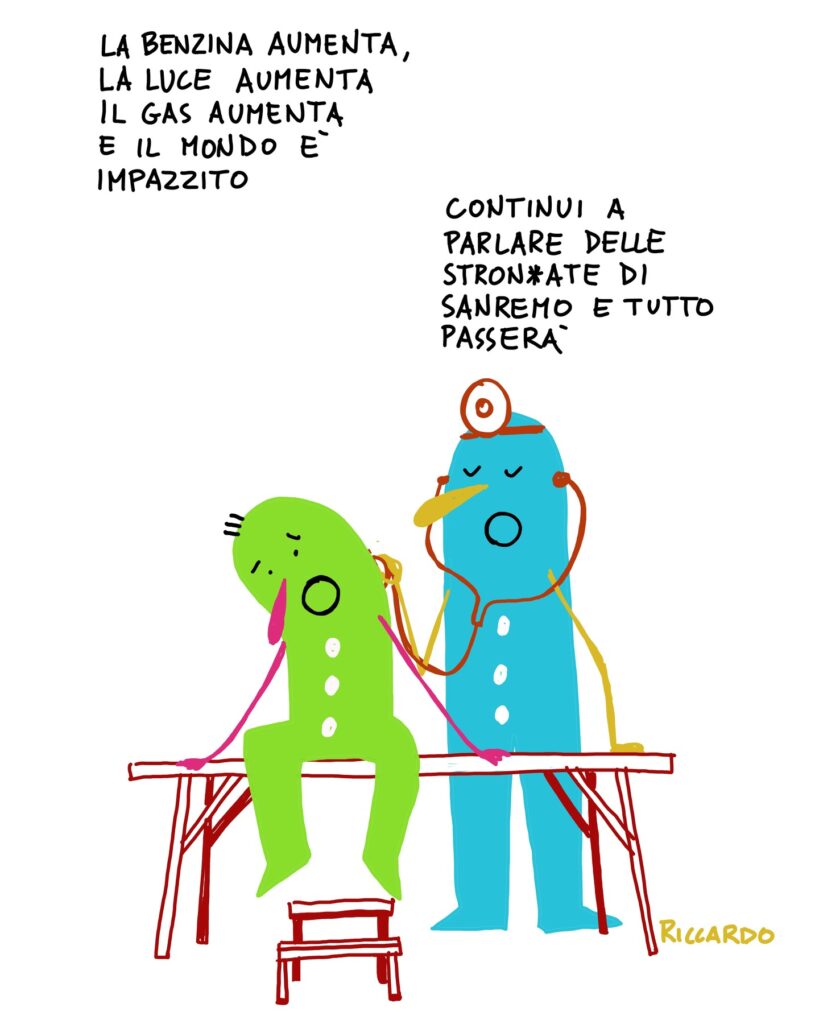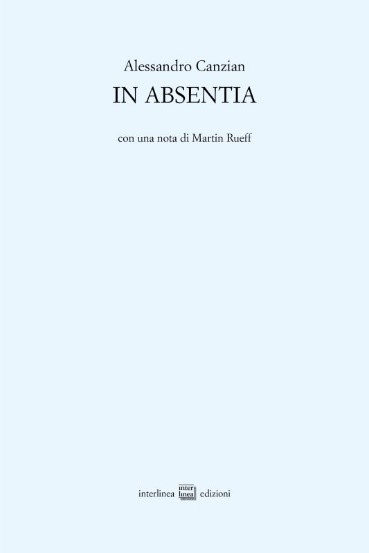Sabato 15 febbraio, 2025 alle ore 11:30 al Museo Internazionale della Maschera “Amleto e Donato Sartori” si inaugura con il patrocinio del Comune di Abano Terme, Provincia di Padova la mostra “MASCHERE E VOLTI DIETRO LE SBARRE” a cura di Paola Pizzi, Sarah Sartori e Walter Valeri, in collaborazione con Balamòs Teatro APS, diretta dal regista e pedagogo teatrale Michalis Traitsis responsabile del progetto teatrale Passi Sospesi con la collaborazione artistica di Patrizia Ninu, attivo dal 2006 negli Istituti Penitenziari di Venezia (Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, Casa Circondariale Maschile Santa Maria Maggiore, Casa Circondariale SAT di Giudecca, attualmente chiusa) col contributo della Regione Veneto e Comune di Venezia.
La mostra è composta da maschere realizzate dai detenuti del carcere maschile di Padova alla fine degli anni ’80, e documenti realizzati nel corso degli anni successivi: servizi fotografici, video, locandine del progetto teatrale Passi Sospesi. Tutti i percorsi laboratoriali, gli spettacoli, le iniziative collaterali esposti, sono stati documentati con il materiale fotografico di Andrea Casari e video di Marco Valentini, presentati in numerose rassegne, mostre, iniziative, convegni, in Italia e all’estero.
A partire dagli anni Ottanta il teatro in carcere – già presente in alcuni istituti con attività amatoriali o tradizionali – ha assunto significati importanti, metodologie sperimentali e obiettivi che si sono consolidati nel tempo, esprimendo delle vere e proprie eccellenze in Veneto. “Ricordo come fosse ieri il volto del direttore, il personale di custodia in apprensione, gli operatori penitenziari entusiasti, l’impegno straordinario dei detenuti nel costruire le loro prime maschere originali. La gioia nel vedere che ce l’avevano fatta!”, afferma Paola Piizzi, direttrice del Museo.
Col passare degli anni il Teatro in carcere ha posto sempre di più l’accento sull’esperienza, sulla pratica teatrale, sull’attività diretta e laboratoriale dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica del palcoscenico, piuttosto che sul mero spettacolo di intrattenimento. Oggi quest’esperienza espositiva, aperta al pubblico, ai giovani e alle scuole, si configura come una pratica formativa importante e consolidata, che aiuta la riscoperta delle capacità e sensibilità personali dei carcerati, con modalità umane, operative ed espressioni educative specifiche, all’interno degli Istituti di pena; dove la ragione intima di ogni intervento artistico rimane il detenuto e il suo benessere. Il Centro Maschere e Strutture Gestuali di Abano Terme, fondato e diretto da Donato Sartori, è stato il primo in Italia e in Europa a realizzare un laboratorio teorico-pratico di maschere create dai detenuti, alla fine degli anni ‘80. Quel seminario, protratto nell’arco di due anni, si è poi concluso con uno spettacolo memorabile dal titolo Non basta dire, testi e musiche di Alberto Todeschini. Rappresentato all’interno del carcere di Padova il 27 gennaio 1990 e, successivamente, con gli stessi detenuti-attori il 31 marzo all’esterno del carcere, nell’ambito della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Padova e da Arteven.
Certo da allora molte cose sono cambiate, non sempre in meglio bisogna dire, ma i filmati, i gesti, le maschere, lo spettacolo a cui hanno dato vita i detenuti in quell’esperienza pilota di Padova e, negli anni successivi a Venezia, sono i protagonisti indiscussi e sorprendenti di questa bella mostra che è costata mesi di lavoro. “Rappresentano la creatività nata dietro le sbarre, per dar voce e dignità ai detenuti, a sé stessi, al proprio dolore, alle proprie future speranze. E’ l’inizio di una volontà di cambiamento che va festeggiata.” Dice il poeta e drammaturgo Walter Valeri. Unica e rara nel suo genere la mostra “Maschere e volti dietro le sbarre”, realizzata con coraggio dal Museo Internazionale della Maschera e Balamòs Teatro, è l’incipit, la memoria delle origini del teatro in carcere, congiuntamente ad un’aggiornata testimonianza di collaborazione con gli Istituti Penitenziari di Venezia al servizio della cultura e della società civile.
La mostra è gratuita e resterà aperta sino a domenica 6 aprile 2025. Nel corso della mostra è previsto un fitto calendario di incontri, testimonianze, dibattiti e filmati.
Maschere e Volti
di Domenico Giuseppe Lipani
Scriveva Montesquieu nei sui appunti di un viaggio da Graz a L’Aia che a Venezia la maschera “non è un travestimento, se mai un incognito”: non un modo per contraffarsi in un altro, ma per non sembrare nessuno. E così essere liberi dall’individuo che si è (o quale dagli altri è riconosciuto), per divenire soggetto libero di agire, non nascosto bensì protetto dalla maschera. Insomma, la maschera ha a che fare con l’identità in una maniera più profonda della semplice negazione, perché ne è in una certa misura complemento, spazio possibile di una sua affermazione, complice del soggetto agente.
Questa mostra mette insieme maschere e volti, mediati e riuniti dal lavoro teatrale in carcere, ossia dal tempo dell’azione libera in uno spazio di privazione.
In queste maschere e in questi volti cosa vediamo? Cosa siamo capaci di riconoscere? Quale risposta sappiamo dare al loro sguardo interrogante?
Il volto dell’altro, secondo Levinas, ci interpella, ci mette in questione, ci chiama a rispondere: in questo senso ci rende responsabili. La richiesta di relazione, che il volto altrui ci impone nella sua incommensurabilità e nella sua totale trascendenza, mette in discussione il Me, le sue certezze e le sue pretese di autosufficienza: l’incontro con il volto dell’altro ci obbliga a uscire da noi stessi.
In questo senso il lavoro teatrale in carcere è la costruzione di uno spazio proprio in cui si riacquista un volto, volto come visum cioè sguardo e immagine – così come vediamo in queste fotografie – ma anche volto come splendore e come – etimologicamente – desiderio. Il volto dell’allievo ricostruito ad arte, cioè con la consapevolezza del suo intento espressivo, lo restituisce alla sua natura di soggetto di desiderio, togliendolo dall’unica dimensione reificante di oggetto di trattamento. L’aspetto che mi pare utile sottolineare sta nella dimensione “artificiale”, cioè a dire artistica, di questo processo. Si restituisce un volto alla persona grazie alla maschera teatrale, sia essa oggetto materiale o metafora del personaggio che agisce, sottraendolo alla maschera sociale che invece nega e occulta. Attraverso la maschera teatrale rivelo l’altro in me e vedo l’altro davanti a me.
Diversamente dalla dimensione ludico-rituale del teatro, le maschere fuori di esso sono oggetti che nascondono e annullano. Il carcere stesso è una maschera del controllo sociale. Dietro di esso scompaiono le vite, i dolori, le fatiche, le aspirazioni. Il potere che vi si esercita mira alla frammentazione di ogni identità o alla sua riduzione a poche, controllabili dimensioni. Il lavoro teatrale negli spazi di reclusione mira a ricomporre questa frammentarietà verso una molteplicità di tanti sé possibili. Osare immaginarsi altro, per arricchire ed espandere – il teatro sì! deve essere uno spasso! – le possibilità della persona.
Il teatro in carcere è ormai una realtà riconosciuta e diffusa, sia sul versante artistico che su quello istituzionale. In Italia nel 2021 su circa 230 istituti di pena ci sono state esperienze teatrali in almeno 127 di essi. Alcune di queste esperienze sono ormai radicate da molti anni, lavorano con continuità e vivono una situazione di riconoscimento formale da parte dell’istituzione carceraria, altre sono ancora estemporanee e vengono attivate di volta in volta sul singolo progetto.
Si tratta di attività che si situano in una posizione ibrida tra lavoro artistico e processo rieducativo, o come viene detto in termini burocratici dalla legislazione italiana ‘trattamentale’. La possibilità stessa di entrare nelle carceri con progetti teatrali si deve storicamente alla legge Gozzini del 1986, che aveva lo scopo di valorizzare l’aspetto rieducativo della pena rispetto a quello meramente esecutivo, in accordo con l’art. 27 della Costituzione italiana. Ciò permise al teatro, che era già presente, salvo poche eccezioni, per lo più con esperienze di carattere amatoriale, di entrare negli istituti di pena grazie al lavoro di registi e compagnie professionistiche. Nel giro di pochi anni si disegna una mappa articolata di esperienze, che di fatto dà vita ad un nuovo teatro, con caratteristiche diverse da un artista all’altro ma con taluni orientamenti e sviluppi condivisi.
Se da un lato l’amministrazione carceraria sottolinea l’aspetto trattamentale ed educativo delle esperienze, dall’altro gli operatori teatrali tendono per ovvie ragioni a mettere in risalto il lato propriamente artistico. Talvolta si tende a depotenziare il lavoro teatrale riducendo l’artista alla sola dimensione di operatore sociale/culturale, non riconoscendo le linee di ricerca sui linguaggi artistici, il loro collocarsi dentro un più generale sviluppo del teatro contemporaneo, la qualità estetica del lavoro.
Sembra di essere davanti ad una contraddizione insanabile, tra chi legge il senso di queste operazioni in chiave prettamente sociale/educativa e mette in evidenza soprattutto il fine etico e terapeutico delle prassi e chi lo legge in chiave prioritariamente artistica rilevando come l’utilità sociale sia direttamente proporzionale – e conseguente – alla qualità artistica e all’efficacia estetica. Questa contraddizione, forse solo apparente, attraversa più o meno tutti gli ambiti di quello che in Italia va sotto il nome di teatro sociale, e nei paesi anglofoni è più diffusamente chiamato applied theatre.
Certo le differenze ci sono e non sono riassumibili in una mera questione di generi artistici. Il teatro di interazione sociale non è un genere teatrale, dentro un sistema estetico di generi. Come affermava tempo fa Richard Schechner: “We do not deny either the social aspects of aesthetic theatre or the aesthetic aspects of social theatre but rather point out differences of purpose, audiences, venues, and production values”[1].
Ritengo personalmente che questa contraddizione sia solo superficiale e che solo la qualità di un lavoro artistico assoluto e puntiglioso, “monacale”, può garantire adeguate ricadute su tutto il sistema carcere. Non si tratta di semplice trattamento, dunque, di un’attività educativa tra le altre, o peggio di in-trattenimento, si tratta piuttosto di uno sguardo trasformativo attraverso il teatro, che si situa in uno spazio terzo, sospeso, non connivente con l’istituzione né banalmente complice con le aspettative dei detenuti. Un teatro che è essenzialmente politico perché, come spiega Hannah Arendt, crea un’occasione e uno spazio di libertà, di “utopia della polis”[2], dentro il carcere che dell’utopia è l’antinomia. E dunque un teatro che si situa lungo linee di sviluppo che hanno caratterizzato la ricerca artistica già dalle rivoluzioni novecentesche, e dalla loro conseguente dilatazione dell’agire teatrale, di quei teatri fuori dal Teatro, come li definì Fabrizio Cruciani. E che rispetto a quelle tendenze non si è acquietato nel sistema economico/istituzionale del teatro stesso, nelle sue propaggini burocratizzate dei teatri nazionali o in quelle a volte troppo autoreferenziali del teatro di ricerca. Ma ha cercato, cerca ancora, nella dimensione costretta del carcere di mantenersi fedele all’idea, che fu già di certe illuminanti esperienze di metà Novecento, di un teatro d’arte per tutti[3].
Il progetto in carcere “Passi Sospesi” di Balamòs Teatro, di cui in questa mostra si possono vedere materiali e fotografie, non prevede solamente l’attivazione di percorsi teatrali, con laboratori e produzione di spettacoli ma un’offerta culturale ampia, che include incontri con importanti maestri del teatro, del cinema e della cultura contemporanea. Un percorso formativo a tutto tondo, per fare del carcere un luogo veramente riabilitativo. Inoltre, lavorando contemporaneamente anche all’Università, nelle scuole e nei percorsi di salute, Balamòs Teatro e il suo direttore artistico, Michalis Traitsis, hanno contaminato più volte i diversi percorsi creando occasioni di incontro tra i diversi gruppi, facendo venire in carcere bambini delle scuole primarie e studenti universitari e, quando possibile, inserendo gli allievi-detenuti nei progetti fuori dal carcere. Gli incontri vengono costruiti nel tempo con la pratica continua del laboratorio, costruendo una lingua comune, grazie ad una coerente disciplina teatrale. Si sono create così le condizioni di potersi riconoscere nel lavoro e attraverso di esso.
Un laboratorio teatrale in un carcere trascende il semplice dato del lavoro attraverso le tecniche del teatro e incide profondamente sulla costruzione delle persone attraverso il frame di interazione sociale in cui si trova immerso e da cui ricava il senso stesso della sua identità. Se la costruzione del sé passa attraverso un processo di negoziazione con l’altro e dal riconoscimento reciproco, inutile sottolineare come dentro l’istituzione totale questa negoziazione è costretta dentro i vincoli di etichette rigide, che segnano norma e devianza e per la quale il detenuto è fissato nell’unico ruolo di criminale, e l’unica relazione possibile con lui è data dal controllo e dalla privazione. Un detenuto è in prima istanza qualcuno che non dispone di uno spazio e di un tempo propri, e dunque non dispone di un proprio vissuto. La sua vita è regolata burocraticamente. In questa unica dimensione consentita la sua identità viene destrutturata e vengono innanzitutto compresse le necessità relazionali del sé. Le stesse istanze rieducative, proprio in quanto ‘ri-educazione’ sono in realtà la definizione di una norma da ristabilire e di una devianza dalla norma. E in questo la stessa rieducazione non mette al centro l’individuo con la sua specificità ma la norma stessa. Il laboratorio teatrale, al contrario, comporta la centralità della persona e delle sue necessità relazionali e in esso la dimensione performativa si fa pratica del sé. Il laboratorio è prima di tutto un ethos, cioè prima ancora che un set di valori, un luogo reale e metaforico da abitare: da cui ci si può allontanare e a cui si può tornare. In una prospettiva goffmaniana non sono gli stati interni dell’individuo che determinano il senso della sua azione ma i frames metacomunicativi. Se la cornice del carcere definisce l’identità del carcerato, il laboratorio teatrale è in prima istanza la creazione di una cornice nuova, uno spazio dentro al carcere che non è carcere e nel quale pertanto i partecipanti sono altro e ricostruiscono attraverso la performance la pienezza di un nuovo sé. Come dice il Marco Polo calviniano a Kublai Khan a proposito dell’inferno dei viventi: «cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».
Per far ciò il laboratorio teatrale funziona in prima istanza come strumento che accresce la consapevolezza delle proprie possibilità espressive e la percezione di sé come soggetto portatore di messaggio, soggetto responsabile, che può responsare. In secondo luogo, il laboratorio si fa strumento di rilettura della propria biografia, grazie ad una drammaturgia delle necessità degli individui, che permette ad un tempo di narrare sé stessi – di identità narrativa parlava Ricouer – e immaginarsi come altro da sé. Decolonizzare l’immaginario dalla sola dimensione della maschera istituzionale e mettersi nei panni altri, per accettare la molteplicità delle identità che ognuno di noi può accogliere.
Il lavoro teatrale si struttura come una sorta di itinerario da dentro a fuori, per giungere ad un’espressione formalizzata nello spettacolo, come momento privilegiato di incontro con l’altro.
Quando parliamo di spettacoli, tuttavia, dovrebbe essere chiaro che stiamo parlando dell’esito di un percorso, determinato dalla qualità del percorso stesso e dai materiali creativi ed emotivi che il gruppo ha messo insieme, costruendo una propria identità collettiva a partire dal laboratorio. Non si tratta mai di progetti pensati a monte, facendo calare dall’alto un testo o un’idea di spettacolo, ma di trovare una via comune che possa favorire maieuticamente l’espressione di sé. In questo processo si può incontrare materiale drammaturgico strutturato, come nel caso delle Troiane di Euripide, messo in scena nel 2012 e ripetuto poi altre volte fuori e dentro il carcere, o si possono montare insieme materiali disparati, in parte autoprodotti in parte suggeriti dal conduttore e ricavati da testi pre-esistenti come nel caso di Cantica delle donne, uno spettacolo del 2016, che ha avuto diverse repliche fuori dal carcere, in teatro e all’Università di Ferrara. Il processo che porta allo spettacolo è sempre fondato su una dimensione dialogica tra individuo, gruppo, regista. E assume un contorno preciso dato dall’apporto peculiare che ogni singolo può dare al lavoro, ridefinendo di volta in volta la propria identità nello spettacolo, grazie al riconoscimento del gruppo prima e della comunità degli spettatori dopo. Bisogna trovare il proprio respiro nei materiali espressivi e trovare con i compagni e con gli spettatori un respiro condiviso. Si tratta di opere a struttura aperta, i cui partecipanti possono variare – uno dei principali ostacoli in una casa circondariale è la difficile stabilità del gruppo: per motivi di esecuzione della pena, gente sempre diversa entra o esce dal carcere in un continuo turnover. Lo spettacolo, quindi, cambia insieme alle persone che vi prendono parte. I frammenti si ricompongono, dentro un canovaccio di massima.
In questa maniera era costruito, ad esempio, Cantica delle donne, in cui frammenti poetici, danze e canti di donne venivano consegnati allo spettatore sotto forma di lettera. Frammenti propri e altrui, che diventavano lo strumento di una comunicazione di sé pienamente autentica. Attraverso la mediazione dell’espressione poetica – fisica, coreutica e verbale –, da un lato si protegge l’intimità del dato biografico, dall’altro gli si dona un senso più grande, capace di traghettare le persone oltre il dolore che sono state, verso la bellezza che possono essere.
Diceva Kantor che il teatro è «il luogo che svela, come un guado segreto nel fiume, le tracce di un passaggio dall’altra riva alla nostra vita»[4]. Questo è stato il laboratorio per gli allievi del laboratorio in carcere di Balamòs Teatro, un guado dalla vita frammentata del detenuto alla pienezza di un sé da costruire giorno dopo giorno.
[1] J. Thompson, R. Schechner, Why «Social Theatre»?, in «TDR», XLVIII/3 2004, p. 11.
[2] Sulla politica come spazio di libertà, vedi H. Arendt, Che cos’è la politica?, Edizioni di Comunità, Milano 1995.
[3] Mi riferisco ovviamente al Manifesto del Piccolo di Grassi e Strehler.
[4] «The place that reveals – as some fords in the river do – the traces of transition from “that other side” into our life» (T. Kantor, A journey through other spaces: essays and manifestos, 1944-1990, University of California Press, Berkeley 1993, p. 146).
In copertina: foto di Andrea Cesari, progetto Passi Sospesi di Balamos Teatro