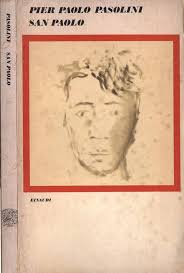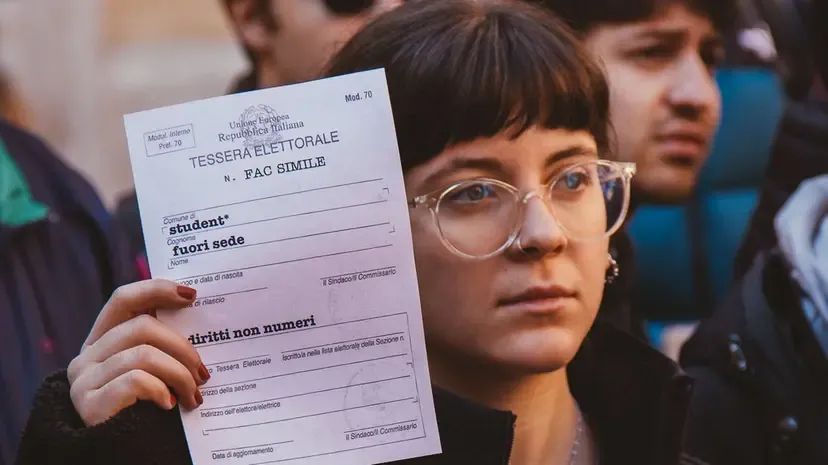Presto di mattina. Ispirazione, pietra e porta
Le Beatitudini per rincuorare e ravvedersi
Alla messa vespertina di due sabati fa a S. Francesca vi erano insieme scout e lupetti del Ferrara 5°, i grandi e i piccoli proprio in prima fila. Al vangelo erano di scena le beatitudini secondo Luca. Gesù rivela alla folla radunatasi nella pianura chi, agli occhi del Padre suo, fossero da considerarsi felici e chi invece sfortunati: Beati voi… poveri affamati piangenti e perseguitati. Guai a voi… ricchi, sazi, gaudenti, e davanti a tutti i lodati − perché Dio ha scelto da che parte stare e veglia − ha riconosciuto i suoi familiari, gli eredi come il Figlio del regno.
Nella prima lettura poi si parlava del tamarisco nella steppa dalla nerissima scorza, che quando vede venire il bene non lo riconosce perché come chi confida solo in se stesso non ha occhi se non rivolti verso se stesso, dallo sguardo tenebroso. Si diceva poi dei confidenti in Dio, di coloro che hanno in lui l’unica risorsa, attendono da lui aiuto. A differenza del tamarisco, questi sono detti simili agli alberi piantati lungo corsi d’acqua, verso cui stendono le radici. Non hanno paura del caldo, rimangono verdi le loro foglie anche nella siccità, continuando a produrre frutti.
Così coloro che vengono messi in guardia: “guai a voi”, coloro che tengono lontano il cuore da Dio e confidano solo nei loro simili hanno la loro controfigura e di che specchiarsi nel tamarisco per rinsavire; gli altri sono rincuorati e consolati per riconoscersi negli alberi che daranno frutti a suo tempo.
L’ispirazione da chi ti è venuta?
L’omelia, una manciata di minuti, ma per dire cosa? E da dove iniziare? Sono rimasto nell’inquietudine e nell’attesa ascoltando il diacono proclamare il vangelo dall’ambone. Poi, inattese, non so da dove sono emerse le parole del libro di Giobbe: «A chi hai rivolto le tue parole e l’ispirazione da chi ti è venuta?» (26, 4)
Ed ecco, come un vagito nascente l’assist che aspettavo: Ispirazione, il soffio che ha increspato le vele verso il largo.
Così ho domandato: «Secondo voi da dove nasce la poesia?» La prima risposta scontata, provocando ilarità nell’assemblea, è stata: «dal poeta». In risposta ho rilanciato con un’altra domanda: «e da dove viene nel poeta la parola?» E, dopo convulsi sommovimenti di grandi e piccoli e mani alzate tra i banchi arriva, quasi una piccola ‘ola’, anche la riposta: dall’ispirazione.
Così sospirando continuai: «Ma da dove sono venute a Gesù le beatitudini: Ispirazione, ispirazione, ispirazione…» fu, scontata, la risposta quasi corale. Insistetti ancora: «ma cos’è l’ispirazione?» E di nuovo silenzio: «da dove deriva questa parola?», come lanciando una cima di salvataggio. «Da spirare dice uno, respirare un altro e soffiare anche; dal soffio dello spirito» disse alla fine un quarto.
«Sì è proprio così» risposi subito, lo spirito che dimorava in Gesù, che sussurrava al suo cuore e abitava i suoi pensieri, animando il suo corpo e lo stesso che ha fatto gemmare le beatitudini, lo stesso Spirito del Padre suo, Spirito d’amore che li tiene uniti e che anche stasera si è riversato, spirando su di noi come onde miti sulla vela”. E la barca, quella sera, aveva raggiunto l’altra sponda del lago.
L’ispirazione: sconosciuta fonte
L’ispirazione per il poeta non è emozione effimera o esercizio di fantasia ma conoscenza, un sapere oltre, specchio riflettente di ciò che è inabissato nelle profondità del reale e dentro di lui. È sommovimento improvviso della coscienza e insieme dell’immaginazione, che determinano una scoperta, un dis-velamento seguito da un capovolgimento di prospettiva, un inatteso orizzonte, che è straniamento e poi familiarità del sentire come un vuoto nel pieno dapprima e nell’assenza intravede infine affiorare una presenza.
L’ispirazione messaggera dello spirito è come il vento «soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito» (Gv3,8). L’ispirazione è portatrice del Pneuma, lo Sconosciuto dentro e oltre noi stessi. Essa avvicina al fondo della realtà, al fondo dell’abisso che è l’altro, un abisso al pari di te: svelamento e velamento insieme: una ri-velazione appunto.
L’ispirazione è creatrice di parole primigenie direbbe il teologo Karl Rahner, matrice misteriosa, perché attinge alla loro essenza, al lievito madre dello spirito, generando parole in azione che danno forma a ciò che non ha forma, parole in presenza come traccia, impronta dell’indicibile.
«Se vuoi trovare la sorgente,
devi proseguire in su, controcorrente»
Bracconiere come Michel de Montaigne, (1533-1592), scrittore del Rinascimento francese, anch’io vado cercando parole d’altri e, citando un suo aforisma, dico: «Faccio dire agli altri quello che non so dire bene, talvolta per la debolezza del mio linguaggio, altre volte per la debolezza della mia intelligenza».
Così mi sovvengono le parole di Karol Wojtyla: «L’ispirazione, in maniera più o meno oscura, conduce il poeta e l’artista su quell’orlo abissale al mistero della tua scaturigine… Se vuoi trovare la sorgente, devi proseguire in su, controcorrente» (La sorgente, in Giovanni Paolo II, Trittico romano. Meditazioni, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 2003, 15).
Nel suo Discorso agli artisti: “A quanti cercano nuove epifanie per farne dono al mondo” (4 aprile 1999) il papa poeta così scrive: «La Sacra Scrittura è diventata così una sorta di “immenso vocabolario” (P. Claudel) e di “atlante iconografico” (M. Chagall), a cui hanno attinto la cultura e l’arte cristiana.
Lo stesso Antico Testamento, interpretato alla luce del Nuovo, ha manifestato filoni inesauribili di ispirazione… Ogni autentica ispirazione, tuttavia, racchiude in sé qualche fremito di quel “soffio” con cui lo Spirito creatore pervadeva sin dall’inizio l’opera della creazione.
Presiedendo alle misteriose leggi che governano l’universo, il divino soffio dello Spirito creatore s’incontra con il genio dell’uomo e ne stimola la capacità creativa. Lo raggiunge con una sorta di illuminazione interiore, che unisce insieme l’indicazione del bene e del bello, e risveglia in lui le energie della mente e del cuore rendendolo atto a concepire l’idea e a darle forma nell’opera d’arte. Si parla allora giustamente, se pure analogicamente, di “momenti di grazia”, perché l’essere umano ha la possibilità di fare una qualche esperienza dell’Assoluto che lo trascende» (nn. 5; 15).
Ispirazione:
carezza dall’altra parte,
sommovimento di gestante,
pietra tombale divelta.
È quel soffio lieve che increspa l’orizzonte del silenzio, così il cammino delle parole ripiglia, anche se è notte. È quel sommovimento di linfa che preme, gemme spinte fuori dal solco di dura corteccia anche se è inverno ancora. Ispirazione è quella pietra tombale divelta delle parole sepolte, dall’altra parte lo sguardo del loro volto pasquale.
Una carezza disfìora
la linea del mare e la scompiglia
un attimo, soffio lieve che vi s’infrange e ancora
il cammino ripiglia
(E. Montale, Ossi di seppia, Einaudi, Torino 1943, 103).
Sotto le scorze, e come per un vuoto,
Di già gli umori si risentono,
Si snodano, delirando di gemme:
Conturbato, l’inverno nel suo sonno
(G. Ungaretti, Vita d’uomo. Tutte le poesie, Mondadori, Milano 1996, 157).
Dall’altra parte della mano tesa
Del petalo della foglia della rosa
Dell’aria azzurrina e del nembo
Del fulmine sghembo tra la pioggia
tutto è pazienza e attesa
che ribalti la pietra pasquale
il lato tombale delle cose
dall’altra parte il vero disegno
il volto luminoso
il regno il regno il regno!
(B. Cattafi, “Dall’altra parte”, in Tutte le poesie, Le Lettere, Firenze, 2020, 422).
È soffio di conchiglia
È l’ispirazione “soffio di conchiglia” per usare un’immagine ungarettiana che dà corpo all’infinito mistero. L’immagine esprime bene il pensiero di Karl Rahner (1904-1984) per il quale la conchiglia è simbolo efficace per dire «l’infinità presente nella finitudine della parola… L’intuizione sensibile guida non alla definizione delle cose, cioè alla conoscenza scientifica, ma verso una intensa evocazione, verso una conoscenza simbolica e dunque più «oscura».
Così commenta Antonio Spadaro introducendo i diversi saggi dedicati da Rahner alla poesia e alla parola poetica, ora raccolti in una nuova edizione: L’arte della Parola. Opere scelte, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, [MI] 2024, 32-33).
Scrive Rahner: «Il cristiano dunque, quale parola deve essere abilitato, esercitato e dotato di grazia ad ascoltare, per poter udire la parola del messaggio di Dio? Deve saper ascoltare la parola, attraverso la quale il muto mistero è presente, deve saper percepire la parola che colpisce il cuore nel suo più intimo, deve essere iniziato nella grazia umana ad ascoltare la parola che unisce e la parola che nel suo senso limitato e preciso è la corporeità dell’infinito mistero. Ma come si può chiamare una tale parola? Essa è la parola poetica; questo saper ascoltare è frutto dell’aver udito la parola poetica, alla quale l’uomo si abbandona in umile prontezza, affinché essa gli apra l’udito dello spirito e gli penetri nel cuore…
È vero perciò che la capacità e l’esercizio di percezione della parola poetica è un presupposto per sentire la parola di Dio. Può bene la grazia crearsi questo presupposto, ci possono ben essere molti uomini, ai quali la poesia dell’esistenza eterna penetra nell’orecchio e nel cuore soltanto nel messaggio cristiano, però tutto ciò non toglie, secondo la nozione acquisita, che il dire e l’ascoltare la poesia appartenga così intimamente all’essenza dell’uomo, che nel caso in cui questa capacità del suo cuore venisse distrutta, l’uomo non possa più ascoltare la parola di Dio in parola umana. Ciò che è poetico nella sua ultima essenza è presupposto per il cristianesimo…
Il coltivare la poesia è in ogni caso una parte dell’esercitazione al saper sentire la parola della vita e, viceversa, quando un uomo nel profondo del suo cuore impara ad ascoltare le parole del Vangelo veramente come parola di Dio, data da Dio stesso, allora incomincia a diventare un uomo che non può più essere completamente insensibile a ogni parola poetica» (ivi, 114-115; 117).
È pietra su cui edificare, porta per continuare oltre
 «Poesia come fedeltà all’ispirazione». È questa la traccia di fondo, l’itinerario carsico che sottende la poetica di Bartolo Cattafi (1922-1979). Ne è convinto Raoul Bruni nell’introduzione alle sue poesie, che rileva pure nell’autore un’idea di poesia come “condizione umana”:
«Poesia come fedeltà all’ispirazione». È questa la traccia di fondo, l’itinerario carsico che sottende la poetica di Bartolo Cattafi (1922-1979). Ne è convinto Raoul Bruni nell’introduzione alle sue poesie, che rileva pure nell’autore un’idea di poesia come “condizione umana”:
«La storia dei miei versi non può che coincidere con la mia storia umana… Quella del poeta è per me una pura e semplice condizione umana, la poesia appartiene alla nostra più intima biologia, condiziona e sviluppa il nostro destino, è un modo come un altro di essere uomini» (Tutte le poesie, VIII-IX).
Pietra bianca
conchiglia calcare
con teneri bordi di colore
che sorte e acrocoro mandano
a un livello di mare
nella vasta pianura
percorsa da opliti
marinai mercanti inconsapevoli
isola emersa
misconosciuta itaca
sotto i piedi d’un gregge polveroso
(ivi, 563).
La porta
Non posso ancora aprirla
non vedo il muro
il varco nei mattoni
il legno immateriale
la misteriosa maniglia.
Ad ogni sbatter di fronda
di ciglia
di finestre furiose
di chiarissima
onda
di pesce fuor d’acqua
d’ali sulla preda
con speranza mi volgo.
Che sia Tu ad aprirla
Nelle Tue cose?
(ivi, 644).
Cover: immagine tratta da https://pixabay.com/it/images/search/free%20image/
Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.











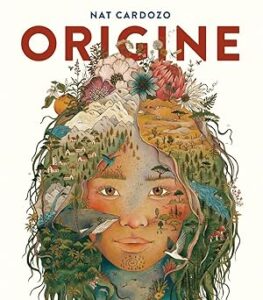








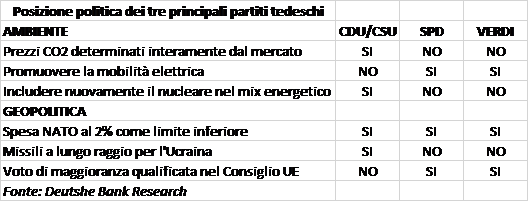




















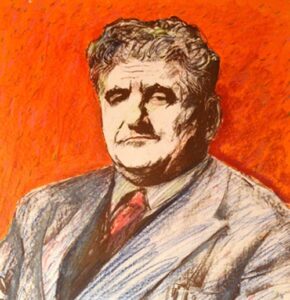


 usa
usa