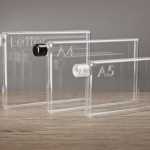La settima arte
snobbata dalla scuola
di Massimo Piazza, Direzione Cinema Mibact
“Piazza Cinema” è uno spazio in cui parlare della settima arte affrontando gli aspetti meno divulgati delle culture cinematografiche, dei problemi del settore e dei protagonisti attuali. E magari anche per divertirci un po’ insieme.
“È assolutamente evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita,
mentre la vita si ispira alla televisione” (Woody Allen)
Cinema “settima arte”, una frase conosciuta e usata come un mantra. Settima, sì, ma anche la più popolare, insieme alla musica. Un’arte che, nonostante la crisi del piccolo esercizio, offre un circuito di distribuzione e presenza ampio e capillare.
Eppure, quanta attenzione le viene dedicata dal nostro circuito di comunicazione mediatico, a parte il facile glamour dei red carpet e delle stelle e stelline? E, soprattutto, quanto spazio è dedicato dal nostro sistema educativo-scolastico alla conoscenza della storia del cinema?
La risposta è sotto gli occhi di tutti: l’insegnamento del cinema a scuola è saltuario, affidato alle iniziative dei singoli operatori didattici. Unici in Europa, i nostri programmi scolastici non prevedono forme di divulgazione della cultura cinematografica.
In tutto il mondo occidentale il cinema si studia nelle scuole, fa parte del patrimonio culturale comune, diventa strumento di crescita anche sociale e partecipativa; da noi invece no, in ossequio ad una concezione ancora elitaria, spesso passatista e appassita, della cultura, che trascura in particolare la formazione delle giovani generazioni, che potrebbero utilizzare e metabolizzare più facilmente e proficuamente questo strumento.
Tanto per dire, nel Regno Unito il British Film Institute agisce in sinergia con il sistema educativo, e l’insegnamento del cinema è presente, sia pure spesso in modo facoltativo, nei programmi scolastici, in particolare delle materie letterarie; in Francia il cinema fa parte dei programmi, facoltativi e obbligatori, di educazione ai media e alle materie letterarie, tanto che si stima che oltre il 10% degli studenti svolga sistematico apprendimento specifico in campo cinematografico. Anche in Germania l’apprendimento dei media, e nello specifico del cinema, è previsto nelle scuole di ogni ordine e grado. E così accade, in diverse modalità, in Spagna, nei Paesi Bassi, e a seguire negli altri Paesi dell’area occidentale.
In Italia, invece, il sistema scolastico è fermo a programmi e ispirazioni di 50 anni fa, prevede percorsi che vengono conclusi senza aver mai nemmeno sfiorato materie divenute nel frattempo fondamentali, come la conoscenza dei media e delle nuove tecnologie, dei meccanismi fondamentali dei sistemi e degli strumenti economici, delle principali culture internazionali, in particolare extra europee.
Così un giovane può concludere un percorso didattico nella più completa ignoranza dei rudimenti della storia del cinema e dei film, e perdere dunque tutto quel patrimonio che racconta le emozioni, le estetiche, gli stili, le tecniche e i contenuti del cinema.
Non parlare mai di Nascita di una nazione di Griffith, della “fantozziana” Corazzata, del neorealismo, o della nouvelle vague, è un po’ come ignorare la Divina Commedia, La Gerusalemme liberata, Leopardi e via dicendo. Non è un problema solo culturale, ma soprattutto una carenza che va a colpire un aspetto fondamentale, perché il cinema produce e materializza i canoni estetici ed espressivi che divengono il codice interpretativo delle realtà e dei tempi; il cinema è come uno specchio nel quale viene proiettata una immagine idealizzata, sintetica e simbolica, di una società o di un tempo; propone frammenti, schegge dei modi di vivere, di parlare, di muoversi, di vestire, ci parla e ci fa vedere luoghi e architetture sociali spesso scomparse; in sintesi potremmo dire che è un dispositivo del racconto storico-sociale, è la storia che racconta le nostre Storie.
Rappresenta le emozioni, le gioie, le paure, le sconfitte e le vittorie, vissute negli ambiti illuminati, ma anche in quelli oscuri, della nostra mente e della nostra psicologia.
E’ in sostanza uno strumento di conoscenza, razionale ma anche emozionale, indispensabile per la piena realizzazione di una personalità completa e matura.
Nonostante frequenti impulsi e richieste in tal senso, nel nostro paese niente si muove. Per ora vive l’auspicio che il prossimo ventilato intervento sulla scuola annunciato dal Governo comprenda anche questo aspetto, e che il Ministro della Cultura e del Cinema Dario Franceschini possa immaginare qualche percorso che porti più cinema di qualità nelle nostre scuole e ai nostri ragazzi, con particolare attenzione alle “periferie” sociali e urbane del nostro Paese.
Nell’attesa noi proviamo a fare divulgazione cinematografica a modo nostro, con una comunicazione creativa e partecipativa: qui a seguire un primo articolo e un test con cui il lettore potrà verificare la propria conoscenza della storia del cinema, indicando il film e se possibile il regista, senza che un esito non entusiasmante debba gettarlo nello sconforto: si può sempre recuperare.
E se invece le indovinerete tutte, non perdeteci di vista, perché dalla prossima volta andremo più sul difficile …
TEST DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
1) Due suonatori di jazz per sfuggire a una banda di mafiosi si travestono da donna
Risposta:
2) Una giovane donna ha un passionale incontro senza parole in un appartamento parigino
Risposta:
3) Un film americano racconta l’intreccio delle storie di vari personaggi nel corso di un festival di musica country
Risposta:
4) Una comparsa muore in croce per aver mangiato troppo
Risposta:
5) Due motociclisti attraversano gli USA per andare al festival di New Orleans
Risposta
6) Un film inglese del ’70 che tra i primi racconta in un drammatico crescendo un interno gay
Risposta:
7) Un cameriere ubriaco distrugge una festa con finale in una piscina
Risposta:
8) Una epica esplosione di un frigorifero nel deserto americano
Risposta:
9) Quattro personaggi hanno una brutta avventura in un bosco, ognuno racconta una versione diversa dell’accaduto, film giapponese del ‘50
Risposta:
10) Un cavaliere gioca a scacchi con la Morte