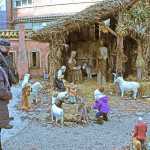La tecnologia informatica, con la rete che connette ogni soggetto con il tutto indistinto del web, con i suoi vari strumenti, Facebook, Tweeter etc., propone in qualche modo un individuo al centro del mondo, o almeno questa è la illusione che ogni navigatore, in qualche modo, culla e insegue.
E’ stato calcolato che tra il 30% e il 50% delle foto scattate dai giovani adolescenti siano selfie: una autorappresentazione di una massa sconfinata di utenti che propongono la propria immagine, pensando in qualche modo a una promozione narcisista di sé.
Non solo la propria immagine, ma anche dove sei, con chi sei, cosa fai, cosa cucini o cosa mangi; un gigantesco ininterrotto rimbalzo di centinaia di milioni di utenti dei social media, continuamente connessi ognuno individualmente con tutti.
L’iconografia proposta è quasi sempre ricca e appagante, spensierata e felice h.24; nessuno spazio per dubbi, ombre, riflessioni, amarezze; una umanità apparentemente felice e spensierata, esasperatamente socializzata, in realtà frantumata e disancorata; una monade che non desidera interagire in profondità nella sfera della emotività, del confronto, della riflessione, inevitabilmente incerti e faticosi.
Recentemente, in un festival del documentario scientifico, di cui ero in giuria, un esperto in comunicazione rilevava la grande difficoltà da parte di studenti tra i 16/22 anni, chiamati a votare, di sostenere la visione di filmati, sia pure interessanti e godibili, ma che avevano il “torto” di durare più di qualche minuto.
Così come la scrittura digitale sta portando ad una eccessiva semplificazione del linguaggio e ad una drammatica desertificazione nei vocaboli usati e nella struttura del discorso.
Un comportamento culturale in cui il soggetto soffre le riflessioni e i tempi di una proposta esterna a sé, e che si contrappone all’essenza del cinema, che è rappresentazione del mondo, in una visione che dal soggetto/autore si amplia e si estende, approfondendola, nel bisogno di uscire dal “sé”, con modi e tempi imposti, insopportabili per i nostri solitari narcisi.
La ricchezza, se si vuole la magia, del cinema, sta proprio nella sua capacità di farci conoscere luoghi, storie, comportamenti, sentimenti, emozioni.
Se facciamo caso, in un giorno qualsiasi, al pubblico in una sala cinematografica, constateremo che in gran parte è composto da grigi: scarsa la presenza di pubblico giovanile, che quando va in sala la maggior parte delle volte si orienta verso il cinema di fantasy o di computer grafica, che ripercorre, in qualche modo, modi e contenuti del web e della rete.
Per il cinema la sfida sarà, nei prossimi anni, quella di riuscire ad intercettare tanti piccoli individualistici selfie-man, senza perdere quelle caratteristiche che ne hanno fatto la settima arte.
Considerato che, ad ogni cambio di tecnologie, si è gridato “il cinema è morto”, salvo accorgersi che poi risorge dalle ceneri, restiamo dunque ottimisti e sogniamo di essere immersi, con tanta gente, nella sala buia…
TEST DI CULTURA CINEMATOGRAFICA
E come sempre, un piccolo test, stavolta tutto Woody: non sarà facile, ma un’occasione comunque per sorridere con un amico che da tanto tempo ci accompagna, con rassicurante ironia, e con la sua personale ossessione, il Sesso… per le risposte clicca qui…
1) “Ma tu mi ami?”, “Amore è un termine troppo debole per… ecco, io ti straamo, ti adamo, ti abramo.”
2) “Non sono i sei milioni di ebrei che mi preoccupano, è che i record sono fatti per essere battuti.”
3) “Considerato che sei morto, stai da Dio.”
4) “Credo di essere mezza santa e mezza vacca.”, “Scelgo la metà che dà il latte.”
5) “Ho scritto molti saggi sulla psicanalisi, ho lavorato con Freud a Vienna. Ci dividemmo sull’invidia del pene: Freud pensava di doverla limitare alle donne.”
6) “Dopo aver perso le gambe, ha trovato Dio.”, “Scusa ma… non mi sembra un granché come scambio.”
7) “Sei il più grande amatore che ho avuto!”, “Beh… Io mi alleno tanto da solo.”
8) “L’amore penetra nel profondo, il sesso è solo questione di pochi centimetri.”
9) “Presto avremo un bambino”, “Scherzi?”, “No, avrò proprio un bambino: me l’ha detto il dottore… sarà il mio regalo per Natale!”, “Ma a me bastava una cravatta!”
10) “La sola volta che Rifkin e sua moglie arrivarono ad un orgasmo simultaneo fu quando il giudice porse loro la sentenza di divorzio.”
11) “Io sono un uomo all’antica. Non credo nelle relazioni extraconiugali. Ritengo, invece, che la gente dovrebbe restare sposata per tutta la vita, come i colombi e i cattolici.”
12) “Ti masturbi? Io preferisco a fare sesso. Ieri sera mi sono messo su una cosetta a tre: io, Marilyn Monroe e Sophia Loren. Credo, tra l’altro, che fosse la prima volta che le due grandi attrici apparissero insieme.”