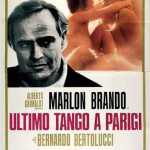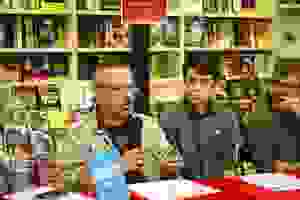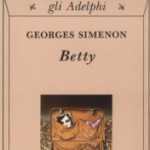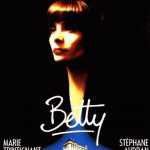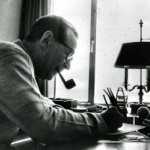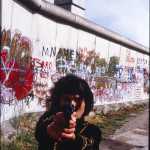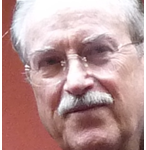La politica gassosa e l’appetitoso Quirinale
Come scrive Massimo Cacciari sull’Espresso, in tempi di politica liquida, e forse già allo stato gassoso, è usuale il lamento sulla qualità della classe dirigente nostrana.
Gli esempi, solo negli ultimi tempi, non mancano.
Se si presta orecchio alle indiscrezioni filtrate dal Quirinale e sulle intenzioni del presidente della Repubblica, che i bene informati danno particolarmente irritato, di lasciare anzitempo l’incarico vista l’inconcludenza sulle riforme, quella elettorale in testa, il festival delle dichiarazioni è in pieno terreno paradossale.
E’ da quando c’era al governo Berlusconi che Giorgio Napolitano predica, invano, che serve una nuova legge elettorale.
Ora che, dopo la sentenza della Corte, l’Italia è rimasta con l’invertebrato Consultellum e con un percorso riformatore che rischia l’approdo con ben un sistema di voto per ciascuno dei due rami del Parlamento, invece di un’autocritica per l’imperdonabile inerzia su un tema che torna nel dibattito politico con la stessa ciclicità del mito dell’eterno ritorno, si assiste sbigottiti alla fiera delle autocandidature per il Quirinale, con tanto di sconcertante lotteria dei nomi: la donna, il giovane, l’outsider, l’uomo di esperienza, il tecnico, quello non sgradito … Manca solo la casalinga di Voghera e poi siamo a posto.
Se anche la prima carica dello Stato rientra nell’avanspettacolo è davvero un problema.
A proposito di legge elettorale, senza entrare nel merito dell’ultima proposta sul tavolo, basta ascoltare un qualsiasi tg negli ultimi giorni per far precipitare in caduta libera qualsiasi mento. Ciascuno cerca di scaricare sull’altro la responsabilità dello stallo. Da una parte, al Pd (che qualcuno già chiama PdL, Partito della Leopolda), la colpa di cambiare in corsa le regole di un patto del Nazareno, che nessuno ha mai visto scritto da nessuna parte. Per contro, la palla viene rilanciata nella metà campo dell’altro PdL, nel quale il leader non riuscirebbe più a tenere i suoi e dove, come profetizzato da Corrado Guzzanti, ognuno fa un po’ come gli pare.
La conclusione è che si sentono dichiarazioni modello premi un bottone, che potrebbero essere buone per qualsiasi argomento: “Se c’è la reale intenzione di sedersi al tavolo e dialogare costruttivamente per cercare una soluzione noi ci siamo, con tutta la determinazione e la coerenza che abbiamo sempre dimostrato”. Naturalmente sempre al servizio del Paese.
Immaginiamo che al termine delle illuminanti parole il cameraman, perché ormai è inutile un giornalista, sia pronto a dare uno zuccherino, come si fa con i cavalli di razza.
Per quanto ci riguarda, telecamere e taccuini potrebbero cominciare a fare a meno di inseguire questo bla bla da calo glicemico, anche solamente per vedere l’effetto che fa. Chissà che pure nelle redazioni non inizi una sana spending review e si usino risorse, professionalità ed intelligenze, per le notizie vere.
Nel frattempo, in questa bolgia si riaprono inaspettatamente dei varchi, ad esempio, per fare scendere la soglia di sbarramento fino al livello del prodotto interno lordo nazionale, così possono continuare ad entrare allegramente nella mangiatoia anche gli organismi monocellulari.
Un altro esempio imperdibile arriva dalla campagna elettorale per la Regione Emilia-Romagna.
Se qualcuno ha visto il Tgr in queste sere ha potuto ascoltare gli spot dei vari candidati.
C’è chi è per la valorizzazione del territorio, chi per favorire gli insediamenti produttivi, chi per la ricerca e l’innovazione, chi dinamicamente vuole il voto per voltare pagina e chi, anche in pochi secondi, incespica sulle poche parole.
Il massimo lo raggiunge quello che non resiste alla tentazione di dare una sbirciatina sul foglio che tiene rigorosamente fuori campo, lasciando trasparire dallo sguardo il panico di perdersi nel pur breve viaggio mentale tra un soggetto e il predicato verbale.
La sensazione, in generale, è di trovarsi di fronte a quel tale che tempo fa disse: “Non sono venuto da Lodi per lodarvi, né da Piacenza per piacervi. Sono venuto da Chiavari”.