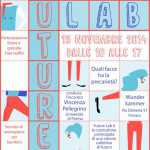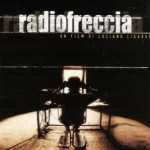Il Premio è stato istituito da Italia Nostra in onore di Giorgio Bassani, presidente nazionale dell’associazione dal 1965 al 1980, nel decennale della scomparsa (2010). Di carattere nazionale e con cadenza biennale, il premio è destinato a uno scrittore-giornalista distintosi negli ultimi due anni per i propri scritti o per interventi a favore della tutela del patrimonio storico, artistico, naturale e paesaggistico del Paese.
Per entrare profondamente nella visione e nel contesto del Premio, abbiamo intervistato Carl Wilhelm Macke, unico giornalista tra i componente della giuria, di nazionalità tedesca, grande amico di Giorgio Bassani e Paolo Ravenna, amante della nostra città al punto di vivere tra Monaco di Baviera e Ferrara.
Come amico ed estimatore di Bassani, come definiresti questo Premio?
Giorgio Bassani scrive racconti e romanzi fino attorno agli Settanta, poi si dedica quasi totalmente a Italia Nostra, producendo un’enorme quantità di scritti sulla tutela del patrimonio del nostro Paese. In questo senso, si può dire che questo premio è dedicato al ‘secondo’ Bassani.
Tu sei uno scrittore e un giornalista tedesco, probabilmente hai quindi un punto di vista molto particolare rispetto ai componenti italiani della giuria, cosa significa per te Italia Nostra e il Premio “Giorgio Bassani”?
A chi mi chiede perché sono diventato socio di Italia Nostra pur essendo tedesco, rispondo che l’Italia ha il 65% del patrimonio europeo in termini di beni culturali e quindi, a pensarci bene, tutti gli europei dovrebbero asserire che “l’Italia è Nostra” e farsi soci. Anzi, vorrei ribaltare il ragionamento: forse Italia Nostra è un po’ poco, sarebbe meglio chiamare l’associazione Europa Nostra e creare una nuova Europa sugli ideali di Italia Nostra.
Non è possibile replicare il modello di Italia Nostra in Germania o in altri Paesi europei?
Me l’hanno chiesto varie volte in Germania, nelle interviste o tra colleghi. Ci ho pensato molto e la risposta è no: non è possibile perché manca il contesto in cui l’associazione è nata e attualmente si scivolerebbe facilmente nel nazionalismo. Italia Nostra ha una storia antifascista: è nata nel dopoguerra, negli ambienti dell’alta borghesia romana, fiorentina e milanese, con una connotazione decisamente democratica, europeista e antifascista. Se si proponesse, ora, di fondare nel mio Paese, un circolo chiamato Germania Nostra, si rischierebbe di richiamare tutte quelle componenti neo-naziste della società. Questo perché è l’idea della nazione che è molto diversa. Quindi, di nuovo, la cosa migliore sarebbe esportare lo spirito di Italia Nostra, quella particolarissima e forte eredità che Bassani e Ravenna ci hanno lasciato, in Europa.
Si potrebbe allora aprire la giuria anche ad altri componenti stranieri…
Assolutamente sì, sarebbe una grande svolta.
Tornando al Premio, come avviene la selezione dei candidati e che tipo di lavoro c’è dietro al Premio? Quale, in due parole, il ‘back stage della premiazione’?
Tutte le sezioni di Italia nostra sono invitate a fare una proposta, indicando uno scrittore/giornalista e inviando i nominativi agli uffici centrali di Italia Nostra a Roma. Qui vengono raccolti tutti i materiali relativi alla produzione scritta dei candidati, sia on line che off line, e inviati ai componenti della giuria che hanno il compito di leggere e valutare. Purtroppo quest’anno abbiamo solo quattro candidati, nelle edizioni precedenti ne avevamo una decina. Le candidature sono segrete, noi della giuria ci ritroveremo sabato mattina al Caffè Europa per un ultimo confronto vis-à-vis e la decisione finale.
Avete già un’idea di chi sarà il vincitore?
Io personalmente ho già la mia proposta, ma staremo a vedere.
Quali criteri utilizzate per la scelta?
Personalmente, non essendo esperto né di arte né di temi quali l’ambiente e il paesaggio, esprimo un giudizio puramente letterario-giornalistico, mi concentro sulla qualità della scrittura e soprattutto sull’impegno civile che emerge dalla produzione dei candidati. Sul riconoscere l’impegno civile sono stato ‘formato’ molto bene dall’Avvocato Paolo Ravenna, grande amico di Bassani, primo presidente e fondatore della sezione di Italia Nostra a Ferrara. Paolo Ravenna era una persona di una intelligenza finissima, molto rigoroso e geniale: le sue intuizioni, le sue idee e i suoi progetti per Ferrara, basti pensare alla restituzione storica delle Mura e all’Addizione verde del Parco urbano, ricordano la lungimiranza dei duchi Estensi di epoca rinascimentale. Sia Bassani che Ravenna avevano, inoltre, una mentalità un po’ anglosassone: da loro ho imparato a distinguere tra la retorica del fare e la sobrietà dell’impegno civile, tra imperativi meramente estetici e obiettivi di grande respiro.
Per concludere, quali sono quindi gli ideali che stanno alla base dell’impegno civile di Italia Nostra?
Direi gli stessi su cui si basavano Bassani, Ravenna ma anche altri grandi intellettuali italiani, come per esempio Pier Paolo Pasolini, che tra l’altro era un grande amico di Bassani: sentirsi italiani, legati alle proprie origini ma senza cadere nel nazionalismo; essere aperti, pensare in grande, a livello europeo e simbolicamente internazionale; essere portatori di un regionalismo moderno, a tutela del territorio ma senza ambizioni secessioniste e reazionarie stile Lega Nord. In due parole, amare il proprio Paese avendo coscienza del mondo.
PRGOGRAMMA DEL PREMIO “GIORGIO BASSANI” E DEL CONVEGNO DI ITALIA NOSTRA
Sabato 15 novembre – a partire dalle ore 10.00
Convegno “Il Po e il suo delta: tutela integrata e sviluppi di un grande sistema ambientale europeo”, Castello estense (sala dell’imbarcadero 2) organizzato da Italia Nostra sezione di Ferrara.
Domenica 16 novembre – ore 10.30
Premio Nazionale Giorgio Bassani
Proclamazione del vincitore, preceduta dalla lectio magistralis di Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale sul tema “Il territorio bene comune”.
LA GIURIA
Alessandra Mottola Molfino, Presidente nazionale di Italia Nostra, Storica dell’arte e Museologa
Salvatore Settis, Consigliere nazionale di Italia Nostra, docente di Archeologia presso la Scuola Normale di Pisa, saggista
Gherardo Ortalli, docente di Medievistica presso l’Università di Venezia, componente del Comitato scientifico internazionale della Fondazione Giorgio Cini e del Comitato scientifico della Fondazione Benetton studi e ricerche
Luigi Zangheri, docente di Storia del giardino e del paesaggio e di restauro dei parchi e giardini storici presso l’Università degli studi di Firenze
Gianni Venturi, direttore dell’Istituto di Studi rinascimentali, presidente dell’Associazione amici dei musei e dei monumenti ferraresi, studioso dell’opera di Giorgio Bassani
Anna Dolfi, docente di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso l’Università di Firenze, presidente del Comitato per il centenario della nascita di Giuseppe Dessì, studiosa dell’opera di Giorgio Bassani
Carl Wilhelm Macke, giornalista di Monaco di Baviera, segretario generale dell’Associazione umanitaria “Giornalisti aiutano giornalisti”, cultore dell’opera e del pensiero di Giorgio Bassani