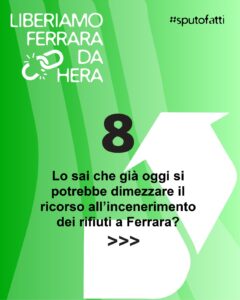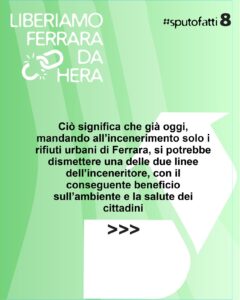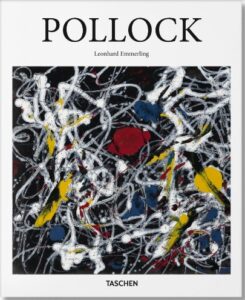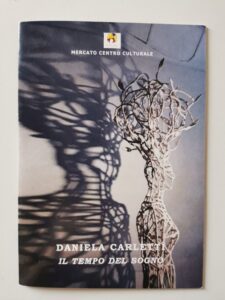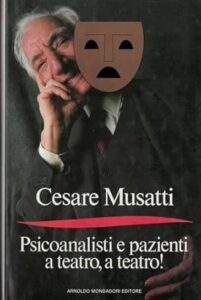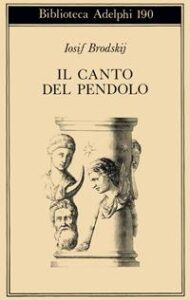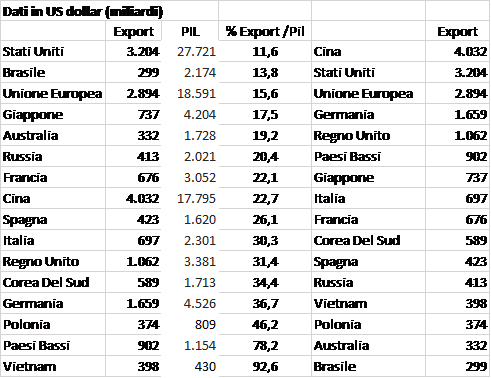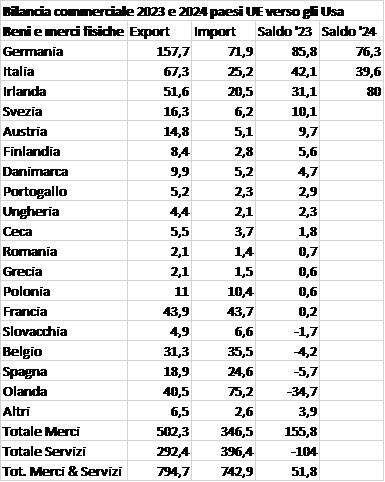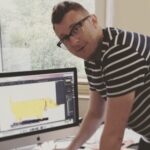La festa di Linda
Un racconto quasi fantastico
Mancava poco a domani, solo una notte, e magari anche quella notte avrebbe fatto il suo sogno. Domattina sarebbero arrivati tutti, da ogni angolo della terra, e in tre dalla nuova stazione di Marte, perché quello era davvero un evento speciale. E qual era l’evento? L’evento era lei, la cosa la faceva sorridere ma, inutile negarlo a sé stessa, si sentiva agitata come non le succedeva da tantissimo tempo. Ecco, quando aveva otto o dieci anni, era spesso agitata così, non ricordava più per cosa. Ma ora, dopo tutto quel tempo, adesso che era arrivata quasi alla fine, doveva ammettere di essere più agitata di allora.
Linda, la nonna Linda, la nonna di tutti, si alzò con un po’ di fatica dalla sua poltrona e si avviò zoppicando verso la sala da pranzo. Niente bastone, ce la faceva ancora, lei non aveva bisogno di un bastone. Aveva tre figli, e ognuno e ognuna le avevano regalato un bel bastone da passeggio. Eccoli lì, mica li aveva buttati, li teneva a dormire nel portaombrelli. La grande tavola era già apparecchiata, la tovaglia bianca di lino misto canapa, il bordo con un ricamo semplice, senza fronzoli, perché lei i fronzoli li odiava, e invece come adorava quella tovaglia antica. Con il pollice e l’indice provò il tessuto ruvido, così vero e bello, avvicinò il viso e aspirò il profumo del tessuto e del pulito. Sul tavolo mancavano solo i fiori, ma quelli li avrebbe aggiunti domani, all’ultimo momento.
Pensò ancora ai figli e ai bastoni, uno aveva addirittura l’impugnatura d’argento, e i figli non li aveva nemmeno ringraziati. Non si era comportata molto bene, ma insomma, non erano stati molto originali – Linda sorrise a quel pensiero impertinente – fosse stato ancora al mondo lo zio Checco, per il suo Moltianni le avrebbe regalato uno skateboard, non un bastone da passeggio. E poi, glielo aveva chiesto lei di regalarle delle stampelle? Per lei i regali non servivano a nulla, ci si amava benissimo senza quella stupida idea di confermare e sventolare in pubblico il proprio amore con un regalo. Se li facessero fra loro i regali. Intanto era entrata nella camera del grande camino di terracotta e si era accostata al tavolo ovale di pioppo bianco dove erano ammonticchiati una trentina di grandi pacchetti.
Bel discordo Linda, abbasso i regali, ma allora i tuoi pacchi di biscotti? Non sono regali anche quelli? No e poi no, protestò contro se stessa, quelli sono un segnale, un messaggio, sono un lascito testamentario. Proprio una bella eredità un pacco di biscotti… Un momento, ora Linda era infuriata: “Ma i miei non sono semplici biscotti, sono biscotti rotti”. Ed eccole qua le generose confezioni da chilo della premiata ditta Malandrini. Era stata una geniale trovata di Alessandro Malandrini di Saronno, pioniere della biscotteria italiana e fidanzato di sua nonna Clelia, no, forse era il fidanzato di sua bisnonna Maria Cecilia. Ha poca importanza, fatto sta che il Cavalier Malandrini cuoceva biscotti nel suo forno industriale e ne uscivano tanti rotti, spezzati, storti, difettosi. Invece di buttarli, Malandrini li mise in grandi sacchetti con sopra una scritta onestissima: Biscotti rotti. Costavano la metà della metà dei biscotti di prima scelta e andarono a ruba. Funzionavano come il cilindro di un illusionista, ci infilavi dentro la mano e non sapevi mai che biscotto pescavi, un frollino, un wafer, un krumiro, una ofella, un amaretto. Più del biscotto valeva la sorpresa. Ma alle sorprese bisognava allenarsi, ecco perché avrebbe distribuito ai discendenti il pacco degli impareggiabili biscotti rotti Malandrini.
Fece un’altra volta il giro della tavola da pranzo e contò ancora le grandi sedie di faggio, diciotto, un bel numero, più il seggiolone per Catina, l’ultima arrivata. Catina aveva quasi due anni e nonna Linda non l’aveva ancora vista toccata baciata. In cuor suo Catina, ma quella cosa non avrebbe mai compiuto il tragitto dal cuore alla bocca, nel suo cuore Catina era la preferita. Perché era l’ultima arrivata, perché aveva una malattia grave e fastidiosa, perché si chiamava Catina, Caterina, come sua madre. Linda non si vergognava delle sue preferenze, anzi, pensava alla preferenza come alla forma più perfetta dell’amore. Se ami molto, preferisci molto, e preferisci tutti, così era puntualmente capitato a lei con tutti e tre i suoi figli.
Il mese prima le era arrivata una foto di Catina, le aveva subito trovato una cornice. “No, niente argento per carità, che pacchianata!”, e l’aveva subito aggiunta al suo bosco famigliare. Accanto alla sua poltrona c’era un tavolino, nemmeno tanto piccolo, lì sorgeva una piccola foresta. Sul tavolino, senza un ordine preciso, senza gerarchie o cronologie, si affollavano alla rinfusa tutte le foto, dai bisnonni ai nipotini.
Il ritratto che attirava per primo il suo sguardo era sempre quello, un adorabile gruppo di famiglia in un interno, anche se non si capiva di che interno si trattasse, forse la grande casa rossa di via Terranuova. Più che un gruppo sembrava un mucchio di famiglia, perché i cugini – le femmine di bianco vestite, indossando le vecchie camicie da notte del Milleottocento – stavano abbracciati e ammonticchiati uno sull’altra sul divano. In posa ma scomposti c’erano tutti e sette, con l’aggiunta di Hola, il pastore catalano perennemente abbaiante ma per l’occasione placidamente spalmata sulle ginocchia di zia Martina. La foto era virata seppia e trasmetteva un sapore di antico, anche se non era poi così vecchia, non era tanto più vecchia di lei, era stata scattata, Linda rifece i calcoli, la vigilia di Natale del 2008, o forse un anno dopo. Erano quelli gli ultimi anni della famosa nonna Caterina, detta Caterina non de’ Medici per la sua avversione verso la categoria, o Pasionaria per la sua passione anticonformista e protocomunista, o Baronessa Mamuska per i suoi nobili e disconosciuti natali, la nonna Caterina detta e ricordata in molti modi e maniere da figli nipoti e pronipoti.
Stava facendo buio, accese l’abat-jour omeostatica (faceva una luce azzurrina, tagliente e provò nostalgia della luce calda dell’energia elettrica), ripose la foto sul tavolino e prese il bicchierone con tutte e due le mani. Lo beveva sempre tutto in un fiato, senza staccare la bocca nemmeno una volta. “E con questo fanno undici”, disse a sé stessa. L’acqua era la sua migliore amica.
Riprese in mano il ritratto. Dei magnifici sette era rimasta solo zia Miriam, nata a cavallo del millennio, ingegnere (ingegnera, avrebbe chiosato sua sorella Clelia) e innamorata dei numeri. Dal fondo della Patagonia, dove si era trasferita trent’anni prima insieme al quartier generale della grande azienda fondata dal bisnonno Serafino, l’aveva avvertita che non avrebbe potuto essere presente alla sua festa di compleanno. Zia Miriam aveva solo 95 anni e puntava a doppiare il secolo e senza ricorrere ai trattamenti eugenetici. Non era proprio il tipo da spaventarsi per un viaggetto del genere: si sarebbe messa al volante del suo ovulo di ultima generazione e avrebbe digitato sul display: Europa-Italia–Ferrara–Quartesana. Ma chi avrebbe badato ai suoi cani (5), e ai gatti (11), ai pinguini (3 coppie), alle stupidissime oche Adelina e Guendalina, e al ciuchino Lucignolo? E poteva abbandonare le 14.000 preziose pecore aziendali, e proprio ora, in piena stagione della tosatura? No, mi spiace piccola (zia Miriam si ostinava a chiamarla piccola), non riesco proprio muovermi, è fuori discussione.
Va bene, le aveva risposto in simultanea Linda, ma senza poter evitare un commento segreto e malizioso. Che poteva farci se oltre a essere intelligente era anche maliziosa? Non è cattiveria, si scusò da sola, la malizia è solo una conseguenza naturale, una innocua deviazione dell’intelligenza. Così pensò che zia Miriam, titolare del glorioso e pluripremiato Allevamento Incico spa e direttrice dell’ultima filanda del pianeta Terra, aveva un altro e più valido motivo per disertare la sua festa. Semplicemente, a Miriam non piaceva essere la seconda più vecchia del gruppo.
Si concentrò sulla faccia bambina di zio Tato, il più piccolo del gruppo. A quel tempo passava molte ore del giorno in compagnia di un pallone da calcio. Sarebbe di sicuro diventato un buon giocatore campione se a 17 anni, quando poteva finalmente fare il salto verso una grande squadra, dopo una settimana di febbre altissima, non fosse stato rapito da un insospettabile amore per la cultura. Appese le scarpette al chiodo e guardò per la prima volta in vita sua la parete del salotto fitta di volumi. Lui che fino ad allora aveva letto un libro e mezzo in tutto, affrontò di petto la grande libreria. In quaranta giorni e quaranta notti si mangiò e digerì alla bell’e meglio la biblioteca del padre. Poi senza indugio si mise all’opera e scrisse ininterrottamente per svariati decenni. Il suo romanzo fiume raggiunse le 14.000 pagine distribuite in 22 volumi, rimanendo purtroppo incompiuto.
Secondo la critica più attenta, il suo ciclopico “Adesso vi spiego com’è andata” inaugura (e chiude definitivamente, forse per stanchezza) la corrente del ipeultrarealismo. Avere in casa quei 22 tomi con la copertina gialla uovo marcio era subito diventato un must, un marchio di status sociale. Così la fatica letteraria di Tato aveva venduto qualcosa come 30 milioni di copie in tutto il mondo, contando però solo una traduzione, vista l’impossibilità di capirci alcunché. L’unica che, per amore e per mestiere, ci aveva provato sul serio – a leggerlo fino in fondo e a tradurlo – era stata sua sorella Clelia che però, intervistata sulla tellurica quanto labirintica trama di “Adesso vi spiego com’è andata”, aveva dovuto confessare di non aver capito del tutto com’era andata veramente.
Allo zio Momo era andata peggio. O meglio, secondo i punti di vista. Dopo aver diretto cinque concettosi lungometraggi in formato Quadriprof (quattro dimensioni con l’aggiunta di puzze, odori e profumi assortiti), ottenendo una assai tiepida accoglienza, aveva finalmente traguardato che il pubblico non era ancora pronto per la sua arte. Per fortuna zio Momo disponeva, come tutti in famiglia, di una intelligenza poliedrica e versatile. Si buttò con entusiasmo sul porno sperimentale, raggiungendo un considerevole successo e, particolare non trascurabile, collezionando svariate amanti e concubine.
E la carissima zia Martina? Che strana vita.. La sua piantagione di gangia prometteva successi e denari, se non fosse intervenuta quella dannatissima legge per la liberalizzazione e la promozione commerciale della marijuana e dei suoi derivati. Si trattava senza dubbio di una importante conquista civile, ma segnò una débâcle per la novella contadina. Da un giorno all’altro il fiorente mercato clandestino crollò e zia Martina si trovò nelle pesti. Seguì una fastidiosa crisi esistenziale da cui uscì solo due anni più tardi, risolvendosi a fare domanda per entrare nella Benemerita. Zia Martina avrebbe poi percorso con onore e velocissimamente tutti gli scalini della gerarchia: appuntato, maresciallo, capitano, colonnello, e infine eccola in alta uniforme, prima donna a raggiungere i galloni di generale dell’Arma dei Carabinieri.
Anche zia Clelia aveva contribuito a dar lustro alla famiglia. Imparò alla perfezione tre lingue, poi cinque, poi sette, poi diciassette. mandarino, lao, urdu e thai incluse. Le sue esibizioni pubbliche fecero impallidire le performances della donna cannone e dell’uomo più forzuto del mondo.
Sotto un grande tendone da circo gremito di gente di ogni specie e colore, zia Clelia se ne stava molto tranqui (Clelia aveva il vezzo di rispondere a tutti con quel suo tranqui) al centro di quella baraonda, seduta su una semplice sedia impagliata. La cosa funzionava più o meno come la simultanea di un gran maestro di scacchi. Intorno a zia Clelia, a formare un ampio cerchio, stavano sedute una ventina di persone, e tutte venti parlavano contemporaneamente, esprimendosi ognuna nel suo idioma natale. Clelia rispondeva a tutti, passando con sovrana disinvoltura da una lingua all’altra e permettendosi anche qualche battuta di spirito. In quella babele, e dico Babele in senso stretto – Linda era convinta che, se zia Clelia fosse stata nei paraggi, su quella Torre le cose sarebbero andate ben diversamente. Il pubblico in sala non ci capiva un’acca ma mandava urla e si spellava le mani.
Rimaneva zia Olly, lei sì che aveva girato il mondo. Per vent’anni aveva fatto perdere le sue tracce sulle strade che portano in India. Inseguiva una piccola tribù di pigmei albini di cui si favoleggiava da secoli, ma che tutti, geografi e antropologi, ritenevano appunto solo una favola.
Zia Olly si procurò nella biblioteca dell’università di Coimbra l’unica preziosa fonte, il diario manoscritto di un navigatore portoghese del Seicento, noto più per le sue epiche sbronze che per le scoperte geografiche. Nel suo resoconto di viaggio, unto e bisunto, pieno di strafalcioni, macchiato di uovo, pomodoro e vino di Porto, non c’era però nessuna coordinata geografica, nessun indizio utile a rintracciare quel minuscolo scoglio in mezzo all’Oceano Indiano. Ma esisteva veramente? La testardaggine di zia Olly fu alla fine premiata, quando, dopo un pauroso naufragio, approdò per puro caso su un’isola misteriosa quanto inedita. A quel minuscolo lembo di terra – oggi è segnato sulle carte a 3.483,5 miglia marine a sud-sudest di Colombo (Sri Lanka) – zia Olly volle dare il nome familiare di Isola Tullia. Seguirono i suoi famosi studi sui 27 abitanti albini dell’isola: pacifici, burloni, vegetariani e felicemente dediti a relazioni consensualmente non monogamiche. Quest’ultima scoperta, il fatto cioè che gli albini di Tullia, lontani dal cappio delle religioni monoteistiche, praticassero il poliamore in pace e armonia, provocò un salutare effetto a cascata sulla decrepita morale occidentale.
* * *
Il giorno della sua festa Linda si svegliò come sempre qualche minuto prima dell’alba. Si alzò a sedere nel letto e subito riconobbe i rimasugli del suo sogno. Come sempre c’era lei bambina di pochi anni e mamma Caterina attaccata a lei, in piedi, sulla riva di un mare immenso, così diverso da tutti i mari che aveva conosciuto nella sua lunga vita.
Era giorno fatto e il sole bruciava la sabbia e la testa, ma il mare era nero, notturno, calmo eppure carico di insidie. Lei aveva addosso il suo costume rosso a due pezzi, la mamma un costume intero bianco, tutte e due voltavano le spalle a lontani ombrelloni. Erano già entrate in acqua con i piedi ma non si muovevano, guardavano una linea d’ombra laggiù in fondo, dove finiva il mare, piene di paura ma piene di voglia di avanzare in quell’acqua scura. L’acqua era freddissima. Andiamo, avanziamo, ci buttiamo? Ma rimanevano ancora ferme, attaccate l’una all’altra. Poi, dal limite estremo del mare veniva il suono di una sirena di una nave, ora la nave sfilava davanti ai loro occhi, alta come un palazzo, tutte le finestre accese. Con quella visione e quel fischio prolungato di sirena, il sogno si interrompeva.
Che peccato, alla bambina del sogno, ma anche ora, mentre ancora stava seduta sul letto, le sarebbe piaciuto un finale, un finale qualsiasi. Dopo tutti quegli anni credeva anche di meritarselo un bel finale.
Nonna Linda si infilò i suoi vecchi zoccoli, ignorò il bagno e raggiunse direttamente la cucina. Sulla parete bianca di fronte al camino stavano appesi i quattro grandi piatti di ceramica con i quattro re delle carte, nonno Desiderio e i suoi tre fratelli, ognuno con il seme distintivo del proprio carattere; spade, bastoni, coppe e denari. Anche quello era un gruppo di famiglia in un interno. E senza volere scivolò ancora nei pensieri, uno a scavalcare l’altro, perché la grande casa di campagna sembrava vivere solo per quello scopo, chiamare i pensieri e radunare i ricordi.
Trent’anni prima, quando Linda era tornata in Italia dall’Aegentina, aveva subito riaperto la villa. Conosceva bene la sua virtù (paura dei fantasmi? Che idea sciocca: lei li adorava i fantasmi) e aveva preso una decisione, avrebbe usato tutto il tempo rimastole per non perdere una briciola del passato, nemmeno una.
Ora però dal salone d’ingresso sente arrivare la musica allegra del pianoforte. Forse il piano ha imparato a suonare da solo, o forse è lo zio Duccio, il più giovane dei fratelli del nonno Desiderio, che le dedica una canzone e le augura il buon compleanno. Linda si avvicinò al vecchio frigorifero Elios, uno dei primissimi modelli ESA (Energia Solare Alternata), l’ultimo ritrovato della tecnica, ma ora era un pezzo di antiquariato, un vero cimelio, un altro ferrovecchio che non aveva voluto rottamare. L’Energia Solare Alternata si era dimostrata abbastanza presto una pessima idea, passabile per scaldabagni, forni e fornelli, ma palesemente inadatta a produrre e mantenere il freddo – E voleva tanto a capirlo? , rifletté Linda.
Dove eravamo rimasti? A lei davanti al suo frigo solare; ora lo apre e tira fuori una bottiglia d’acqua fredda. Nel frigo non c’è molto posto per le cose da mangiare, quasi tutto lo spazio è occupato da bottiglie, tutte piene d’acqua. Di fianco al frigorifero, sulla credenza verde chiaro con il piano di marmo, ci sono tre vassoi e tanti bicchieri di vetro leggero, grandi e trasparenti, perché Linda odia i bicchieri colorati e non sopporta il contatto delle labbra con un vetro grosso. Se riempi uno di questi bicchieri di vetro sottile, non fino all’orlo, diciamo per tre quarti, la bottiglia si vuota per metà. Un bicchiere è mezzo litro, dodici bicchieri sei litri, che è giusto la dose giornaliera di Linda. Questo che si sta versando ora è il primo bicchierone della giornata, l’ultimo lo berrò verso le sette di sera. L’acqua, devo averlo già detto, è la migliore amica di Linda , la ragione della mia salvezza, o forse no, ma ilei sentiva che era proprio così.
I reni di Linda erano piccoli come noccioline americane, non crescevano, non volevano funzionare. Aveva le foto di lei intubata in ospedale. I dottori di Lione non sapevano cosa dire e cosa fare, la diagnosi era complicata. Una cosa brutta, tanto brutta che anche a mamma Caterina era andata via la speranza, e lei, Linda, non sapeva più se restare e vivere, oppure tornare indietro, dall’altra parte, dove non sappiamo se c’è il buio o la luce. C’era un video ripreso da un cellulare con la mamma che la tiene sulle ginocchia e la fa cavalcare. Nel video, l’aveva rivisto un milione di volte, lei ha ancora il sondino nel naso, ma ride e fa ciao con la mano. Non ricorda molto altro di quei mesi terribili, ma capita a volte che i ricordi entrino in silenzio sotto la pelle e rimangono con te per sempre.
Era stato un dottore italiano, il dottore era parecchio anziano, Linda aveva quattro anni e cresceva troppo poco, a mamma Caterina il vecchio medico aveva dato un consiglio. Senta signora, è un rimedio antico, forse non farà miracoli, ma certo non potrà far del male alla bambina, l’acqua non fa male a nessuno. Acqua, acqua, tanta acqua, tutti i giorni. Da allora lei aveva seguito fedelmente la dieta acquatica. I suoi reni, sia stata l’acqua o le medicine, le preghiere a Dio o la fortuna, non le avevano più dato problemi. Era solo rimasta, una volta si diceva così, un po’ debole di reni, ma niente di più.
Di Lione aveva ricordi sfocati, l’ospedale, la casa, il parco dove andava tutti i giorni, prima in passeggino, poi sulle sue gambe e sul triciclo – era rosso anche quello, dello stesso rosso del suo costume da bagno a due pezzi – ma Lione le era sempre stata antipatica, forse per via della malattia, o per la faccia triste che i genitori volevano nasconderle, o semplicemente per i francesi, tutti i francesi o quasi tutti. Dopo Lione c’erano stati tanti altri posti, tante città e tante case. Lione era stata coperta da moltissime altre immagini, come un lenzuolo sotto cento coperte.
Questo pensa ora Linda, che non era stato facile essere figlia di due scienziati. Era diventata grande. Abitavano in una bella casa nel quartiere Palermo a Buenos Aires, la casa era piena di sole e di vento, aveva un grande giardino. Quel giorno, erano a tavola, Linda andò subito al sodo con mamma e papà: Qui mi piace, è il mio posto, non voglio più partire, voglio essere un animale stanziale io. Invece, dopo che a mamma Caterina era stato assegnato il premio, quello per la fisica – ricordava benissimo la compassata cerimonia a Stoccolma – i viaggi si erano moltiplicati, e dopo il secondo premio, questa volta per la chimica, c’erano stati anni in cui mamma e papà non disfacevano mai le valigie.
Colpa di Argon, “l’Inoperoso” secondo la radice greca, l’inafferrabile e inutile gas nobile, detto anche gas inerte, o gas raro. Questo Argon, che non è poi tanto raro, visto che partecipa con un rispettabile uno per cento alla composizione dell’atmosfera terrestre (venti o trenta volte di più dell’anidride carbonica senza la quale però non ci sarebbe vita sul pianeta), non aveva nessuna intenzione di combinarsi o coniugarsi con alcunché. Da sempre, dal principio di tutto, Argon dormiva, fluttuava, oziava, incurante degli altri elementi e del genere umano.
Mamma Caterina – la stampa internazionale l’aveva poi messa sul trono chiamandola la nuova Marie Curie – non era certo una donna da confondersi con le altre. Del resto, la bisnonna Maria Cecilia, la nonna della mamma, andava ripetendo che “In famiglia siamo tutti un po’ speciali”, Forse la mamma lo era più degli altri, era speciale in un modo speciale. Fatto sta che grazie a una geniale intuizione, a una perseveranza alfieriana e a uno spericolato esperimento, mamma Caterina era riuscita a far socializzare il placido Argon. Linda aveva gran rispetto per la scienza e gli scienziati, ma aveva una personale teoria al riguardo. Conosceva sua mamma meglio di chiunque altro ed era convinta che con Argon lei avesse giocato d’astuzia, che gli avesse tirato un tiro mancino. Lo aveva corteggiato, vezzeggiato, adulato (papà Serafino se ne era anche un po’ risentito), lo aveva portato a spasso come si fa con un cagnolino adorato, tenendo il guinzaglio allentato, senza dare strattoni, carezzandogli il muso e lisciandogli il pelo. Poi, in un momento di abbandono, quando l’accidioso e misantropo Argon aveva la guardia abbassata, la mamma aveva stretto all’improvviso il collare e costretto l’Inoperoso – per la prima volta dal Big Bang ai giorni nostri – a darsi da fare e a guadagnarsi da vivere.
Il resto è storia che trovate in qualsiasi enciclopedia. Né l’autore di queste righe né Linda vogliono annoiare il lettore ripetendo quello che i bambini imparano in terza elementare. Il trionfo della Energia Argonautica è sotto gli occhi di tutti. Chi non sa che senza di lei (e ovviamente senza mamma Caterina) non saremmo arrivati dove siamo adesso? E non ci sarebbero i viaggi interstellari, l’inquinamento zero e ozono quanto basta.
Ma è tempo di tornare alla festa di Linda e di concludere questa storia. Una storia piuttosto ordinaria ma assolutamente vera anche se, lo ammetto, non troppo verosimile. Le piccole licenze, le innocue divagazioni, le strampalate fantasie che l’autore ha voluto concedersi, non sono però frutto di una inveterata tendenza alla menzogna, ma il risultato di un duplice amore. L’amore per l’oggetto, cioè per i soggetti protagonisti del racconto, e l’amore per la finzione letteraria. Non so se qualcuno l’ha già scritto, in ogni caso lo scrivo io: solo percorrendo le strade della finzione è possibile estrarre qualche verità dalla materia inerte del reale. E’ una teoria stramba e non dimostrabile? Ve lo concedo, ma è la mia teoria.
Ora il sole incomincia a scottare e quella mattina, voglio dire questa mattina, la mattina del 18 dicembre 2095, non sembra diversa da qualsiasi altra mattina di caldo inverno di fine secolo. Linda si è vestita e con il vestito della festa, continua a camminare per le stanze della villa, i suoi zoccoli fanno toc toc sul vecchio pavimento di cotto. Come tutte le mattine si emoziona vedendo la luce del sole che invade e accende le pareti bianche. Che ore sono? Sono le otto e mezza, l’ora della prima colazione. Ma prima deve levare i catenacci del portone d’ingresso, afferrare le maniglie, far scorrere e accostare le due ante della porta a vetri.
Un sibilo leggero, prolungato e acuto come una punta di spillo, taglia a metà l’aria tiepida del mattino. Allora Linda riapre le ante della porta finestra che affaccia sul parco, passa con lo sguardo i pioppi secolari e le due Gingo dritte come sentinelle, l’orto ben tenuto, la torre colombaia là in fondo. Sul grande prato verde sta atterrando l’ovulo dei primi invitati. Il buffo velivolo descrive un cerchio quasi perfetto proprio sopra la torre e si posa dolcemente sull’erba. L’ovulo (occorre specificarne il principio motore? Gas Argon ben compresso in quattro pistoni e una biella) brilla nel primo sole; è rosso cromato, lo stesso rosso delle antiche automobili a scoppio Ferrari. Sembra proprio una grossa ciliegia matura. Nonna Linda avanza qualche passo sul pianerottolo della scala di cotto, agita la mano destra per dare il benvenuto ai suoi ospiti. La sua festa di compleanno è incominciata.
(Finito a Ferrara il 30 giugno 2016 – 5° revisione 21 marzo 2025)
Per leggere tutti gli articoli e i racconti di Francesco Monini su Periscopio clicca sul nome dell’Autore