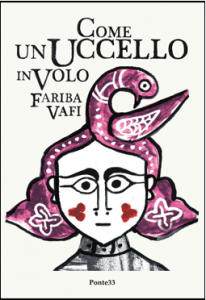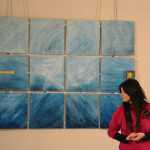I fumi sulla città
E alla fine si è dovuto attivare il prefetto. Magari sollecitato, probabilmente indotto a convocare un tavolo di confronto che vedrà riunite istituzioni, aziende e organi di controllo per capire cosa sta succedendo al petrolchimico e quali sono i rischi per la popolazione. L’accensione delle torce e le alte colonne di cupi fumi sono ormai uno spettacolo quotidiano tutt’altro che edificante. Fra il 19 e il 30 novembre e poi ancora fra il 7 e il 9 dicembre, quindi il 14 dello stesso mese e infine l’8 e il 10 di gennaio le lingue di fuoco fuoriuscivano dalle ciminiere degli stabilimenti. Si tratta di un’emergenza, poiché l’accensione delle torce è consentita solo in casi straordinari. Il problema ora è comprenderne le ragioni e stabilire i pericoli. Yara e Versalis sono le imprese più attentamente monitorate. Loro per prime dovranno fornire spiegazioni.
Le istituzioni per ora si sono limitate a generiche rassicurazione. Non c’è stata una presa di posizione netta. La scelta è stata forse quella di trasferire al rappresentante del governo l’impegno di mediare e sollecitare i chiarimenti. Una strategia accorta, improntata alla prudenza, per qualcuno finanche eccessiva. E’ il caso del Movimento 5 stelle, per esempio, che sollecita una presa di posizione politica e snocciola fondate ragioni di inquietudine.
Peraltro le inquietudini destate dal petrolchimico a Ferrara si assommano all’emergenza che in questi ultimi due mesi ha interessato tutto il Paese e in particolare la pianura padana a seguito del drammatico aumento del livello di polveri sottili presenti nell’aria.
“E’ piovuto un po’ e questo ha indotto qualcuno a considerare sbrigativamente risolto il problema, ma non è così e lo sappiamo bene – commenta il deputato 5 stelle, Vittorio Ferraresi – Gli ultimi dati sono molto preoccupanti. Per affrontare la situazione servono interventi strutturali e misure mirate. Non si tratta di allarmismo ma di rischi reali. A Gela di recente il tribunale ha emesso una sentenza che presuppone il nesso causale fra morti e miasmi petrolchimici. Teniamone conto. Ferrara in questa fase è simultaneamente oppressa da problemi sindacali e rischi per la salute. Il prefetto si è mosso giustamente e lo ha fatto per primo”.
Il Movimento 5 stelle punta l’indice sul ricatto occupazionale. “Si è perennemente in bilico fra produttività e sicurezza. Su questo terreno la politica non fornisce alcuna risposta. E’ ovvio che le aziende, nei limiti posti dalla legge, facciano tutto ciò che conviene loro per trarre il massimo”. Sono entità economiche e tutelano i loro interessi. E’ la politica – sostiene Ferraresi in conferenza stampa – che dovrebbe condizionarne l’operato “incentivando chi attua comportamenti virtuosi e sanzionando pesantemente chi inquina”. Tali non si possono certo considerare, per esempio, le ammende inflitte in passato a Yara e Basell per una serie di ripetute infrazioni: emissioni non autorizzate (fra il 2007 e il 2010) e improprio utilizzo torce (fra 2010 e 2011). In totale 41 mila euro: una sanzione ridicola, un regalo.
Manca un piano economico energetico-produttivo che abbia valenza strategica, fa notare anche il deputato ferrarese del Movimento 5 stelle. Denuncia come per estrarre petrolio, allettati da una manciata di euro, si vogliano violare il paradiso delle isole Tremiti. E addita Ferrara come capitale delle Pm10, le terribili polveri sottili. All’inquinamento altissimo certificato dai dati Istat corrisponde un alto tasso di mortalità. Si è registrato un aumento dei casi di tumore, ben 2980 in più. E le risposte sono insufficienti. Alle nostre latitudini – riferisce – l’aspettativa di vita è di tre anni inferiore al resto del Paese. Vergognoso e allarmante il silenzio. Il problema riguarda prima di tutto la salute dei cittadini. Ma ha anche ricadute economiche, sottolineano ancora i 5 stelle. In Emilia Romagna c’è un costo di tremila euro procapite che gravano sulle spalle di ognuno di noi, dovuto ai danni arrecati all’ambiente e agli interventi attuati per attenuarne gli effetti.
Servono interventi mirati a livello nazionale, con specifico riguardo per la pianura padana. Che fare? “Incentivare la raccolta differenziata. Stop ai propellenti fossili (invece si punta ancora sugli idrocarburi). Per contrastare l’inquinamento ambientale, stop ai veicoli diesel. Favorire la diffusione di vetture a gpl, metano e ibride. M5s ha proposto incentivi solo per questo tipo di auto. Invece hanno incentivato tutti”.
Poi c’è il dito puntato sulle infrastrutture e l’ostilità per la Cispadana. “Stiamo per costruire una strada assolutamente inutile fra Ferrara e Reggiolo, proprio quando l’Europa chiede un potenziamento del trasporto ferroviario. Serve la sensibilità del governo”.
Alle questioni prettamente locali torna il neoconsigliere comunale Sergio Simeone: “Chiediamo che il tavolo convocato per martedì dal prefetto sia allargato alla presenza di un organismo terzo indipendente e rappresentante società civile”. Il soggetto proposto è l’associazione Isde di cui è esponente il medico Luigi Gasparini, simpatizzante del Movimento 5 stelle, anch’egli presente in conferenza stampa. “Chiediamo all’Amministrazione comunale cosa fatto per migliore la qualità aria. Sul problema torce noi ci siamo mossi tempestivamente senza ottenere risposte. E’ stata ignorata da Arpa la nostra richiesta di chiarimento. Sono arrivate generica rassicurazioni ed eluse le reali problematiche. Ferrara subisce tutte le problematiche proprie della pianura padana. In aggiunta ci sono petrolchimico e inceneritore: la situazione è particolarmente pesante”.
Simeone solleva poi una questione non secondaria: Arpa ha fornito dati rilevati da Yara, sono stampati sulla loro carta intestata. Possiamo fidarci? Chi controlla il controllore. Di questi tempi ci vorrebbero verifiche scrupolose, al di sopra di ogni sospetto. La situazione del petrolchimico è preoccupante. Oltretutto Versalis è in fase di vendita e potrebbe esserci un allentamento controlli… Per questo, pur apprezzando l’iniziativa del prefetto che ha invitato aziende, organismi di controllo e istituzioni, sosteniamo che sia importante coinvolgere la società civile. Quella di Iside è una proposta, ma siamo aperti ad altre soluzioni. La nostra è una richiesta non polemica, un contributo costruttivo. Speriamo si possa dare questo segnale importante.
E in tema di contributi fattivi, Simeone aggiunge un’annotazione e la conseguente proposta: “l’inquinamento delle caldaie incide più di quello delle auto. Spesso negli uffici pubblici le temperature sono eccessive. sarebbe il caso di verificare e intervenire. Se si iniziasse dagli uffici pubblici a dare il buon esempio forse poi si sarebbe più autorevoli a chiedere l’impegno dei cittadini. Servirebbe anche un fondo pubblico per la mobilità sostenibile, immediatamente disponibile. E, al riguardo, a livello di comportamenti virtuosi bisognerebbe per esempio che tutti quanti spegnessimo il motore ai semafori. Tante piccole cose utili che sommate possono contribuire a migliorare la situazione…”.
Infine Luigi Gasparini, in attesa del nulla osta per partecipare al vertice in prefettura di martedì, snocciola i dati delle polveri sottili rilevati in città. E fa notare come i valori non siano rassicuranti. “La situazione epidemiologica di Ferrara conferma vecchie tendenze. L’eccesso di micropolveri causa malattie cardiocircolatori e tumori. “Ieri le pm10 in corso Isonzo erano a 74 microgrammi di media. I danni alla salute, secondo l’Organizzazione mondiale per la sanità, iniziano già dai 20 microgrammi per metro cubo. E poi, analizzando la serie storica del 2015 ci si accorge che i valori più alti e il maggior numero di sforamenti 2015 sono al Barco non in città”. Alla radice del problema, dunque, più che il traffico automobilistico ci sarebbe proprio il petrolchimico.