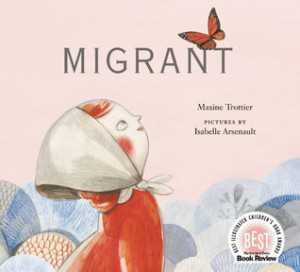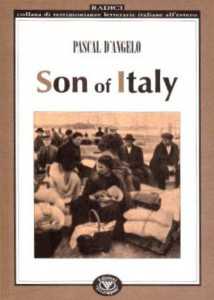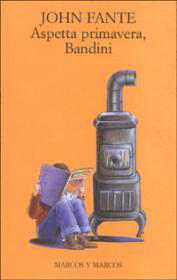Sembrano secoli ormai. È passato tanto, troppo tempo da quel giorno. Però mi ricordo tutto, e se chiudo gli occhi posso sentire ancora gli odori di quella mattina di festa.
Era il trentuno dicembre del 1982 e avevo compiuto i miei sospirati diciott’anni già da qualche mese, in agosto per la precisione. Ovviamente era ancora fresca in tutti noi la gioia della finale dei mondiali vinta contro la Germania.
Apro una parentesi: l’estate di quell’anno fu una delle più felici della mia vita, sicuramente la più spensierata. Ricordo la vigilia di Ferragosto nella spiaggia di Gabicce, era ormai buio ed eravamo tutti intorno a un falò in attesa che partissero i fuochi dai barconi al largo. Io ero con Adina (in realtà il nome era un altro, simile ma assai difficile da pronunciare), era tedesca e aveva vent’anni, era bionda, alta e… si sarebbe sposata in settembre con un suo coetaneo di Colonia, la città dove abitava. Lei non spiaccicava una parola d’italiano e io altrettanto di tedesco, però i gesti e gli sguardi erano più che sufficienti e stavamo abbracciati come due innamorati. Il giorno dopo poi sarebbe ripartita per Colonia e naturalmente non l’avrei più rivista. Guardavo lei, guardavo la sua amica, che sospettavo essere lesbica perché aveva rifiutato la corte di tutti i maschietti del gruppo, e guardavo i miei amici spalmati sulla sabbia come me, come me rallegrati da una buona dose di birra che, a parte il far girar la testa, ci costringeva a ripetute missioni tra i cespugli tutt’intorno per svuotare vesciche sempre piene. Fissavo il fuoco e desideravo che quella notte durasse per sempre. Poi l’estate finì e ricominciò la scuola. Per me era l’anno della maturità, ancora un ultimo sforzo e una volta diplomato sarebbe arrivata finalmente la libertà… almeno pensavo.
Comunque torniamo a quella mattina della vigilia di Capodanno.
Mi ero svegliato presto e avevo chiesto a mia madre di prestarmi la macchina perché mi serviva per andare a fare spese per la festa che stavo allestendo col resto del gruppo, ero fresco di patente e mia madre acconsentì a malincuore. Del resto in quel periodo ero l’unico patentato tra i miei amici e la disponibilità di una macchina divenne per noi fondamentale. Addentai una fetta di ciambella che mia nonna aveva appena sfornato e ingollai al volo un sorso di latte direttamente dal cartone, afferrai le chiavi della 127 e uscii. Ricordo ancora la voce accorata di mia nonna che mi seguiva per le scale dicendomi: “Mi raccomando, stai attento! Vai piano con la macchina, che non la conosci ancora bene!”
Il cielo su Ferrara era coperto, come al solito. La pioggia cadeva a intermittenza ormai da giorni e, anche se non faceva troppo freddo, l’aria era umida e pungente. Tutto sommato, del tempo non mi fregava un granché: la festa era al coperto e io e i miei amici sapevamo che niente ci avrebbe rovinato la serata, nemmeno il diluvio!
Passai a prendere Andrea, il mio migliore amico, insieme andammo da suo cugino Marco. Marco abitava con la madre e la sorella in una casa enorme, con un grande cortile in fondo al quale si ergeva un capannone che all’inizio serviva come magazzino per macchine agricole, e che dopo alcuni anni, trasferite le attrezzature in campagna, trasformammo completamente facendolo diventare il nostro quartier generale. Ogni sera e ogni fine settimana ci trovavamo tutti lì, a bere una birra, a giocare o anche solo a fare niente, bastava esserci. Lì ci facevamo le feste, ci portavamo le ragazze, ascoltavamo la musica e, ogni tanto, qualcuno preparava un rilassante e innocuo spinello che democraticamente passava a tutti gli altri.
Avevamo organizzato tutto nei minimi particolari, già due mesi prima avevamo iniziato a spargere la voce tra le varie “cumpa” di periferia con cui avevamo rapporti di buon vicinato. Negli altri gruppi c’erano vecchi amici d’infanzia o ex compagni di scuola o semplicemente gente conosciuta in precedenti feste e poi rimasta in contatto con alcuni di noi. Lo scopo ultimo era procurare più ragazze possibili, meglio se carine: a tal proposito potevamo considerarci più che soddisfatti poiché, dalle adesioni ricevute, prevedevamo la partecipazione di un’ottantina di persone, di cui più della metà erano ragazze. Avevamo distribuito decine di biglietti, ognuno dei quali significava un incasso anticipato di diecimila lire, coi soldi avremmo comperato i cibi e le bevande per la festa, e il denaro che fosse avanzato l’avremmo speso in dischi e luci strobo.
All’epoca locali da ballo e discoteche erano roba da “anziani”.
Per noi e i nostri coetanei era più divertente farci la discoteca in casa organizzando feste private dove puntualmente conoscevamo e intortavamo ragazze nuove.
Per la musica erano anni importanti: c’era il rock delle ‘band immortali’, stava nascendo il pop della new wave inglese, mentre il funky americano dominava ancora le piste da ballo, poi lo ska, il reggae e qualche residuato di punk. Questo era il menù musicale delle nostre feste e più in generale delle nostre serate in compagnia. Andare ai concerti era un’abitudine costosa, ma irrinunciabile: si risparmiava sul cinema e la pizza, però quando gente come The Police o i Simple Minds capitava a fare concerti nei paraggi noi dovevamo esserci, con buona pace dei nostri vecchi.
Quel giorno io, Andrea e Marco andammo al supermercato a procurarci tutto l’occorrente. Uscimmo con tre carrelli carichi e ancora mi sorprendo per come siamo riusciti a far stare tutto nella 127 di mia madre.
Stipati all’inverosimile, ci stavamo dirigendo a casa di Marco quando per strada vedemmo un ragazzo che camminava quasi barcollando. Lo riconobbi, era Simone, un mio vecchio compagno delle medie, abitava nel nostro quartiere e per qualche tempo ci eravamo frequentati. Mi fermai, scesi dalla macchina e gli andai incontro. “Ehi vecchio come stai?” gli dissi.
“Ma ciao! Bene, te come va?” mi rispose.
“Tutto regolare Simo. Senti, ti ho visto e mi sono chiesto che facevi stasera… Noi organizziamo la festa da Marco, se vuoi passare noi siamo lì. Ti garantisco che faremo un gran casino”.
“Beh, ti ringrazio, è che stasera sarei a un’altra festa. Però magari dopo la mezzanotte mi libero e faccio un salto”.
“Ok! Senti: se poi passi e ti porti dietro qualche donzella ti offriamo doppia consumazione. Ci stai? Mi raccomando ci conto!”
“Vedrò cosa posso fare, ciao!”
Simone aveva diciannove anni, era un bel ragazzo, alto, con i capelli castani, ricci, portati lunghi sulle spalle. A scuola, almeno finché non si era ritirato, aveva fatto sfracelli con le ragazze. Qualche anno prima era conosciuto da tutti per la sua fama di ‘bello e maledetto’: arrivava con la sua moto e tutte le ragazze se lo mangiavano con gli occhi. Tra noi c’era chi non lo sopportava proprio. Non io.
Ci conoscemmo alla Tasso, io facevo la terza media e lui capitò nella mia classe come ripetente. Un pomeriggio, nel cortile della scuola, mi salvò da un sicuro pestaggio dopo una discussione con tre ‘cremini di piazza’. Da quella volta iniziammo a vederci spesso: mi insegnò a giocare a carambola in un baraccio di un suo lontano parente in fondo a Via Arginone, mi fece fumare il mio primo spinello dietro una siepe nei giardini dell’Acquedotto e mi fece condividere la sua particolare passione per i fumetti horror.
Parlavamo di tutto, gli argomenti spaziavano dalle tipe che te la danno subito all’estinzione delle tigri siberiane, da Alan Ford e il Gruppo Tnt a Baudelaire, Rimbaud e tutti gli altri maledetti.
Lui invidiava il mio talento a disegnare, io il suo coraggio.
Un giorno lo presentai ai miei amici, ma Simone era un solitario e preferiva starsene per i fatti suoi. Ancora oggi non so proprio perché mi prese in simpatia. In compenso usciva con un sacco di ragazze e spesso me le presentava.
Una sera mi fece conoscere Anna, un tipetto tutto pepe di un paio d’anni più grande di me. Era una biondina graziosa con due occhi chiarissimi dall’apparenza innocente, in realtà una punk scatenata, pazza per i Sex Pistols e i Clash. La prima ragazza che mi fece finalmente comprendere cosa volesse dire baciarsi con tutta la lingua.
Poi Simone cambiò, cominciò a frequentare quelli di Via Formignana, tossici convinti. Ci vedemmo sempre di meno fino a perderci di vista, per poi incontrarci casualmente in quella vigilia di Capodanno.
Ci salutammo, io me ne tornai nella 127 mentre sentivo su di me le occhiate perplesse dei miei due compagni, Simone si girò e proseguì il suo cammino. Quella mattina fu l’ultima volta che lo vidi.
La giornata proseguì frenetica. I preparativi per l’imminente serata erano la nostra unica preoccupazione. Ricordo che avvisai i miei che non sarei tornato per il pranzo e che sarei rimasto da Marco a sistemare il locale fino al tardo pomeriggio, sarei poi passato a casa a ora di cena a cambiarmi per la festa. Ci trovammo tutti lì, tutti noi della vecchia guardia: Andrea, Mek, Gepry, Mauro, Ruggy, Willy, Robur, Flipper, Carion, Forla, Ricci e io. In cuor mio però mi dicevo: “Ne manca uno…”
L’avevo incontrato proprio quella mattina.
Lavorammo sodo perché tutto fosse pronto per le nove di sera, l’ora ufficiale d’inizio della festa.
E forse fu proprio quel pomeriggio il momento più bello di quel Capodanno, più della sera e della notte di baldoria che ci aspettava, più delle ragazze e delle sbornie che sarebbero arrivate. Quel pomeriggio, forse come mai prima d’allora e come non sarebbe mai più stato dopo, ci sentimmo fratelli.
Non potrò mai dimenticare quella notte, la festa fu un successone, arrivarono più di un centinaio di persone e, tra esse, tantissime ragazze nuove. Ci sentivamo i padroni del mondo, e forse in quel piccolo angolo di mondo che avevamo trasformato nel nostro regno del divertimento lo eravamo per davvero.
Io feci pace con Isabella, la mia ex. Ci baciammo fino a un quarto d’ora dalla mezzanotte poi scattarono i festeggiamenti: il 1983 era iniziato!
Bastarono qualche birra e qualche liquore di troppo e io e Isabella ci mandammo nuovamente e reciprocamente al diavolo, stavolta in modo definitivo. In verità ero segretamente e disperatamente innamorato di Roberta, una morettina pallida e magrolina conosciuta un anno prima ad una festa di carnevale. Era di Tresigallo, ma i suoi si erano trasferiti in città da qualche anno. Portava i capelli corvini raccolti in un cerchietto di madreperla, i suoi grandi occhi neri dal taglio vagamente orientale e le sue labbra carnose facevano da contrasto con le lentiggini che ricoprivano il nasino a patata. Non era appariscente e per diverso tempo nessuno del gruppo se la filò più di tanto. Nonostante ciò, quando la vidi quella prima volta, la trovai subito bellissima. Quello con Roberta fu un vero e proprio colpo di fulmine, il primo e unico, purtroppo non corrisposto, credo. Un amore comunque destinato a rimanere platonico, poiché all’epoca, se pur tra alti e bassi, stavo con Isabella e decisamente non ero il tipo che ci provava con tutte. Roberta poi era una ragazzina assai timida, parlava poco e arrossiva facilmente, era costantemente controllata dai suoi e usciva di casa raramente. Lo shock arrivò nell’aprile del 1982, quando venni a sapere che Mek e Roberta s’erano messi insieme. Da quel giorno ebbi la certezza d’amarla, ma mi convinsi pure che non sarebbe mai più potuta essere mia.
Erano le tre di notte quando Andrea e Ruggy mi trovarono steso a terra nel cortile davanti all’ingresso del capannone. Sbronzo come poche altre volte nella mia vita, mi ero addormentato con la faccia semisommersa in una pozzanghera.
Fuori c’erano cinque gradi sopra lo zero e io avevo addosso solo un paio di jeans e la camicia, ero in uno stato pietoso: col respiro facevo le bollicine nel fango!
Mentre mi raccoglievano per portarmi al coperto e risparmiarmi una probabile polmonite, io chiamavo Roberta e piangevo. Mi tennero in disparte e ci misero un po’ per calmarmi. Ma alla fine mi passò, ci unimmo agli altri e Andrea e Ruggy non dissero niente a nessuno. Quell’episodio rimase una cosa tra me e loro, Mek non lo venne mai a sapere.
Il giorno seguente eravamo devastati!
Fortunatamente le scuole avrebbero riaperto dopo la Befana e noi avremmo avuto tutto il tempo per recuperare.
Ci ritrovammo da Marco nel tardo pomeriggio: ci eravamo ripromessi di ripulire e riordinare il capannone dagli effetti della bolgia di qualche ora prima, ma nessuno di noi era a posto, c’era chi aveva un tremendo mal di testa, chi continuava a entrare e uscire dal bagnetto in fondo al cortile, e chi come me era febbricitante e con la gola arsa dalla sete.
Per tutto il giorno, il prezzo da pagare per aver passato una notte di bagordi l’avremmo scontato nella testa e nello stomaco; ed era un conto parecchio salato! Vedere le bottiglie di liquore rimaste mi dava la nausea e avevo un continuo, assillante bisogno di bere acqua
Poi all’improvviso arrivò Forla, aveva un’espressione strana, capimmo che doveva dirci qualcosa.
«Che c’è Forla, che è successo?» lo incalzò Ruggy. Forla fece un sospiro, era scuro in volto, aspettò che tutti noi lo guardassimo con la massima attenzione, infine parlò: «Sentite gente, l’ho saputo adesso per radio… Simone è morto!»
Rimasi col bicchiere di carta pieno d’acqua in mano a guardare la faccia di Forla che, dette quelle parole, si sedette sul divano e rimase a testa bassa senza aprir più bocca. Non avevo più sete. Sentii la mia voce esclamare che non era possibile, che l’avevo incontrato la mattina precedente dopo tanto tempo e che c’eravamo pure parlati, ma quelle parole non uscirono mai dalla mia bocca. Rimasero nella mia testa e ci rimasero a lungo. Sapevo che si bucava, tutti lo sapevano, eppure ero fermamente convinto che ne sarebbe uscito, che si sarebbe salvato. O forse, crederlo mi aveva fatto comodo, mi era servito semplicemente per alleggerire la coscienza.
In realtà non avrebbe mai potuto salvarsi, non senza il nostro aiuto. In realtà gli avevamo voltato le spalle, avremmo dovuto fermarlo, riempirlo di botte se necessario. Magari non sarebbe cambiato niente, ma avremmo dovuto comunque provarci, io per primo. Invece non facemmo nulla, se non commiserarlo.
Simone era orgoglioso, era impavido e amava le sfide e l’avventura.
Simone era fragile, solo e insicuro, e non si fidava di nessuno.
Simone aveva perso i genitori da bambino e viveva con i nonni. La scuola non faceva per lui, non accettava ordini e fece del suo meglio per farsi cacciare. Iniziò a lavorare a sedici anni, coi primi guadagni si comprò una Cagiva 125, poi a diciotto passò alla RD 350, la moto più desiderata di tutte all’epoca.
Eppure per lui mancava sempre qualcosa, aveva un buco nero che non riusciva mai a riempire, lo capivo dalle tante confidenze che ci facevamo nelle serate birraiole dalla Gigina. Mi diceva che Ferrara gli stava stretta, che appena avesse messo da parte un po’ di soldi e fosse stato maggiorenne sarebbe andato via per sempre, mi parlava del Venezuela e di un suo improbabile cugino che abitava là. Non so quanto di quello che diceva fosse vero, ma so che mi piaceva ascoltarlo, era bravo a raccontare.
Anche se per breve tempo, Simone fu per me un vero amico, e credo di esserlo stato anch’io per lui, forse l’unico amico che abbia mai avuto. Almeno finché non conobbe colei che se lo portò via per sempre: si chiamava eroina!
La stessa che si portò via una decina di miei coetanei. Amici, compagni di scuola o semplici conoscenti, chi prima e chi anni dopo, se ne andarono tutti. Tutti allo stesso modo: accartocciati in qualche angolo sporco della città.
Il giorno dopo andai all’edicola sotto casa a comprare il Carlino: era il 2 gennaio 1983, i giornali riferivano gli avvenimenti risalenti alla notte di Capodanno poiché il primo dell’anno le testate non erano uscite. Sfogliai il giornale andando direttamente alla cronaca di Ferrara e vidi il titolo: “Giovane trovato senza vita la notte di Capodanno”.
Lessi l’articolo: “Alle prime luci dell’alba del nuovo anno una pattuglia di Carabinieri ha trovato il corpo senza vita di un ragazzo. Era rannicchiato ai piedi di una panchina nel parco adiacente ai Rampari di San Paolo in zona Acquedotto, si tratta del diciannovenne Simone B. residente in via Vignatagliata. Dai primi accertamenti pare che il decesso sia avvenuto per overdose di eroina. La scena ai Carabinieri è apparsa subito in tutta la sua drammaticità: il giovane giaceva esanime da alcune ore a pancia in giù sul terreno ghiaioso ai margini di una panchina col volto immerso quasi completamente nel fango di una pozzanghera e un giubbotto adagiato su un fianco, nel braccio era ancora infilata la siringa, le ginocchia piegate…”
Per un momento mi mancò il respiro.
Forse quella notte Simone fece sul serio un salto alla festa.
Forse quella notte venne a trovarmi per l’ultima volta, per l’ultima burla del destino.
E insieme, per un po’, ci divertimmo a fare le bollicine nel fango!