LA RICORRENZA
Buon 25 aprile
Buon 25 aprile!
Anche chi ha lottato per quell’alba di Liberazione, ma non ha potuto viverla perchè è morto per essa.
Benedetto Bocchiola (Marco)
Di anni 20, meccanico, nato a Milano il 14 maggio 1924. Dal marzo al giugno 1944 svolge attività di raccolta e rifornimento di armi per le formazioni in montagna, nei mesi successivi prende parte a varie azioni effettuando colpi di mano su caserme occupate da forze nazifasciste e posti di blocco. Arrestato il 10 ottobre 1944 in Valle Biandino (Lecco) nel corso di un rastrellamento. Processato il 13 ottobre a Casargo da un tribunale misto tedesco e fascista. Fucilato il 15 ottobre a Introbio (Lecco) con altri cinque compagni.
15.10.1944
Carissimi genitori,
vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che la mia salute è ottima come spero sia anche la vostra, non pensate per me perchè io sto bene. Se non riceverete mie notizie non allarmatevi.
Ricevete tanti saluti e tanti baci.
Vostro Nino
(Scritta poche ore prima della fucilazione, quando già conosceva la sua condanna)
Mario Brusa Romagnoli (Nando)
Di anni 18, meccanico aggiustatore, nato a Guardiaregia (Campobasso) il 12 maggio 1926. Nell’autunno del 1943 è nelle bande Pugnetto di Valli di Lanzo (Torino). Combatte sulle montagne di Genova, dove viene ferito una prima volta e arrestato, ma riesce a fuggire. Entra a far parte dei primi nuclei della Divisione autonoma Monferrato. Nel corso di un’azione da lui guidata vengono fatti prigionieri soldati e ufficiali tedeschi, viene nuovamente ferito. Non ancora guarito partecipa al combattimento del 25 marzo 1945 nei pressi di Brusasco-Cavagnolo, vicino Torino, e il 29 marzo mante guida un’azione contro un convoglio ferroviario tedesco sulla linea Milano-Torino viene ferito gravemente. Catturato verso la mezzanotte da una pattuglia del Reparto Arditi Ufficiali insieme ai tre compagni che tentavano di trasportarlo e condannato a morte quella stessa notte, mentre il comando partigiano tenta invano di concordare uno scambio di prigionieri. Fucilato il mattino del 30 marzo 1945 sulla piazza di Livorno Ferraris (Vercelli). E’ il fratello di altri due partigiani caduti.
Papà e Mamma,
è finita per il vostro figlio Mario, la vita è una piccolezza, il maledetto nemico mi fucila; raccogliete la mia salma e ponetela vicino a mio fratello Filippo.
Un bacio a te Mamma cara, Papà, Melania, Annamaria e zia, a Celso un bacio dal suo caro fratello Mario che dal cielo guiderà il loro destino in salvo da questa vita tremenda.
Addio. W l’Italia. Mario-Nando
Mi sono perduto alle ore 12 e alle 12 e 5 non ci sarò più per salutare la Vittoria
Domenico Caporossi (Miguel)
Di anni 17, elettricista, nato a Mathi Canavese (Torino) il 4 agosto 1927. Iscritto al Partito Comunista italiano, partigiano con il grado di sottotenente nella 80a Brigata Garibaldi operante nelle Valli di Lanzo e nel Canavesano. Il 17 febbraio 1945, recatosi a trovare i famigliari a Ciriè, viene catturato da elementi della Divisione Folgore. Incarcerato e torturato per 36 ore, viene fucilato senza processo il 21 febbraio 1945 sulla piazza principale di Verbania. Decorato di Croce di Guerra.
Cara Mamma,
vado a morire, ma da partigiano, col sorriso sulle labbra e una fede nel cuore. Non star malinconica io muoio contento. Saluti amici e parenti, ed un forte abbraccio e bacioni al piccolo Imperio e Ileno e il Caro Papà, e nonna e nonno e di ricordarsene sempre.
Ciau Vostro figlio Domenico
Eraclio Cappannini
Di anni 20, studente all’Istituto Industriale di Foligno (Perugia), nato a Iesi (Ancona) l’8 gennaio 1924. Nel novembre 1943 entra a far parte del 5a Brigata Garibaldi operante nella zona di Ancona e ne diventa Capo di Stato Maggiore. Partecipa ai combattimenti del gennaio e dell’aprile 1944 a Serra San Quirico e nei dintorni di Cabernardi e al colpo di mano per il sabotaggio del macchinario della Snia viscosa di Arcevia (Ancona), utilizzato dai tedeschi. Catturato all’alba del 4 maggio 1944 durante un trasferimento da un reparto tedesco presumibilmente guidato da un delatore. Viene fucilato senza processo il 5 maggio sotto le mura di Arcevia.
Arcevia 5 maggio 1944
Sono il giovane Cappannini Eraclio prigioniero dei tedeschi. Chi trova la presente è pregato di farlo avere alla mia famiglia, sfollata da Iesi a Serradeiconti presso il contadino Carbini. Cari Genitori e Parenti tutti; il mio ultimo pensiero sarà rivolto a voi ed alla mia, alla nostra cara Patria, che tanti sacrifici chiede ai suoi figli. Non piangete per me, vi sarò sempre vicino, vi amerò sempre anche fuori dal mondo terreno; voi sarete la mia sola consolazione. Siate forti come lo sono stato io.
Salutatemi tutti i miei conoscenti.
Vostro per l’eternità Eraclio
Bacioni alla piccola Maria Grazia
Ringrazio perennemente il latore
(Lettera scritta e abbandonata lungo il percorso fra il luogo della cattura e il luogo della fucilazione)
da “Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana”, a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli, Einaudi

















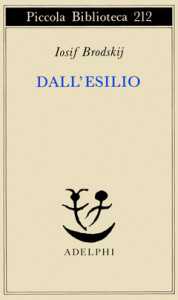

 Prepariamoci al grande evento, i Giardini Estensi, dal 30 aprile al 1 Maggio, a Ferrara. Prima di parlarvi dell’evento (a breve), e prepararci a questa consueta esplosione di colori, arriviamo per gradi, al 23 Aprile. Mancano pochi giorni, infatti, per partecipare a un concorso che, con tanta fantasia e buona volontà potrà portare i fiori su tutti i balconi della città e nelle sue più belle vetrine. Ci sarà spazio per ogni idea e iniziativa.
Prepariamoci al grande evento, i Giardini Estensi, dal 30 aprile al 1 Maggio, a Ferrara. Prima di parlarvi dell’evento (a breve), e prepararci a questa consueta esplosione di colori, arriviamo per gradi, al 23 Aprile. Mancano pochi giorni, infatti, per partecipare a un concorso che, con tanta fantasia e buona volontà potrà portare i fiori su tutti i balconi della città e nelle sue più belle vetrine. Ci sarà spazio per ogni idea e iniziativa.



















































