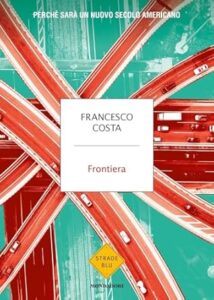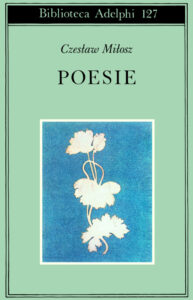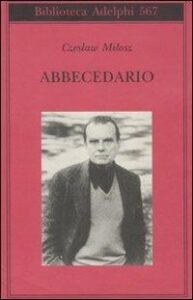“L’idea di poter risolvere tutto con il codice penale è solo propaganda, pericolosa demagogia”, scriveva Nordio in un libro del 2010. Più recentemente, nell’ottobre 2022, dopo il giuramento al Quirinale come ministro della Giustizia, il Guardasigilli aveva affermato che «la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati». Bisogna «eliminare questo pregiudizio che la sicurezza e la buona amministrazione siano tutelati dalle leggi penali: questo non è vero». Peccato che il disegno di legge (ddl) Sicurezza, presentato da Nordio, insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Difesa, Guido Crosetto, vada nella direzione di una panpenalizzazione.
Sono 13 i reati introdotti dal testo normativo. Ma tra nuove fattispecie incriminatrici, ampliamento di fattispecie già esistenti e definizione di ulteriori circostanze aggravanti con inasprimenti di sanzioni, si arriva a contare 24 interventi.
L’intenzione dichiarata è quella di porre un freno a determinate forme di criminalità, senza tuttavia spiegare se l’entità e la gravità delle violazioni siano tali da richiedere una massiccia azione normativa come quella realizzata dal ddl. A dire il vero, l’impressione è che la politica, con l’ausilio di alcuni media, tenda ad esasperare la percezione di certi illeciti, per alimentare l’istanza di sicurezza da parte delle persone e poi legiferare sull’onda emotiva collettivamente generata, amplificando così la discrasia tra la realtà percepita e quella effettiva. Il risultato sono norme penali “manifesto” che, anziché risolvere effettivamente i problemi che proclamano di voler prevenire e reprimere, hanno l’unico effetto di dare in pasto alla pubblica opinione nuove ipotesi criminose, ulteriori sanzioni e aggravi di pene già esistenti. Populismo penale, in sintesi.
Daremo conto di alcune fra le più rilevanti norme del ddl Sicurezza, mostrandone profili critici, incoerenze, e non soltanto.
La norma anti-Gandhi
L’articolo 14 del ddl dispone che sia punito a titolo di illecito penale – anziché di illecito amministrativo, com’è attualmente previsto – l’intralcio al traffico stradale o alla circolazione sui binari. La pena consiste nella reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro per chi attua il blocco con il proprio corpo. La reclusione è aumentata da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.
La norma è stata ribattezzata “anti-Gandhi”, rievocando il paladino della lotta di resistenza non-violenta, qual è quella che ispira manifestanti e ecoattivisti, vale a dire i soggetti che la norma stessa sembra finalizzata a colpire. Si può essere più o meno d’accordo sulle modalità in cui certe proteste sono realizzate, ma l’obiettivo della disposizione pare proprio quello di delegittimare esponenti della società civile, criminalizzando azioni di disobbedienza non-violenta dagli stessi realizzate.
Anche pacifici sit-in di studenti che fermano il traffico davanti alla scuola o di operai che fanno lo stesso dinanzi alla fabbrica – in buona sostanza, ogni manifestazione di dissenso contro quello che si ritiene sia un fatto ingiusto – potranno essere considerati reato. Una norma poco coerente e sanzioni sproporzionate rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla Costituzione (articolo 21).
La resistenza passiva nelle carceri e nei CPR
Gli articoli 26 e 27 del ddl, modificando alcune disposizioni rispettivamente del codice penale e del Testo Unico Immigrazione, introducono diverse misure riguardanti la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari nonché dei centri di trattenimento e accoglienza dei migranti. In particolare, il testo qualifica come crimini anche forme di mera disobbedienza o resistenza passiva e non-violenta, e le punisce con la pena della reclusione da 2 a 8 anni (da 1 a 6 anni se avvengono nei centri per i migranti), salve aggravanti. La norma va contro quanto affermato finora unanimemente dalla giurisprudenza, la quale ritiene rilevanti sul piano penale solo comportamenti attivi, che integrino una violenza o una minaccia o comunque un’azione percepibile come minacciosa, mentre esclude la punibilità di condotte di mancata collaborazione, di assoluta inerzia o che non si traducano nell’uso della forza. Eppure la nuova norma le sanziona comunque.
Il bilanciamento di interessi tra l’ordine pubblico e la libertà di manifestazione del pensiero, operato dal legislatore con la norma in discussione, pare non adeguato al principio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione. In altre parole, la necessità di mantenere condizioni di sicurezza nelle carceri o nei centri per i migranti non sembra sufficiente a giustificare una limitazione del diritto ad esprimere pacificamente il proprio pensiero attraverso comportamenti meramente omissivi quali sono quelli sanzionati dal ddl. Tali comportamenti spesso costituiscono l’unica forma di comunicazione a cui hanno accesso le persone imputabili del nuovo illecito. Con la conseguenza che i reati in via di introduzione rischiano di compromettere in maniera non legittima la libertà di espressione di soggetti che già ne godono in forma necessariamente limitata.
La sensazione è che si voglia mettere a tacere qualunque forma di protesta sulle condizioni disumane e degradanti delle carceri e dei centri per i migranti, anziché fare qualcosa di concreto per migliorarne la situazione.
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Il ddl Sicurezza, all’art. 10, prevede il reato di occupazione arbitraria di immobile (o delle relative pertinenze) – con una norma ribattezza “anti-Salis”, dal nome di Ilaria Salis, parlamentare europea nota, tra l’altro, per l’occupazione di un immobile avvenuta anni fa – e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso. In particolare, si punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
Quando si parla di questa ipotesi normativa come di un “nuovo reato”, sottintendendo che prima quella condotta non fosse punita dal codice penale, si afferma il falso. Il reato già esisteva, anche se formulato in termini più generali. L’articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o di edifici), infatti, già sanziona con reclusione e multa chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Al riguardo, c’è un profilo rilevante da sottolineare. Lo scorso aprile, la Corte Costituzionale si è espressa nel senso della legittimità della norma già vigente, che tutela in modo pieno ed effettivo il diritto alla proprietà. Tuttavia, secondo la Corte, se si ha estremo bisogno di una casa – ad esempio, perché lo Stato non vi provvede con i servizi sociali di housing – e si occupa in modo non-violento un immobile lasciato in stato di abbandono dal proprietario, nel bilanciare i principi dell’ordinamento il giudice può far prevalere quello della necessità abitativa rispetto ad altri. La nuova norma, più specifica, sull’occupazione di immobili inserita nel ddl Sicurezza non sembra escludere questa valutazione discrezionale, già ammessa per quella più generica. Il giudice potrà, quindi, riconoscere comunque la legittimità di occupazioni abusive, nonostante gli intendimenti del governo paiano andare in senso opposto a questa conclusione.
La norma anti-borseggiatrici
L’articolo 15 rende facoltativo, e non più obbligatorio come finora, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e dispone che esse scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). L’esecuzione non è comunque rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
Conclusioni
Si potrebbe ancora parlare dell’aggravante della pena per qualunque reato commesso «all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri», impostazione definita da Luigi Manconi come «una sorta di panpenalismo toponomastico che valuta l’entità della pena sulla base delle circostanze di luogo nel quale quel reato viene commesso»; o dell’altra aggravante, detta anti No-Ponte o No-Tav, in caso di «violenza o minaccia» a un pubblico ufficiale per protestare contro «la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica», che punisce specificamente alcune condotte già previste da una disposizione più generica, dimostrando l’ideologia sottesa alla scelta legislativa.
Questo, e molto altro, con la moltiplicazione delle norme e delle sanzioni, nonché talora con l’eventuale sovrapposizione di fattispecie criminali, andrà non solo a intasare i tribunali, ma soprattutto a peggiorare il sovraffollamento carcerario, che concorre all’elevato numero di suicidi che si registrano tra i detenuti. Se non si valutano ex ante i presupposti delle nuove disposizioni, quindi la reale necessità dell’intervento regolatorio, e gli effetti negativi che ne potranno derivare, né si va mai a verificare ex post che l’intervento stesso abbia davvero prodotto gli esiti sperati, ma si ha come bussola il sentimento espresso sui social dall’elettorato, si attua proprio quella «pericolosa demagogia» che Nordio stigmatizzava quando non era ministro. “Come si cambia” quando si sta al governo, si potrebbe commentare.
In copertina: Giorgia Meloni e Carlo Nordio – immagine da vialibera.it