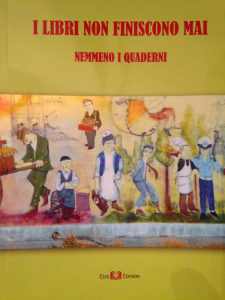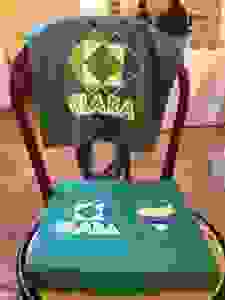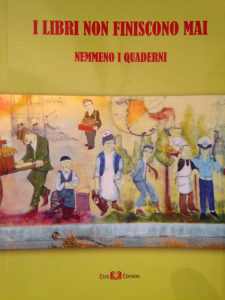Dove lo metto? Abbiamo chiesto ai nostri lettori in quale posto, nella coppia, preferirebbero trovare l’altra persona, a quale distanza sarebbe meglio stare o lasciare perchè le cose funzionino.
Di lato, di fronte, vicino ma non troppo, una geometria variabile in cui ciascuno ha le proprie misure e dove sembra vitale potersi spostare.
Ecco le lettere arrivate in redazione:
Tra i piedi
Cara Riccarda,
Noi possiamo stare solo di fianco. Non al mio fianco, di fianco. A volte tra i piedi.
Possiamo stare solo così, non siamo neanche allineati, qualche volta lui capisce e lo trovo al mio fianco, a volte tra i piedi.
E’ un equilibrio precario, di due persone diverse, senza interessi in comune, idee diverse, obiettivi differenti. Entrambi ambiziosi. L’unica cosa che ci unisce è la consapevolezza che l’altro ha rinunciato a parecchie cose pur di stare “di fianco”.
V.
Cara V.,
essere tra i piedi non lo trovo così negativo perchè può fare inciampare nell’altro e, per me, è sempre meglio che un cammino in solitudine. E’ l’unione in nome di una rinuncia che mi lascia perplessa, soprattutto perché tu la senti come ‘l’unica cosa’ che vi connette. La vita in due richiede di lasciare da parte qualcosa, però poi c’è sempre una compensazione, a volte si tratta solo di averne coscienza, o se preferisci, ‘consapevolezza’.
Riccarda
L’amore vero trova da sé il proprio posto
Cara Riccarda,
dopo essere stata io, per molto tempo, a cercare un posto adatto intorno ai miei uomini, prima con un padre despota e poi con un marito egoista e narciso, ho sentito la necessità di collocarmi al centro!
Poi è arrivato l’amore… quello vero, quello in cui la coppia trova da sè il proprio posto, interscambiandosi.
Il mio uomo lo voglio lì, dove posso trovarlo quando mi giro e che sa stare un passo indietro quando necessito di fare “da sola”!
Ho imparato che lo spazio vitale è molto importante e necessario, è bello condividere spalla a spalla, confrontarsi, uno di fronte all’altro…esserci ma non opprimerci!
So che alle volte è complicato e siparietti come quelli descritti da te credo siano frequenti. Trovo stancante e imbarazzante cercare di collocare il proprio uomo in situazioni dove già si sa non troverà il giusto posto! E parlo per esperienza.
Il posto giusto, secondo me, è quando non ti chiedi….Dove lo metto?
Nadia
Cara Nadia,
che bella la tua centralità che è diventata la premessa di tutto il testo. Immagino la liberazione di non dovere più cercare un posto adatto a te, di non chiederti dove sia meglio stare e con quale ruolo. Quante energie a volte buttiamo in questo affanno che non soddisfa mai nessuno.
Il non pensare a dove mi metto, secondo me, ti ha permesso di non chiederti dove lo metto, e di trovare sempre chi vuoi vicino.
Riccarda
L’amore allo specchio
Cara Riccarda,
idealmente o razionalmente vorrei che tra me e il mio uomo i posti fossero continuamente intercambiabili a seconda dei momenti e delle situazioni.
Vorrei che lui stesse un passo indietro quando mi dedico a mio figlio o quando ho bisogno di ritirarmi in me stessa per sentirmi e ascoltarmi. Vorrei stesse due passi in avanti quando ho bisogno di lui per allargare il campo della mia visuale, perché mi possa offrire prospettive diverse dalle mie e mi indichi orizzonti più lontani.
Vorrei sentirlo spalla a spalla nella condivisione della quotidianità, della vita sociale e dell’intimità, nel supporto e sostegno reciproci.
Vorrei fosse il mio specchio ogni volta che discutiamo o ci arrabbiamo, perché so che ciò che in quel momento non sopporto di lui non sono altro che parti di me che non voglio vedere o accettare.
Mi chiedo però se tutto ciò si possa realmente scegliere…al cuor non si comanda ed proprio il cuore l’unico posto dove vorrei fosse il mio uomo.
Un abbraccio
Simona
Cara Simona,
ho la sensazione che tu stia scrivendo, o meglio, descrivendo, ciò che vivi e conosci. E se è così, non è solo fortuna, è impegno, scelta, tempo per guardare verso tutti i possibili posti. Una danza continua che però ha bisogno anche di qualche pausa in cui, come giustamente dici, occorre ritirarsi un po’ per poi riprendere, magari con un altro passo e un altro ritmo. C’è una cosa su cui concordo più di tutte: la distanza che può esserci fra due persone, se non scivola nell’abisso, può diventare un’opportunità per uno sguardo più ampio.
Riccarda
Maschi dispettosi e infantili?
Cara Riccarda,
siccome spesso sono insopportabili, gli uomini è meglio lasciarli fuori dalle amicizie fra donne, a meno che non ci si trovino per caso. Credo anche che siano dispettosi come quando avevano otto anni.
Daniela
Cara Daniela,
ti rispondo con un messaggio speculare che mi ha scritto un amico, ferraresissimo, commentando il tema: l’oman l’ha da star luntan da il vostar ciacar.
Riccarda
Dove stare?
Cara Riccarda,
no, il posto fisso non c’è. Ma com’è dura capire dove stare. Spesso le intenzioni migliori vengono male interpretate, specie se vuoi lasciare quella libertà che lei chiede. O fai la figura dell’appartato o quella di chi si vergogna di lei. E quando uno ha una vita propria e deve essere anche in grado di gestire il rapporto a due, dove può collocarsi? Le invasioni di campo sono sanzionate? Tollerate? Gradite? A seconda delle circostanze?
Filippo
Caro Filippo,
un posto cristallizzato è sempre pericoloso, rischia di non essere coincidente con la persona che si assume o è confinata in quella parte. Credo che la partita vada giocata, per entrambi, con la capacità di spostarsi al bisogno, accettando anche un posto diverso, panni nuovi e perchè no invasioni di campo. Il rischio maggiore, mi pare, sia obbligare e obbligarci alla stessa immutabile posizione.
Riccarda
Un posto mobile condiviso
Cara Riccarda,
dove lo vorrei… La premessa è avere lo sguardo nella stessa direzione, ma il posto fisso no, impossibile. Se saremo capaci di guardare sempre verso la stessa meta, quando io sarò in difficoltà, lui più forte e (spero) davanti, mi tenderà la mano per portarmi al suo fianco, così farò io quando sarà lui ad avere bisogno, facendo in modo che comunque ognuno di noi percorra la strada, con le proprie gambe. Il posto fisso no e forse pretenderlo porterebbe alla fine di tutto.
Ecco, accettare il posto non fisso, penso porti a rendere più forte il legame.
S.
Cara S.,
posso dire, in questo caso, viva il precariato? Ma è più efficace come l’hai definito tu “posto non fisso” come spazio necessario alla solidità fra due persone.
Riccarda
Accanto ma non troppo
Cara Riccarda,
credo che l’importante poi in fondo non sia dove metterlo, ma come, quando e in che modo.
Mi piace pensare che la persona con cui si ha deciso di condividere questa vita ti stia vicino, non troppo, ma vicino.
Sia vicina quanto basta per camminare magari affiancati ma senza urtarsi, uno di fronte all’altro anche, ma avendo sempre un punto di vista sgombero e libero. Lo metterei accanto, ma non troppo. L’impegno è quello di mantenere quella stessa distanza, nel tempo, senza allontanarsi troppo, senza avvicinarsi troppo.
Quanto basta.
Quanto basta per essere felici indipendenti, quanto basta per stendere il braccio e afferrarlo con la mano.
Buone feste
C.
Cara C.,
il tuo quanto basta è come quello delle ricette: bravo chi lo azzecca. Ma a forza di provare poi ci si prende la mano, giusto?
Riccarda
Un cambio in meglio
Cara Riccarda,
avevo un uomo al mio fianco che, nel momento del bisogno, si metteva dietro di me. Ora ho un uomo che sta dietro di me, ma che, nel momento del bisogno, mi sta davanti.
Debora
Cara Debora,
niente male come staffetta, ma non credo sia casuale.
Riccarda
Utopie? Direi di no
Cara Riccarda,
io vorrei un uomo laterale spalla alla spalla per essere protetta, supportata, sopportata e viceversa. Di fronte per potermi specchiare e confrontarmi. Ma questa è solo utopia.
A.
Cara sfiduciata A.,
ho volutamente lasciato la tua e-mail per ultima perchè le lettere pubblicate sopra possano parlarti meglio di quanto sappia fare io.
Riccarda
Potete inviare le vostre lettere a: parliamone.rddv@gmail.com