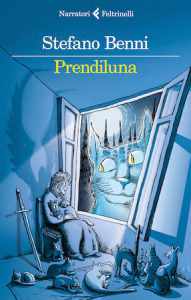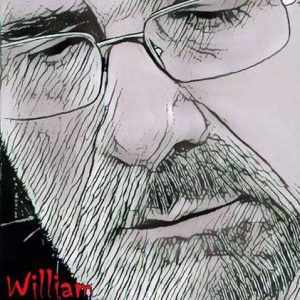Storia di Maria Rita Storti: da insegnante a premiata produttrice cinematografica

“Ci sono esperienze, nella vita, che vale la pena di vivere e basta: bisogna solo non aver paura di mettersi in gioco”. Impossibile non dare ragione all’insegnante Maria Rita Storti, la prima a credere nel film sul terremoto dell’Emilia, ‘La notte non fa più paura’, opera prima del regista Marco Cassini. La docente ferrarese nel 2014 si offrì come produttrice di un progetto che stentava a decollare: un film per raccontare il terremoto del 2012, il senso di precarietà che il sisma aveva fatto avvertire ai ferraresi, descrivendo al tempo stesso l’incertezza delle condizioni sociali che rendono instabile la vita quotidiana. Insegnante di Filosofia e Scienze Umane al Liceo di Codigoro, abituata a lavorare e a rapportarsi con i ragazzi, Maria Rita Storti era così convinta di questa idea, così come del talento e della determinazione dei giovani professionisti coinvolti nel progetto, che decise di stanziare il contributo fondamentale per la realizzazione della pellicola, non curandosi di chi guardava con sospetto la sua ‘follia’.
“La ‘meravigliosa follia’ della ‘Notte’, è stata un’esperienza umana e conoscitiva importante – racconta Maria Rita -, che mi ha permesso di incontrare persone splendide e di imparare tante cose che non conoscevo del mondo del cinema”.
Autentica, spontanea, curiosa, profonda, empatica, l’insegnante tresigallese ama la cultura: adora leggere, viaggiare, condividere esperienze.
La foto delle sue scarpe da ginnastica immortalate sul ‘Red Carpet’ della Festa del Cinema di Roma (scelta come profilo sulla pagina Facebook) rivela la sua ironia e la sua capacità di essere ‘unconventional’, sopra le righe.
‘La notte non fa più paura’ dal 2015 continua a collezionare prestigiosi riconoscimenti. Ma Maria Rita ha scelto di non adagiarsi sugli allori e di rituffarsi in un nuovo progetto giovane.
Nei giorni scorsi a New York, in occasione della presentazione di New Young Cinema – una community di giovani professionisti del cinema, creata con lo scopo di conoscersi e scambiare esperienze tra italiani e statunitensi – è stato presentato il trailer de ‘La porta sul buio’, opera seconda del regista Marco Cassini. Questo nuovo film vede ancora il coinvolgimento di Maria Rita Storti: “Ho 58 anni, e ‘quelli del film’, che potrebbero essere tutti miei figli, affettuosamente mi chiamano ‘boss’ o ‘zia’. Adesso sono diventata ‘bi-boss’ o ‘superboss’ o ‘zinna’”.
Di che cosa parla ‘La porta sul buio’?
È una storia completamente diversa dalla ‘Notte’. È un film tratto da un testo teatrale scritto da Marco Cassini nel 2009 (il volume è disponibile su Amazon), già rappresentato con successo a teatro. Per il film, girato a Pescara nel maggio scorso, sono state scelte maestranze abruzzesi, ma con un respiro internazionale. È una storia di suspense, con tre protagonisti, ambientata in un appartamento; c’è paura e tensione drammatica ma anche commedia: la porta è il simbolo di un Altro e di un Altrove. ‘La porta sul buio’ si potrà vedere al cinema nel 2018.
Che cosa l’ha spinta a sostenere questa seconda pellicola?
È stata l’esperienza de ‘La notte non fa più paura’, unita alla stima e all’amicizia che ho per Marco, che mi ha fatto scegliere di essere coinvolta anche in questo film. Oltre al regista Cassini ci sono altri professionisti che ammiro e che hanno lavorato alla prima pellicola: Martina Colli per la colonna sonora (stupenda quella della ‘Notte’) e il tresigallese Stefano Muroni, uno degli attori protagonisti.
La prima ‘scommessa’ è andata a segno, con risultati che hanno superato le aspettative. Non ha paura di lanciarsi in una nuova avventura?
Ho deciso di nuovo di fidarmi della mia lungimiranza. Con ‘La notte’, per me la soddisfazione è aver intuito che valeva la pena dare fiducia a questo progetto culturale, che ispirava la mia sensibilità artistica. Amo leggere, sono una lettrice onnivora, mi piace il buon cinema, andare a teatro, viaggiare, oltre alla buona tavola (sorride). Ho scritto anche un testo che è stato messo in scena in teatro a Tresigallo il mese scorso.
Come è andata con ‘La notte non fa più paura’?
Il percorso del primo film è stato accidentato, ma alla fine ha portato risultati sorprendenti: ‘La notte non fa più paura’ ha ottenuto a giugno una menzione speciale ai Nastri d’Argento ed è stato ammesso ai David di Donatello 2018. Inoltre è stato acquistato da Sky Cinema, ed è uscito un libro in edizione limitata con le foto scattate sul set.
‘La notte non fa più paura’ rappresenta un punto di arrivo incredibile per un ‘piccolissimo-grandissimo’ film indipendente, girato in dieci giorni e con pochi soldi. Arrivare a questi risultati era impensabile, anche per me che l’ho finanziato per la maggior parte. Situazione quasi unica nel panorama del cinema raggiungere questi risultati con un’insegnante di un liceo di provincia come ‘produttrice-mecenate’!

Perché ha deciso di finanziare il film?
La storia è nota a tanti. Dopo il terremoto del 2012, Walter Cordopatri, Samuele Govoni e Stefano Muroni scrivono il soggetto di una storia ambientata ai tempi della crisi economica, a cui si aggiunge il terremoto che ne amplifica, in maniera tragica, le difficoltà. I ragazzi contattano un giovane regista di Teramo, Marco Cassini, che da abruzzese aveva vissuto il terremoto del 2009 a L’Aquila, e una produttrice esecutiva ferrarese, Ilaria Battistella.
Trovare i soldi per girare il film non era facile: dopo 47 ‘NO’ raccolti nel giro di un anno mezzo, alla fine io decido di versare parte dei risparmi personali (ventimila euro) perché questo film venga girato. Lo ritenevo, infatti, un film necessario per lasciare testimonianza di quel periodo, per onorare la memoria di chi è morto sotto i capannoni, per contribuire – attraverso una narrazione – alla rielaborazione delle ferite dell’anima in chi è rimasto. A questi miei soldi, poi se ne sono aggiunti altri sotto forma di piccoli finanziamenti provenienti da vari soggetti. Nel settembre 2014 il film è stato girato a Mirabello.
C’è un momento, tra i tanti vissuti in questi tre anni, che per lei resta indimenticabile?
Beh, è stato impagabile vedere il sorriso e il guizzo di commozione negli occhi blu di Marco Cassini mentre mi diceva ‘Grazie!’ il giorno in cui l’ho conosciuto.
Ma questo ormai fa già parte del passato…
Adesso che sono stati raggiunti traguardi importanti, sono in molti a complimentarsi, e questo mi fa piacere, ma io penso già alla nuova avventura della ‘Porta sul buio’. Con l’entusiasmo alle stelle.