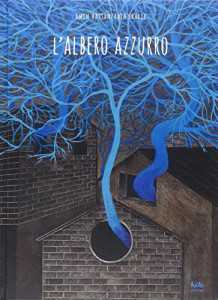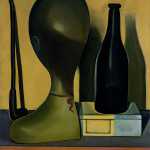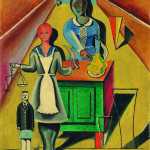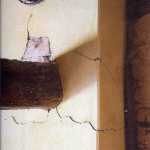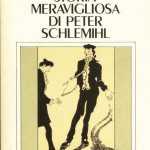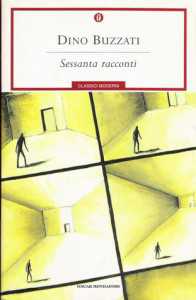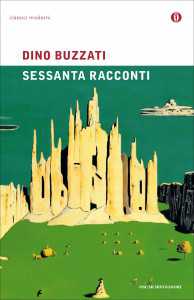LA CITTÀ DELLA CONOSCENZA
Formazione: Italia sempre alla rincorsa, è ora di confessarci il perché
Lo scadere di ogni anno porta con sé il tempo dei bilanci. Sul terreno dell’istruzione e della formazione ci forniscono spunti di riflessione l’annuale rapporto dell’Ocse “Education at a Glance” e, in casa nostra, il “Rapporto sul benessere equo e sostenibile” dell’Istat. Da tempo le ricerche internazionali utilizzano il livello di istruzione come misura indiretta del capitale umano, hanno dimostrato che le persone con un alto livello di istruzione in genere godono di una salute migliore, sono socialmente più impegnate, il loro tasso di occupazione è maggiore e i guadagni più elevati. Da questo punto di vista dovremmo essere davvero preoccupati del nostro 41% di popolazione, tra i 25 e i 64 anni, con un livello di istruzione al di sotto della secondaria superiore, contro la media Ocse del 24%. Per non parlare del nostro esiguo 17% con un livello di istruzione terziario contro la media Ocse del 34%, esattamente la metà. Nel conto va considerato che l’accesso all’università da noi è ostacolato dal numero chiuso e dai test di ammissione, non è gratuito come in Germania e i nostri studenti non godono di supporti economici.
Ma guardiamo le cose in positivo, il rapporto dell’Istat in materia di istruzione esordisce con un titolo rassicurante: “Migliorano i livelli di formazione e si riduce il divario con l’Europa”. Non dice però che, da dieci anni a questa parte, tutti i paesi dell’Ocse registrano un progressivo miglioramento, ma i tassi di incremento nel nostro paese sono tra i più bassi, pertanto inadeguati a colmare la distanza accumulata.
Si ha l’impressione che gli ‘zero virgola’ più che una tendenza al miglioramento registrino gli effetti del naturale avvicendarsi generazionale. Man mano che nei rilevamenti statistici ci si approssima a popolazioni che hanno beneficiato dell’istruzione di massa, anche gli indici di percentuale sono destinati a mutare. A non mutare invece è la capacità di aggredire ciò che del nostro sistema formativo continua a non funzionare. L’Italia si conferma un paese che in materia di cultura e istruzione ha due velocità tra Nord e Sud, un paese in cui le condizioni di partenza per censo e cultura fanno ancora la differenza.
I dati non ci dicono nulla di diverso da quanto già non sapessimo; ci saranno anche quelli che spasimano per uno zero virgola in più o in meno, ma il dato di fondo non cambia: ci troviamo di fronte a politiche formative mal disegnate, incapaci di garantire equità e mobilità sociale.
Siamo lontano dall’obiettivo, uscito dal summit mondiale sull’istruzione tenutosi a novembre a New York, di garantire entro il 2030 un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa per tutti, accrescendo le opportunità di apprendimento permanente per le persone di ogni età.
Una cosa, per esempio, che non viene detta nei rapporti statistici di casa nostra, è che l’Italia non partecipa alle indagini Ocse sui livelli di competenza della popolazione adulta, il Piaac (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). L’istruzione degli adulti, che incide sui livelli culturali complessivi del paese, è un capitolo da noi ancora ampiamente trascurato. L’Italia, tanto per incominciare, non fornisce dati circa la padronanza delle tecnologie informatiche e la capacità di problem solving da parte della sua popolazione adulta, su questo terreno preferiamo non confrontarci con gli altri paesi dell’Ocse. Misuriamo invece i nostri livelli culturali computando i libri che leggiamo, con quanta frequenza andiamo al cinema e a teatro, per non parlare della lettura dei giornali, che pare essere crollata. Insomma nei casi migliori rimaniamo aggrappati ai cliché culturali della tradizione, disdegnando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione.
Quando si arranca per recuperare strada, per raggiungere gli altri, difficilmente si è in grado di vedere cosa c’è oltre la linea d’arrivo dei nostri sforzi. E questo è l’errore che ci manterrà sempre in ritardo, perché mentre noi siamo impegnati nella rincorsa, gli altri partono per traguardi più avanzati, lasciandoci così sempre più indietro. Allora, forse, cambiando la macchina anche noi potremmo darci obiettivi nuovi e più ambiziosi, anziché continuare a inseguire quelli ormai mancati.
Fotografare il presente resta una buona pratica, registrare gli output del nostro sistema formativo è utile per dirci quanta distanza ci separa dagli altri, ma non ci aiuta a guardare più lontano. Se il sistema formativo non cambia non possiamo attenderci performance molto differenti da quelle che ormai da anni registrano sia i dati Ocse che i dati Istat.
Inseguire indicatori come il numero di diplomati, di laureati, di abbandoni scolastici, eccetera è come il serpente che si morde la coda, perché si continuano a rilevare e misurare i sintomi senza mai aggredirne le cause. Alla narrazione degli output dovremmo imparare ad accompagnare la narrazione degli input e degli indicatori di processo, quelli che potrebbero davvero cambiare la trama dei racconti e assicurare un finale una volta tanto diverso da quelli già conosciuti. Quali sono questi indicatori? La qualità degli insegnamenti e di chi insegna, la qualità degli ambienti dove si impara e come si impara. Attori e politiche dell’istruzione, questo è il nostro teatro dei pupi che ogni anno mette in scena il copione della formazione nel nostro paese.