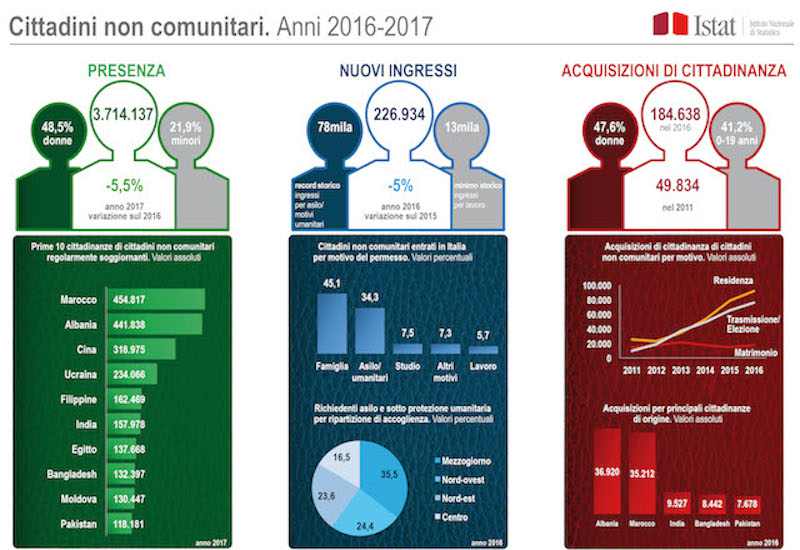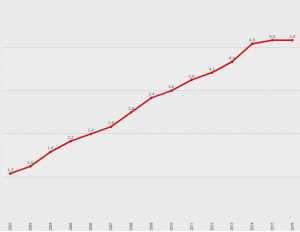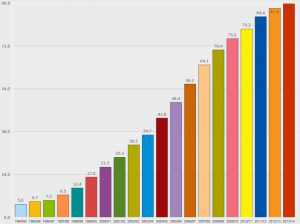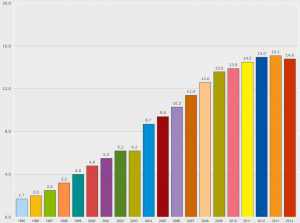Al Meis in mostra primi mille anni di Y-Tal-Ya, l’isola della rugiada divina
di Riccardo Gnudi
“Il primo lotto che inauguriamo è costituito dall’ex-carcere di Ferrara ristrutturato in modo impeccabile per essere adibito a una nuova destinazione d’uso: in una sorta di contrappasso da luogo di segregazione ed esclusione quale è stato per tutta la durata del Novecento si appresta ad assumere il ruolo quanto mai significativo di centro di cultura, di ricerca, di didattica di confronto e dialogo e quindi in una parola di inclusione”. Con queste parole il Presidente della Fondazione Meis Dario Disegni ha aperto mercoledì mattina, 13 dicembre, la conferenza stampa di presentazione della prima grande mostra del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, ‘Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni’, in quello che una volta è stato il corpo principale delle carceri cittadine.
All’incontro con la stampa, oltra a Disegni, hanno partecipato il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, il responsabile delle attività culturali di Intesa Sanpaolo Michele Coppola e Daniele Jalla, curatore della mostra insieme ad Anna Foa e Giovanni Lacerenza.
“L’apertura del primo grande edificio del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah con questa mostra che abbiamo chiamato ‘Ebrei una storia italiana. I primi mille anni’ – ha continuato Disegni – rappresenta una tappa di grandissima rilevanza della realizzazione del museo istituito dal Parlamento della Repubblica. Il MEIS verrà poi completato entro la fine del 2020 con la costruzione di cinque edifici moderni connotati da volumi che richiamano i cinque libri della Torà”, dando così vita ad un grande complesso museale e culturale. “Decisivo per il raggiungimento di questo grande obiettivo il supporto del ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo che ha garantito l’intera copertura economica del cantiere grazie al forte sostegno del Ministro Franceschini”, ha concluso il Presidente della Fondazione Meis.

Lo stesso Franceschini ha sottolineato la propria emozione: “E’ una giornata personalmente emozionate perché arriva a compimento di un percorso che è iniziato molti anni fa, è un segnale di grande attenzione da parte di tutto lo Stato con la presenza del Presidente della Repubblica questo pomeriggio”. E, da ferrarese, il titolare del Mibact non ha rinunciato a evidenziare ancora una volta il doppio filo che lega Ferrara con la Ferrara ebraica: “Molti mi hanno chiesto perché Ferrara: perchè Ferrara nei secoli di difficoltà ha accolto con solidarietà la comunità ebraica, perché Ferrara è conosciuta nel mondo per Bassani, ‘Il Giardino dei Finzi Contini’, un luogo che esiste, se non concretamente nella città, certo nei nostri cuori ma che non esiste . L’ebraismo a Ferrara è dentro le pietre, dentro le persone. A Ferrara c’era la Nuta, con il suo negozietto in via Mazzini, dove ho potuto conoscere cose meravigliose: la cucina dello storione e del caviale secondo le ricette ebraiche tramandate di generazione in generazione. La cultura ebraica si è incrociata con la vita di tutte le persone”. Tornando al progetto del museo nazionale dell’ebraismo e della Shoah, Franceschini ha affermato: “E’ un impegno che si è concretizzato prima con la legge poi con i finanziamenti, che consentono di completare questo progetto nella parte che vediamo oggi e nella parte che di architettura contemporanea”, che sarà costruita da qui al 2020. “Penso che ci sia un grande futuro a livello internazionale per questo museo, siamo stati insieme al Presidente Disegni e Simonetta Della Seta a presentare il Meis a Gerusalemme e New York e abbiamo trovato una grandissima attenzione perché la storia degli ebrei italiani è conosciuta in tutto il mondo forse più che in Italia. Portare qua i giovani significa investire in conoscenza, investire in conoscenza significa offrire l’antidoto più forte a tutti i rischi e le paure di questo tempo”, ha concluso il Ministro.
La parola è poi passata al sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani: “Io, Renzo Gattegna e Carla Di Francesco abbiamo avviato questo percorso nel periodo tra le due disposizioni normative che regolano l’esistenza del Meis tra il 2003 e il 2006, un ruolo il nostro diverso, ma con una decisione e una caparbietà seconda solo al Ministro nel portare a compimento un’opera significativa per il nostro paese. Non dobbiamo dimenticare il ghetto, i secoli successivi, il contributo che gli ebrei hanno dato alla Prima guerra mondiale. Non dimentichiamo quella classe borghese ricordata nella video rappresentazione di Carrada che ci richiama alla presenza del podestà ebreo di Ferrara, che ha vissuto il passaggio dal governo della città alle leggi razziali e alle persecuzioni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa storia, credo ci sia stata una collaborazione importante tra la città e il Meis”.
Nel corso della mattinata, infatti, è stata inaugurata anche l’installazione multimediale ‘Con gli occhi degli ebrei italiani’, a cura di Giovanni Carrada – autore di ‘Superquark’ – e di Simonetta Della Seta, direttore del Meis, con la ricerca iconografica di Manuela Fugenzi, la regia di Raffaella Ottaviani e la colonna sonora di Paolo Modugno. Ai visitatori, stretti fra due grandissimi schermi, l’installazione immersiva offre la possibilità di fare un viaggio nel tempo con l’intento di coinvolgere fin dall’inizio il pubblico nei temi che il percorso espositivo del Meis esplorerà.
Una sorta di introduzione a una vicenda che pochi conoscono davvero: la storia degli ebrei e dell’ebraismo in questo paese, perché la loro è una storia che a scuola non si insegna, se non per parlare della Shoah. Una storia che il Meis, una volta completato, narrerà per intero. La mostra inaugurata mercoledì pomeriggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non a caso si intitola ‘Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni’, narra l’inizio di una vicenda che, fra alti e bassi, dura da 22 secoli, e che ha caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre vicende della Diaspora: I-Tal-Ya in ebraico significa “l’isola della rugiada divina”. Lo fa in uno spazio di più di mille metri quadrati e oltre duecento oggetti preziosi, manoscritti, epigrafi di età romana e medievale, e centoventuno tra anelli, sigilli, monete, lucerne e amuleti, poco noti o mai esposti prima, provenienti dai musei di tutto il mondo: dalla Genizah del Cairo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dai Musei Vaticani alla Bodleian Library di Oxford, dal Jewish Theological Seminary di New York alla Cambridge University Library.
L’obiettivo dei curatori e del Meis è suscitare riflessioni, attraverso la scoperta e la conoscenza di una parte della nostra storia poco nota: un indiretto invito a porsi domande e a ricercare le risposte, che oggi, a differenza del passato, non possono prescindere dai valori del riconoscimento e del rispetto dell’altro e del diverso.
‘Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni’ e ‘Con gli occhi degli ebrei italiani’ saranno aperti fino a domenica 16 settembre 2018. Sono visibili dal martedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00, e il giovedì dalle 10.00 alle 23.00. Giorni di chiusura: tutti i lunedì, 31 marzo (primo giorno di Pesach), 10 settembre (primo giorno di Rosh Hashanà) e 19 settembre (Kippur).
Maggiori info su www.meisweb.it