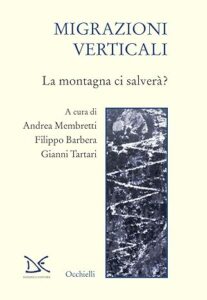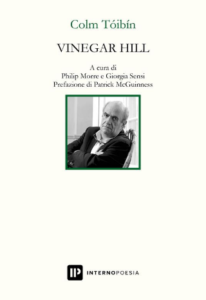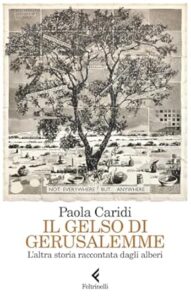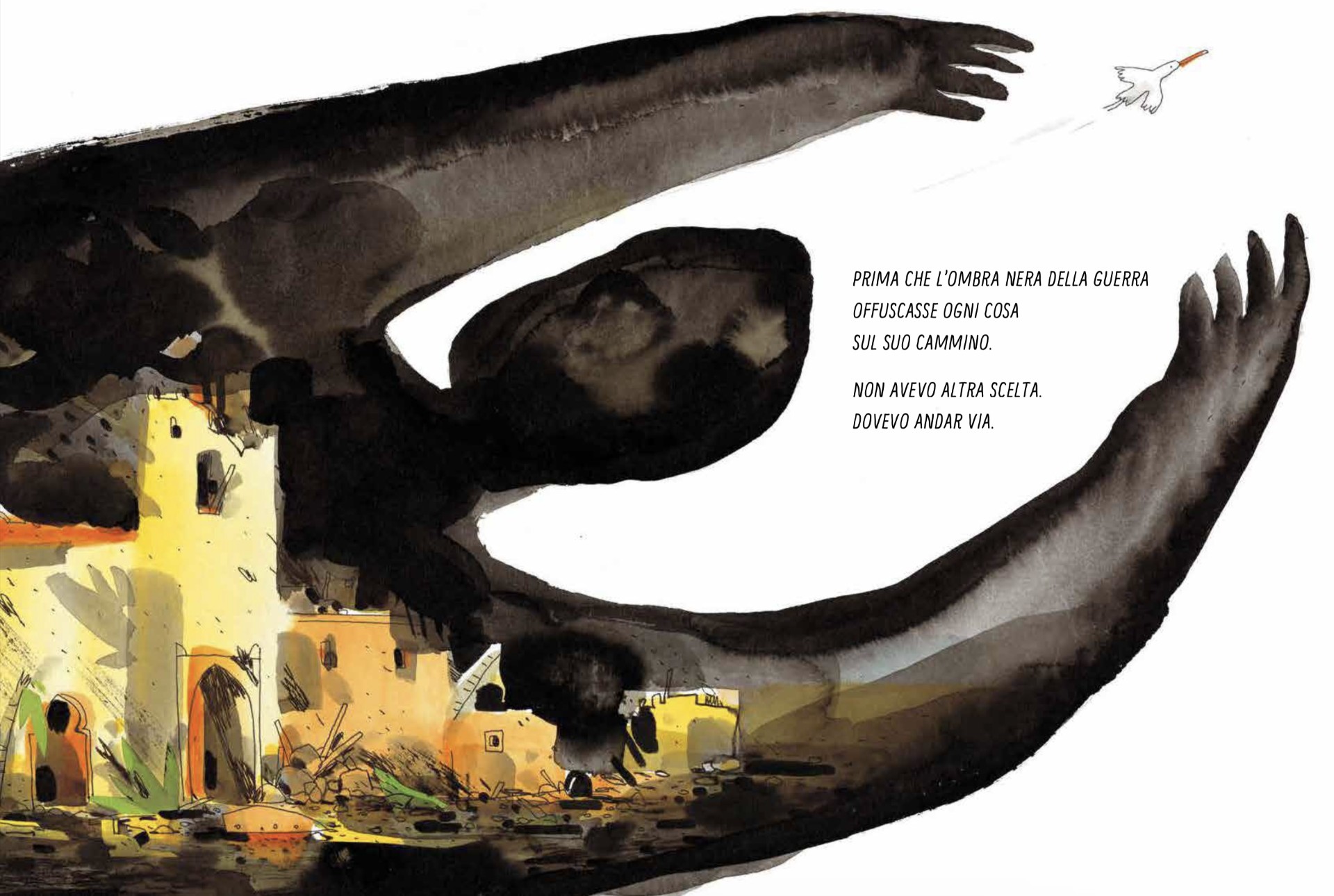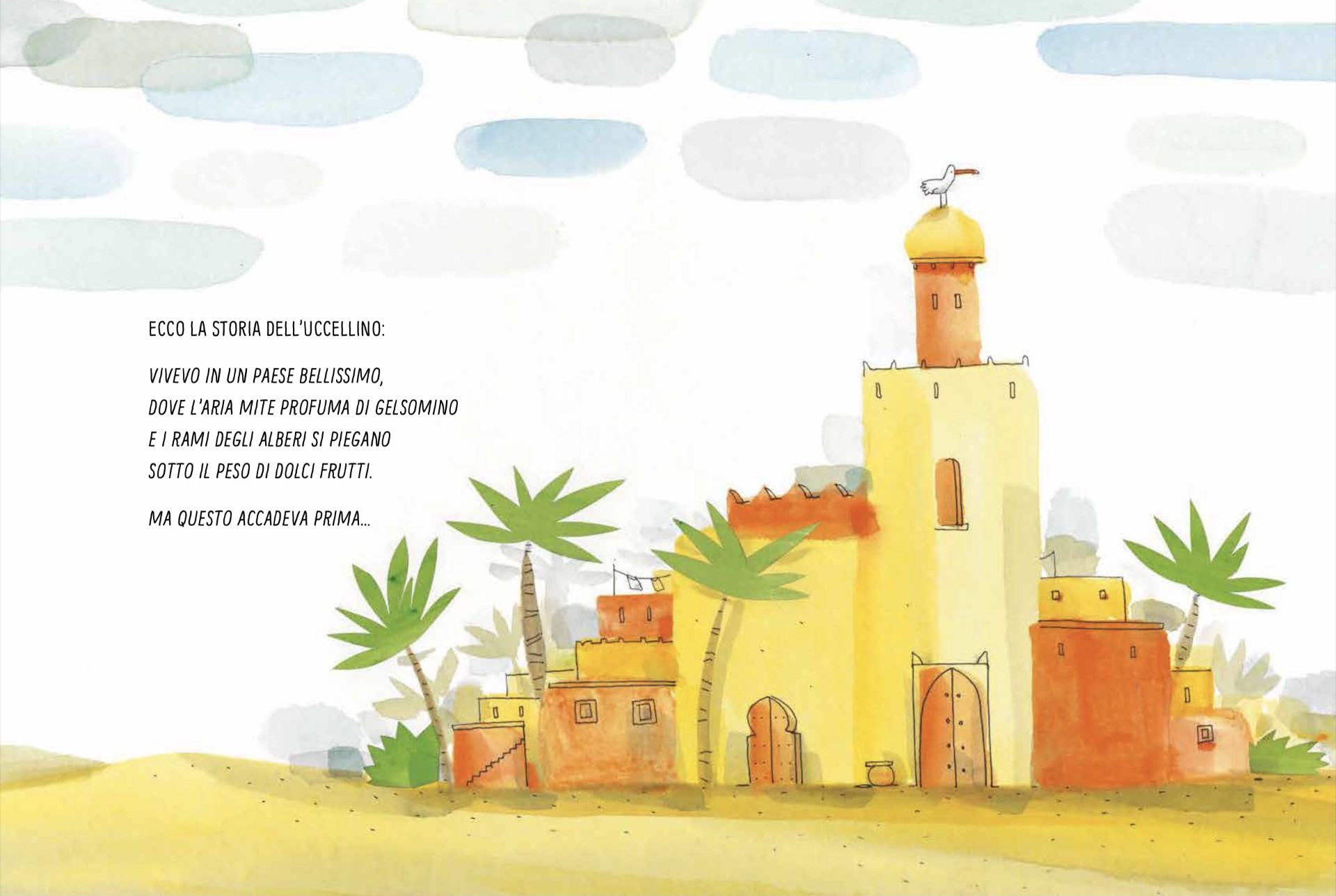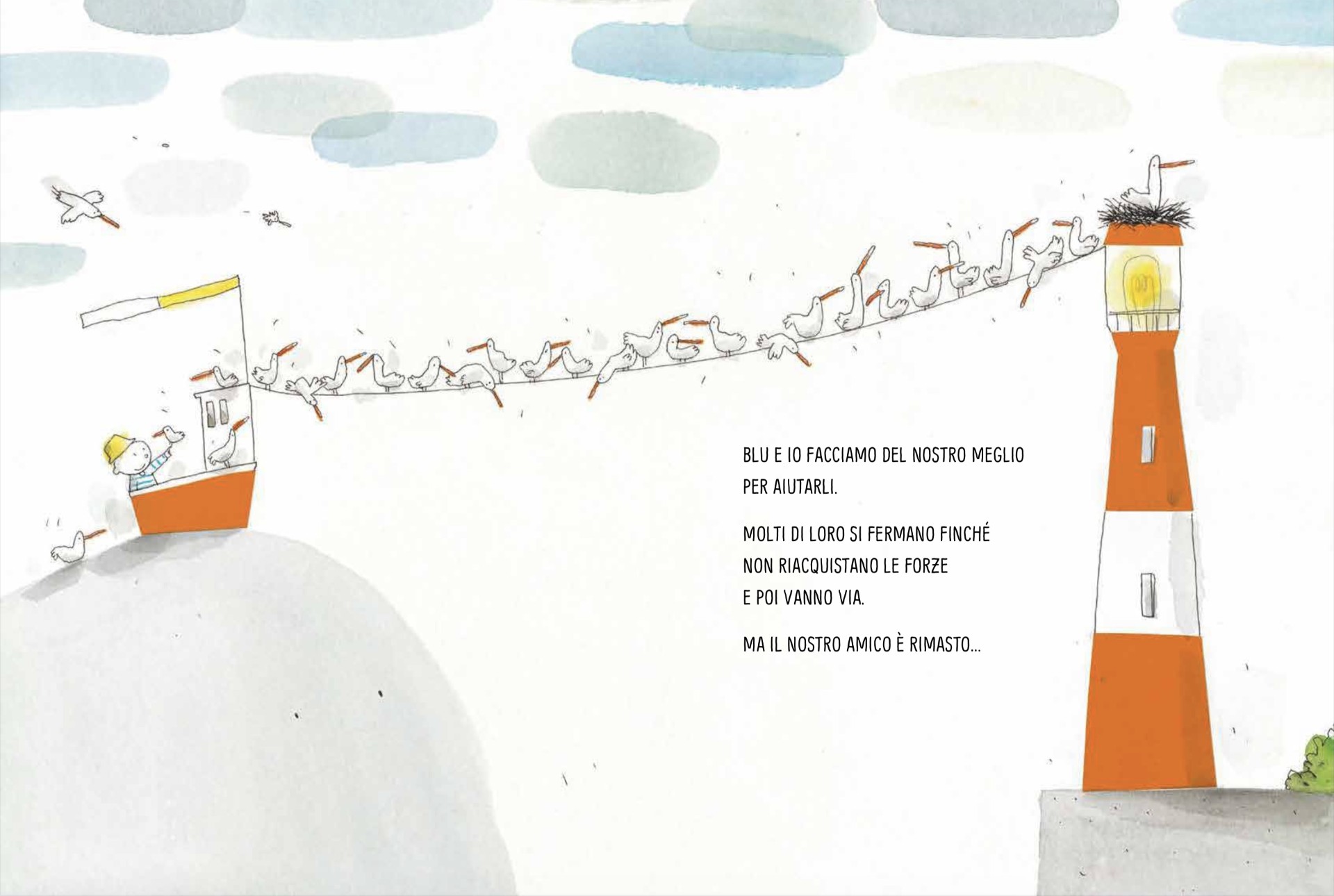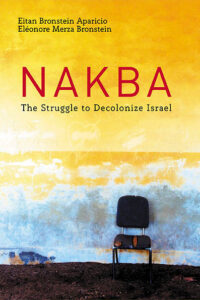Lettera dal carcere di Ferrara al Presidente della Repubblica
Un gruppo di persone detenute nella Casa Circondariale di Ferrara ha scritto una lettera che ha inviato al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Ministro di Giustizia. Propone spunti di riflessione alternativi sul tema delle condizioni delle persone ristrette in carcere e suggerisce alcuni interventi urgenti. È scritta con intelligenza e garbo, evitando critiche sterili. Diventa pertanto credibile e degna di essere presa in considerazione in quanto scritta da chi vive i problemi dall’interno.
Mi auguro che sia letta, discussa, diffusa e spero che chi ne ha la possibilità intervenga in tempi rapidi, con professionalità, nel rispetto del dettato costituzionale.
(Mauro Presini)
Egr. Presidente della Repubblica Italiana Dott. Mattarella Sergio
c/o Palazzo del Quirinale P.zza del Quirinale
00187 Roma
E.P.C.
Egr. Ministro della Giustizia Dott. Carlo Nordio
Via Arenula N° 70 00186 Roma
Ili.mo Presidente,
siamo un gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Ferrara “Costantino Satta” che hanno deciso di esporsi, in prima persona, per offrire uno spunto di riflessione, alternativo, sul tema, sempre più drammatico e allo stesso tempo sempre più mediatico, delle condizioni dei carcerati in Italia.
La nostra missiva vuole, senza alcuna pretesa, suggerire alcuni interventi che riteniamo essere meritevoli di ricevere attenzione, se non altro, perché immaginati da chi vive i problemi dall’interno, punto di osservazione, ahi noi, privilegiato. Ci asterremo, per cui, dal sollevare alcuna critica sterile di un sistema che zoppica, né avanzare l’ennesima richiesta di clemenza.
IL SOVRAFFOLLAMENTO
Quasi giornalmente sentiamo parlare di provvedimenti necessari per risolvere l’annoso problema del sovraffollamento carcerario. In quasi tutte le discussioni, viene paventato un qualche atto di clemenza che, sbrigativamente, porterebbe a una immediata riduzione del numero dei detenuti.
Abbiamo avuto modo di osservare, in passato, come, questo tipo di soluzioni, oltre a non essere risolutive, poiché il problema si ripresenta, prendono in considerazione solo l ‘aspetto quantitativo del problema, cioè il mero numero di detenuti stipati all’interno d i una struttura. Tralasciano, completamente, l’aspetto qualitativo d i questa piaga, ovvero le altre mille difficoltà che fanno, delle carceri, un luogo di immane sofferenza, dove regna il degrado e l’umiliazione.
Un atto di clemenza risolverebbe il problema della metratura pro-capite, ma per quelli che inevitabilmente restano ospiti delle patrie galere, la condizione risulta degradante, con un po’ di spazio in più, ma con tutte le criticità ancora ben presenti e irrisolte.
Come sancito da molteplici pronunce di vari organi, sia Italiani che Europei, lo spazio a disposizione nelle celle, per ciascun detenuto, non può essere l’unico parametro per valutare la vivibilità e idoneità del regime detentivo applicato. Se, al contrario fosse davvero l’unico parametro da tenere in considerazione, rispettandolo, il regime detentivo risulterebbe, iniquamente depurato da tutte quelle violazioni dei diritti umani, da troppo tempo tollerate e sedimentate, che negli anni sono divenute, addirittura, una squallida “normalità”.
OGNI CARCERE È UN MONDO A SÈ
Prima stortura del sistema che, a parer nostro, andrebbe sanata, nel più breve tempo possi bile, è l’incomprensibile diversità di trattamento e di condizioni all’interno dei vari carceri Italiani. “Ogni carcere è un mondo a sé” è un detto in voga in tutti gli istituti che, in modo semplice e chiaro, certifica l’abbandono della legalità, per favorire la praticità, spesso, a scapito proprio del rispetto dei diritti umani.
Ogni detenuto ha, già, dentro di sé le proprie fragilità personali. Vi si aggiunga lo sconforto di trovarsi in un carcere dove la parola diritto è solo un’utopia lontana e, di contro, sapere d i altri detenuti che godono di un trattamento, decisamente, più consono e rispettoso dei principi ispiratori, in un istituto che, magari, dista solo qualche kilometro da quello dove egli è detenuto. La sensazione di frustrazione e lo sconforto si possono trasformare, facilmente, in depressione.
Scontare la propria pena in una cella di oltre 20 mq, con altri due detenuti, con acqua calda e doccia in cella, in un istituto con molteplici attività proposte, possibilità lavorative importanti e, soprattutto, un programma di trattamento serio è decisamente meglio, se paragonato ad una cella di 12 mq con altri due detenuti, costretto a dormire in un letto a castello a 3 piani, senza acqua calda né doccia in cella, i n assenza d i qualsivoglia attività, che porta il detenuto a dover restare a ciondolare in sezione, anche, 20 ore al giorno. L’unico modo, per “uscire” dall’ incubo che il ristretto vive ad occhi aperti, è quello di rifugiarsi nell’abuso di sostanze antidepressive (che le amministrazioni incentivano pur di sedare, sul nascere, eventuali contestazioni).
Non è solo “diverso”, è INGIUSTO.
Non riteniamo necessario ricordare, banalmente, che l’art. 3 Cast. sancisce l’uguaglianza tra tutti i cittadini, ma sottolineiamo proprio la frase che noi tutti abbiamo visto scritta a grandi lettere in tutti i tribunali Italiani: “LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI”.
Ci interroghiamo su questo tema e ne condividiamo con Lei le nostre riflessioni. Se la legge, per un determinato reato prevede una pena di 3 anni, e questi tre anni hanno un peso decisamente diverso se scontati in un carcere modello, come quello di Bollate, piuttosto che nel tugurio dell’istituto di Caltagirone, dov’è l’uguaglianza della condanna?
Oppure, 3 anni nel carcere, ??? ali ‘ avanguardia, di Padova non sono nemmeno paragonabili a 3 anni scontati in quello Treviso. Sono realtà vicinissime, dal punto di vista geografico, ma distanti anni luce se si paragonano le condizioni dei detenuti in essi ristretti.
Ci asteniamo dal contestare l ‘aspetto che concerne l’edilizia carceraria, elemento per il quale, ci rendiamo conto, evidentemente, servirebbero ingenti stanziamenti per un livellamento delle strutture.
A titolo esemplificativo, Le facciamo presente che i colloqui con, le così dette, “terze persone”, dopo i l giudizio di primo grado, sono autorizzate a discrezione della direzione dell’istituto, senza alcuna indicazione da parte del legislatore.
La conseguenza di quanto descritto è quella di avere istituti in cui si possono avere colloqui con persone diverse dai famigliari ed istituti dove, questa possibilità, è assolutamente negata.
Lo stesso vale per uno svariato ordine di autorizzazioni:
carceri in cui è consentito il possesso di un proprio persona! computer ed altri in cui non lo è; alcuni consentono l’utilizzo di lettori mp3 altri no;
ci sono istituti in cui è permesso l ‘utilizzo delle chiavette usb, mentre in altri è vietato;
carceri che mettono in chiaro solo 12 canali tv, mentre altri prevedono l’accesso alla totalità delle trasmissioni televisive;
persino sulla ricezione dei pacchi postali da parte dei famigliari ci sono autorizzazioni
differenti, che arrivano al punto di avere carceri che consentono la ricezione di generi alimentari altri che li negano completamente.
In Italia abbiamo circa 200 istituti di pena e, attualmente, circa 200 mondi diversi in cui
scontare le proprie condanne.
Non può continuare ad essere così. DEVE esserci parità di trattamento, quanto meno per le autorizzazioni.
Ci auguriamo più uniformità tra le diverse realtà delle carceri italiane, prendendo come esempio gli istituti più virtuosi e in linea con le normative comunitarie, per livellare tutti gli istituti d’Italia a quel modello.
LA STRATIFICAZIONE DEI PROBLEMI
Un altro problema che crea immani difficoltà, all’interno degli istituti, è l’abitudine, di molti operatori, (in generale tutte le tipologie di figura professionale che ruotano intorno al mondo carcerario) di procrastinare qualsiasi adempimento di loro spettanza, spesso, nell’assurda speranza che il problema si risolva da solo. In realtà, il risultato è, solamente, quello di inasprire i rapporti detenuto-operatore.
Troppe volte, alla richiesta di una prestazione, l ‘atteggiamento dell’operatore è lo stesso: procrastinare fino al cambio turno, lasciando l’incombenza all’operatore che lo sostituirà e che rimanderà, a sua volta.
Perpetrando questo comportamento fino allo sfinimento del detenuto, si creano i pretesti, mai giustificabili, per insulti, proteste, aggressioni e, nei casi più gravi e sedimentati, si può arrivare, facilmente, a vere e proprie rivolte che coinvolgono più detenuti o intere sezioni. In altri casi questa stratificazione, dei problemi irrisolti, può portare a stati depressivi, del detenuto, che possono indurre anche al suicidio.
Una soluzione, a parer nostro, potrebbe essere l’addestramento specifico del personale, impiegato all ‘interno degli istituti carcerari, nell ‘approccio ai problemi e al controllo della frustrazione dei detenuti. Ci rendiamo conto che, a volte, l’operatore può essere mal disposto perché sottoposto a richieste molto simili tra loro, se non uguali, ma è altrettanto vero che in un luogo come il carcere, dove si è privati praticamente di tutto, anche un piccolo gesto di interessamento può fare la differenza, tra il sentirsi abbandonati e i l sentirsi, invece, parte d i un sistema.
Una preparazione specifica, sotto il profilo psicologico, sarebbe, quanto meno, auspicabile per coloro i quali debbano avere un rapporto professionale con persone fragili.
Una formazione improntata al problem solving, piuttosto che alla negazione del problema sarebbe un ottimo punto di partenza.
L’AMBITO SANITARIO
Il numero estremamente esiguo, dei controlli psicologici, è un problema che riguarda tutti i detenuti. Infatti, a parer nostro, tutti i ristretti dovrebbero essere sottoposti ad uno screening periodico, atto a valutare lo stato di salute mentale.
Com’è noto, la depressione è spesso un declivio lento dello stato di salute mentale di chi se ne ammala. Altre volte, invece, è frutto di eventi traumatici.
Ad oggi, chi entra in carcere per la prima volta o comunque è sottoposto a misura cautelare in attesa di giudizio, non rientra in alcun percorso, né psicologico, né rieducativo. In molti casi si è potuto osservare come i suicidi, tra i detenuti, abbiano visto come protagonisti persone in attesa di giudizio.
La soluzione, al momento, è quella di privare il detenuto di lenzuola, indumenti e accessori, che possano essere utilizzati per farsi del male, oltre ad una sorveglianza che prevede un passaggio ogni venti minuti davanti alla cella.
Secondo la nostra opinione, oltre alle iniziative messe in atto, sarebbe opportuno attivare, in concomitanza con la carcerazione, un supporto psicologico, come già avviene, in altri ambiti, in risposta ad eventi traumatici. L’obiettivo è quello di intercettare, con anticipo, situazioni di disagio, che potenzialmente possano sfociare in gesti estremi. La nostra convinzione è rafforzata dal fatto che, spesso, la difficoltà più grande per una persona, detenuta o libera che sia, è quella di chiedere aiuto. In ambito carcerario, anche chi chiede aiuto, talvolta non può essere seguito a causa dell’ampia forbice, in termini di rapporto numerico, che c’è tra i pochi psicologi, in forza all’istituto, e il numero elevato di detenuti da seguire.
L’attivazione di contratti con psicologi che possano colmare questo squilibrio, l ‘avvio di screening periodici e un supporto psicologico immediato, sarebbero auspicabili.
IL LAVORO COME SCUOLA DI VITA
Il tasso di recidiva, nel nostro paese, supera il 70%. Un valore decisamente alto, se paragonato a quello di altri paesi europei. Molti detenuti hanno storie di vita simili, caratterizzate da ambienti sociali con scarse opportunità di lavoro, molto tempo libero trascorso oziando, in giovane età, che li ha resi facile preda della criminalità.
Un istituto carcerario che ha, come primo obiettivo, quello di rieducare al fine di reinserire il detenuto nella società, si trova molto spesso a lasciare, i ristretti, ad oziare all’interno delle sezioni. Ripropone, cioè, le stesse condizioni sociali che hanno spinto, gli stessi detenuti, tra le braccia della delinquenza.
Ci sono pochi istituti virtuosi, in Italia, che propongono un lavoro fisso alla propria popolazione carceraria. Nella maggioranza dei casi, le opportunità lavorative sono pochissime e vengono proposte rotazioni, tra i detenuti, che permettono loro di lavorare un paio di mesi all’anno.
Secondo le nostre osservazioni, la miglior scuola di vita, per chiunque, è il lavoro. Il lavoro svolge molteplici funzioni:
Una funzione economica, perché permette al lavoratore di auto sostentarsi, di essere un operatore economico in grado di risparmiare supportando, così, gli investimenti, alimentare i consumi e generare ricchezza;
Una funzione sociale, perché rende i l lavoratore parte di un ‘organizzazione. L’uomo è completo se è parte d i una comunità. Il lavoro, inoltre, permette, all’individuo, di gettare le basi per poter costruire una propria famiglia;
Una funzione psicologica, perché il lavoro restituisce soddisfazione e autostima. Inoltre alimenta l’ambizione a volersi migliorare, seguendo dei modelli virtuosi che l’ambiente stesso propone;
Il lavoro ci impegna le giornate, sostiene i nostri progetti e ci permette di perseguire i nostri obiettivi. Se viene insegnato ad assaporare il valore prezioso delle opportunità che il lavoro può dare, nella completa legalità, molti meno detenuti vorranno rischiare di perdere quanto di buono hanno conquistato, compiendo ulteriori reati.
Ed ecco, perché, secondo la nostra opinione, proprio il lavoro dovrebbe rappresentare le fondamenta del percorso atto a riabilitare il detenuto. Non può esserci percorso di rieducazione senza lavoro. Crediamo che si possano avviare collaborazioni con aziende pubbliche e private per garantire un lavoro ai detenuti.
SEZIONI DISTACCATE PER DETENUTI A BASSA PERICOLOSITA’
Seguendo questa linea di principio ci sentiamo di suggerire alcune azioni che, a parer nostro, potrebbero alleviare, in parte, alcuni problemi dei detenuti.
L’Italia è stata colpita da diverse crisi, negli ultimi anni, che hanno interessato molti settori della nostra economia. Anche i l settore alberghiero e dell’ospitalità ne ha risentito. Attraverso i telegiornali, siamo venuti a conoscenza di alberghi in difficoltà, che rischiano di dover chiudere e, nei casi più gravi, di dover dichiarare fallimento.
Acquisire, o prendere in gestione, oltre ad implementare le opportune modifiche per trasformarle in sezioni distaccate dei vari istituti di pena, questo tipo di strutture non dovrebbe avere un costo eccessivo per lo Stato, rispetto a quello necessario per la costruzione di un nuovo carcere.
In queste “sezioni distaccate” potrebbero essere allocati detenuti a bassa pericolosità sociale. In particolare, queste strutture, potrebbero essere dedicate a coloro che stanno finendo di scontare la propria pena in regime di articolo 21 O.P. (lavoro all’esterno) e articolo 50 O.P. (semilibertà).
È già previsto che questa tipologia di detenuti debba essere allocata in sezioni apposite e separata dagli altri detenuti. Queste sezioni, già oggi, sono strutturate in modo da essere molto meno restrittive del carcere tradizionale e quindi non troppo differenti da una struttura alberghiera, anche se un po’ spartana.
Anche la sorveglianza, nei suddetti casi, è molto ridotta, quindi sarebbero necessari pochissimi agenti per la gestione delle strutture.
Spesso, le domande per le assegnazioni al lavoro all’esterno o alla semilibertà vengono rigettate per mancanza di posti disponibili. Con questo semplice escamotage si potrebbero avere molte più assegnazioni .al lavoro e più detenuti ammessi a regime di semilibertà ·(quasi sempre concessa con un lavoro o del volontariato).
Queste “sezioni distaccate” potrebbero ospitare anche quei detenuti che hanno tutti requisiti per poter ottenere una misura alternativa, ma che non riescono ad accedervi in quanto non hanno un domicilio presso il quale legare la misura alternativa.
Maggior accesso al lavoro all’esterno e semilibertà, uniti alla possibilità di scontare in misura alternativa, per quelli che non hanno una casa, potrebbe alleggerire di un numero cospicuo il totale dei detenuti ristretti all’interno delle carceri, con una serie di benefici consequenziali:
Il primo, di facile lettura, sarebbe la diminuzione del tasso di sovraffollamento;
aumentando il numero di detenuti che scontano la propria pena in misura alternativa, considerando che chi finisce di scontare la propria pena in misura alternativa ha un tasso di recidiva molto inferiore rispetto a chi sconta interamente la propria pena in carcere, avremo un minor ingresso di detenuti per il futuro;
avendo molti più “detenuti lavoranti” si avrebbe anche un maggior introito dal pagamento del mantenimento carcerario. Perché, anche se tale somma è richiesta a tutti i detenuti, solo chi lavora la paga realmente, quindi l’introito potrebbe aumentare, proporzionalmente, tanto più si agevoleranno questo tipo di misure.
Risultati simili si potrebbero ottenere se il ragionamento delle “sezioni distaccate” viene riproposto anche su strutture come le caserme dismesse. Si dovrebbe tenere conto, però di tempi più lunghi per la riqualificazione degli edifici e dei costi più elevati, che sarebbero comunque inferiori rispetto alla nuova edilizia carceraria.
DIFFERIMENTO DELLA PENA
Troppe volte abbiamo avuto a che fare con detenuti che hanno commesso un reato parecchi anni prima e, dopo un brevissimo passaggio in carcere, sono stati rimessi in libertà in attesa di condanna definitiva.
Anche se la costituzione recita che la durata del processo debba avere una durata ragionevole, nella realtà constatiamo continuamente come i processi abbiano una durata estenuante che facilmente arriva a un decennio.
Questo vuol dire che, dopo il primo periodo di carcerazione (che a volte nemmeno c’è), ci potremmo trovare con persone che, dopo la commissione del reato, sono state reputate non pericolose per quasi un decennio. Appena arriva la condanna definitiva devono essere messi in stato di detenzione, per scontare la loro pena, perché considerati “pericolosi”.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la pena residua da scontare, risulta essere ampiamente al d i sotto dei limiti di legge per poter accedere a misure alternative al carcere. Nella quasi totalità dei casi, non possono beneficiarne in quanto occorre una relazione di sintesi che deve essere redatta durante un periodo di osservazione obbligatoria post condanna definitiva.
Il risultato è che queste persone entrano in carcere per poter scontare il loro periodo di osservazione, per essere affidati ad una misura alternativa. Il periodo di osservazione coincide, in molti casi, alla pena residua da scontare, con il risultato che il detenuto accede alla misura alternativa per pochissimo tempo.
Il nostro pensiero è che, se una persona che ha commesso un solo errore nella sua vita, non ha mai più sbagliato e ha avuto una vita regolare, è ingiusto che dopo molti anni dai fatti, in assenza di errori, sia penalizzata da una pratica burocratica che si annoda su sé stessa.
A nostro avviso sarebbe opportuno prevedere un differimento pena della durata dell’osservazione necessaria a produrre una relazione di sintesi. In modo da poter ottenere direttamente l’applicazione di una misura alternativa al carcere senza dovervici per forza trascorrere infruttuosamente del tempo (se il tempo da trascorrere presso un istituto è molto breve, nessun percorso rieducativo o riabilitante è possibile, tant’è che gli operatori nulla prevedono per questa categoria di detenuti). Ovviamente bisognerebbe prevedere che il periodo di osservazione possa essere effettuato attraverso colloqui regolari con psicologi ed educatori esterni al carcere.
Se si decidesse di credere in questa idea, il beneficio sarebbe quello di avere un più basso ingresso di detenuti in carcere. Inoltre si potrebbe creare un deterrente per coloro i qual i, in attesa di pena definitiva, non dovendo più pensare “tanto in carcere ci dovrò finire lo stesso”, presi dallo sconforto, abbandonino ogni remora e, anche nel periodo di attesa del definitivo, commettano altri reati proprio perché, in cuor loro, si sentono già finiti.
APPLICAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI
Il governo attuale, come i precedenti del resto, hanno provato a porre rimedio, al problema delle carceri, approvando nuove leggi e decreti, che prevedono misure sovrapponibili a quelle che la legge precedente già prevedeva. Quello che a noi detenuti sembra essere il nocciolo della questione risiede nella discrezionalità affidata ai magistrati di sorveglianza che in maniera, talvolta, indiscriminata si astengono dall’interpretare la norma da applicare, ma ne generano delle loro.
In troppi casi si vedono rigetti di misure alternative, perché, “a parere” del magistrato di sorveglianza, il periodo di espiazione è troppo breve e quindi si richiede un ulteriore periodo di osservazione.
Richieste che sono supportate, come effettivamente la legge prevede, dai termini raggiunti per la concessione della misura richiesta, dalla relazione di sintesi del carcere favorevole alla concessione della misura alternativa, dalle indagini degli assistenti sociali del territorio con esito positivo e dal contesto famigliare idoneo alla concessione della misura. Questo, in pratica, vuol dire che non importa cosa dica la legge, cosa dichiarano i vari operatori che hanno avuto rapporti professionali con il detenuto, ma che l’unica decisione che conta, una volta avanzata una richiesta di misura alternativa, è l’impressione che il detenuto da al magistrato di sorveglianza, nei dieci minuti dell’udienza.
Signor Presidente, Lei, già in passato, intuendo la grandezza del problema, disse che discrezionalità non è arbitrio.
Oggi noi Io ribadiamo con forza e, altrettanto veementemente, affermiamo che la legge va interpretata seguendo il principio ispiratore del legislatore e non l’umore, del momento, di un giudice, che esprime un parere dettato dalle sue impressioni e non da dati di fatto accertati e verificati.
Se non si prevedono degli automatismi all’interno delle nuove proposte di legge, ogni nuova stratificazione sarà inutile, perché sarà immediatamente vanificata da quella discrezionalità, massima espressione di libertà di un giudice che, ad oggi; non ha limiti o imposizione alcuna.
II giudice è soggetto soltanto alla legge, recita la costituzione, ma se un giudice può disapplicare la legge in ogni momento, senza alcuna responsabilità, chi è soggetto a chi? Il giudice alla legge o la legge al giudice?
Signor Presidente, il nostro è il più umile grido di aiuto del quale siamo capaci. Nonostante i nostri errori, per i quali stiamo pagando, e la nostra attuale condizione, ci sentiamo ancora parte attiva di questo grande sistema che ci ha fatto conoscere i valori più importanti della vita e che ci ha garantito, per iscritto, una seconda possibilità. Sistema del quale vogliamo fare, ancora una volta, parte, nel rispetto della legge e dei princìpi dell’umanità. Un sistema che ci ha premiati e puniti, cresciuto e accolti, aiutato e abbandonati. Sistema del quale vogliamo essere orgogliosi di fare parte.
Questo sistema, che con gli occhi lucidi per la commozione, chiamiamo Italia. Cogliamo l’occasione per porgerle cordiali e distinti saluti.
Ferrara, 24/10/2024
Un gruppo di detenuti della Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara
Per leggere le altre uscite di Le Voci da Dentro clicca sul nome della rubrica.
Per leggere invece tutti gli articoli di Mauro Presini su Periscopio, clicca sul nome dell’autore