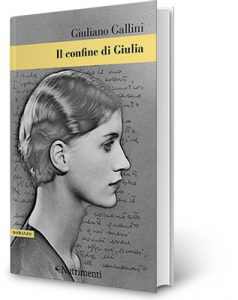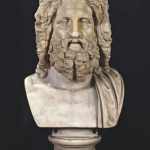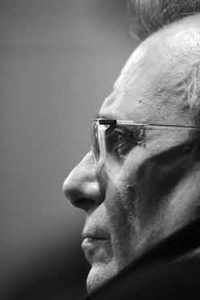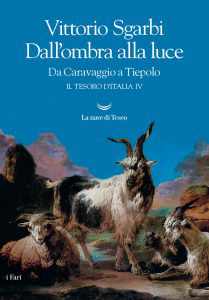Acqua, bene comune per appetiti privati
di Marcella Ravaglia
Il dibattito sui beni comuni nasce e si espande a livello internazionale negli anni ’70, in opposizione ai processi di smantellamento dello stato sociale e della società dei diritti – si ricordi la battaglia contro il Gatt, l’Accordo generale sul commercio dei servizi.
L’economia capitalista di mercato sin dagli anni ’80 è promotrice di un modello di globalizzazione basata sulla mercificazione di ogni bene, la predazione delle risorse naturali, la privatizzazione di beni e servizi pubblici di interesse generale collettivo. Margaret Thatcher all’epoca declinò in modo molto nitido il sistema neoliberista come quello in cui “la società non esiste, esistono gli individui, gli uomini e le donne, ed esistono le famiglie”; un sistema rispetto al quale “there is no alternative” (ovvero, non c’è alternativa). Spesso si fa coincidere la nascita del neoliberismo con la dittatura di Pinochet, il quale fra i suoi primi atti nel 1981 privatizzò tutte le acque della cordigliera cilena.
La dichiarazione di Dublino del 1992, per mano delle Nazioni Unite, trasforma l’acqua da “diritto” a “bisogno”, che perciò da bene universale ed esigibile si trasforma in bene economico da acquistare sul mercato. Dall’enunciazione all’applicazione di questo principio nelle politiche dell’acqua il passo è breve, e a compierlo sono primariamente Banca Mondiale, Fondo monetario internazionale, Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e grandi corporations dell’acqua (Suez, Veolia gia Vivendi, Rwe-Thames water, per citare solo le più note). Nel 1999 l’Unione Europea chiede l’inserimento dell’acqua nel Gats (risorto dalle ceneri del Gatt per mano dall’Omc). Non è un caso se le più grandi multinazionali dell’acqua sono europee, le quali intravedono l’apertura di un mercato mondiale degli acquedotti. Da allora, a 72 paesi del Sud del mondo è stata chiesta la piena liberalizzazione dei servizi idrici, nonostante le fortissime contestazioni dei movimenti altermondialisti (Seattle 1999, Cancun 2003).
Nei paesi del Sud del mondo il servizio idrico ha seguito una diversa evoluzione da quella del continente europeo. Infatti, mentre i paesi imperiali ampliavano le reti pubbliche nelle città europee (attraverso le municipalità), nelle colonie l’erogazione dell’acqua era riservata alle élite. Con l’indipendenza, il Sud del mondo si è trovato con infrastrutture insufficienti, e la mancanza di amministrazioni decentrate ha portato i governi centrali ad affidarsi ai finanziatori internazionali strettamente legati ai paesi europei di precedente dominazione coloniale.
L’acqua, come bene comune pubblico e diritto umano necessario alla vita, è stata oggetto di grandi battaglie ovunque, a partire proprio dalle regioni del Sud del mondo. Prima in America Latina, con la memorabile vittoria del popolo boliviano, che nel 2000 a Cochabamba costringe il proprio governo a cancellare la legge di privatizzazione dell’acqua. In Uruguay, dove dopo un decennio (1994-2004) di tentativi, un plebiscito nazionale blocca le privatizzazioni e inserisce in costituzione il diritto di accesso all’acqua come diritto umano e la gestione esclusiva del servizio idrico da parte dello stato. In seguito le lotte per l’acqua attraversano Honduras, Sudafrica, Guinea, Ghana, Indonesia, Filippine. A fronte delle mobilitazioni popolari e dello scarso ritorno economico, dal 2003 si osserva un blocco e parziale ritiro delle multinazionali da quelle regioni del mondo. Ma è solo un cambio di strategia, le multinazionali si concentrano infatti sui paesi occidentali.
In Italia la privatizzazione dell’acqua comincia nel 1994, attraverso la legge Galli, e prosegue a grandi balzi fino al 2009 con il decreto Ronchi, sotto governi di ogni colore. L’obiettivo è quello di sottrarre la gestione del servizio idrico agli enti locali e portalo in mano ad aziende private di portata sovraregionale, ovvero aziende misto pubblico-privato, che sottraggono ai territori sapere e patrimonio, facendo profitto con la mercificazione di un bene essenziale come l’acqua, esponendosi in molti casi alla finanza globale attraverso la quotazione in Borsa.
Le lotte contro la privatizzazione dell’acqua in Italia nascono a livello territoriale, specie nelle regioni del centro-sud: Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, sono regioni dove prima che altrove si sviluppano le contestazioni per l’entrata dei privati e l’aumento incontrollato delle tariffe. La Toscana è la prima regione a sperimentare il partenariato pubblico-privato, portando Arezzo ad essere la provincia con le tariffe più alte a livello nazionale (oggi è Grosseto). I movimenti per l’acqua pubblica si incontrano proprio in Toscana, nel 2002 in occasione del Forum sociale europeo, e poi nel 2003 in occasione del Forum mondiale alternativo dell’acqua. Nel 2005, con l’intensificarsi delle vertenze territoriali, viene lanciato l’appello per la costituzione del Forum italiano dei movimenti per l’acqua: la prima iniziativa del Forum consiste nella costruzione di una legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico, legge che ancor oggi è il manifesto dei movimenti per l’acqua. Nel 2007, in sei mesi più di 700 comitati territoriali raccolgono oltre 400 mila firme sulla legge di iniziativa popolare, che viene poi presentata al Parlamento, dove starà a prender polvere per due legislature. In questo contesto sociale opera la Commissione Rodotà, la quale nel 2008 consegna un disegno di legge delega per la riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, lavoro fortemente innovativo, quanto inattuato. Nel 2008 inizia la campagna per la modifica degli statuti comunali attraverso delibere di iniziativa popolare, per il riconoscimento dell’acqua bene comune diritto inalienabile e per la definizione del servizio idrico come servizio di interesse generale privo di rilevanza economica: oltre 200 comuni introducono questa modifica. Nel 2009 il governo Berlusconi fa approvare a colpi di fiducia il decreto Ronchi, che impone la privatizzazione del servizio idrico entro il 2011. Per questo motivo il Forum promuove la campagna referendaria – Rodotà è fra i costituzionalisti estensori dei quesiti – che culmina col voto del 12-13 giugno 2011, quando 27 milioni italiani si esprimono a larghissima maggioranza (98,5% dei votanti) contro la cessione ai privati e contro i profitti fatti sull’acqua. Un risultato frutto di una coalizione vastissima (si dirà “dalle parrocchie ai centri sociali”) e di una mobilitazione capillare fatta tutta dal basso. Va ricordata anche la risoluzione Onu del 2010, che dichiara per la prima volta nella storia il diritto all’acqua “un diritto umano universale e fondamentale”. Il resto è storia recente, in cui i governi (non eletti) che si sono susseguiti in Italia hanno tentato variamente di annullare il risultato referendario, trovando sul loro cammino le contestazioni dei movimenti e spesso anche le bocciature della Corte Costituzionale. Ultima in ordine di tempo, la sentenza di incostituzionalità per il decreto Madia sui servizi pubblici, di cui nell’estate 2016 era stato chiesto il ritiro con una petizione popolare su cui sono state raccolte 230 mila firme.
Il Forum italiano dei movimenti per l’acqua, forte del risultato referendario, ha promosso la nascita della Rete europea dei movimenti per l’acqua, grazie alla quale vengono portate avanti importanti iniziative a livello internazionale. Nel 2012 quasi 2 milioni di firme hanno sostenuto l’iniziativa dei cittadini europei per il diritto all’acqua (Right2Water). Negli ultimi anni poi si sono intensificate le spinte privatizzatrici provenienti da organismi sovranazionali, e dunque è necessario contrastare , oggi più che mai, tutti quei trattati che mirano alla apertura di un mercato mondiale dell’oro blu, in particolare il Ttip e il Ceta. La mobilitazione contro il Ttip, attuata fin dalla sua presentazione nel 2014, ha permesso di vederne la sospensione (non la cancellazione) nel 2015; stessa sorte speriamo avrà il Ceta, l’accordo fra Ue e Canada, ma serve la partecipazione di tutti, ognuno nel proprio contesto e con le proprie competenze. Si scrive acqua, si legge democrazia.
Spunti di lettura
1. Acqua in movimento, Marco Bersani – Edizioni Alegre (2010)
2. Come abbiamo vinto il referendum, Marco Bersani – Edizioni Alegre (2011)
3. Salvare l’acqua, Claudio Jampaglia e Emilio Molinari – Feltrinelli (2010)
4. L’acqua (non) è una merce, Luca Martinelli – Edizioni Altreconomia
5. Il Servizio idrico integrato, 11° indagine di Cittadinanzattiva (marzo 2016)
6. Il Ceta e l’acqua, European water movement (settembre 2016)
7. Fondo campagna referendaria per l’acqua pubblica e contro il nucleare, Fondazione Lelio Basso (2016)