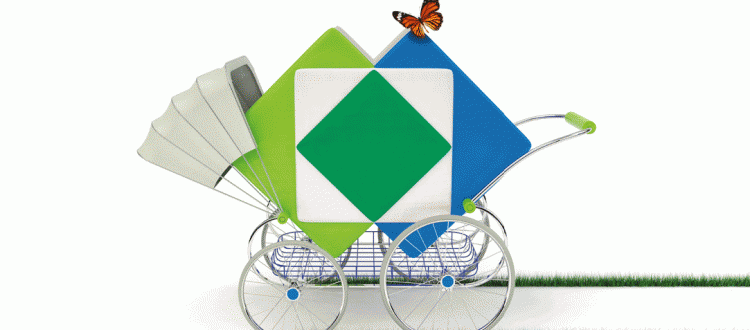Da organizzatori
Mai uguale a se stesso, sempre fedele allo spirito che negli anni l’ha reso un appuntamento imperdibile nel panorama mondiale, torna il Festival Internazionale del Giornalismo, quest’anno alla sua XI edizione.
Mai come in questa edizione 2017 nel cuore dell’evento ci saranno le persone. Faremo incontrare a Perugia cittadini di tutto il mondo con storie, testimonianze ed esperienze da raccontare e condividere. Dall’America di Trump alla Filippine di Duterte, passando per l’Africa e il Medio Oriente e ovviamente l’Europa. Racconteremo questi nostri tempi insieme agli oltre 500 speaker in arrivo da tutto il mondo.
E come sempre sarà una riflessione sui temi del giornalismo, i cambiamenti continui della professione, e l’occasione per raccontare le storie e i temi di attualità, le questioni che premono sulle nostre società, sul nostro stare insieme. Il Festival di Perugia è una grande newsroom mondiale, che produce un’immagine del presente in tempo reale, dove professionisti e non si incontrano e fanno giornalismo, informazione, costruendo un ricco e complesso racconto a più voci del mondo.
Trump e la sua sfida continua ai media, la Turchia di Erdogan e la libertà di informazione sotto attacco in tutto il mondo, l’Europa al bivio con Brexit e la spinta dei movimenti populisti, e la pericolosa tentazione di legiferare sulla verità per contrastare le fake news, in una presunta era della post-verità. Questo sarà un argomento che affronteremo in diverse sessioni puntando soprattutto su media literacy (alfabetizzazione ai media) e prendendo posizione, come Festival, contro tentativi di filtri e censure. Si parlerà di Siria, di Yemen, una delle crisi meno raccontate del Medio Oriente, che sta avendo un impatto devastante sulla popolazione civile, non senza la responsabilità dei paesi, tra cui l’Italia, coinvolti nel commercio delle armi in questo conflitto, organizzato da Medici senza Frontiere, si parlerà delle guerre e della povertà che spingono milioni di persone ad abbandonare i loro paesi, di Africa grazie anche all’incontro organizzato da Amref “Prendersi cura del mondo” con Riccardo Iacona. L’attivismo, i diritti umani, le cyberguerre, la guerra ai signori del narcotraffico, la crisi di fiducia nei media che mette a rischio le nostre democrazie, il cambiamento climatico, la necessità di un giornalismo capace di parlare alle nuove generazioni “digitali”, il ruolo, i rischi e l’etica dei leak e del whistleblowing per il giornalismo. E ancora: modelli di business e ruolo della filantropia nel presente e futuro dei media, disabilità e sport, ISIS e il ruolo delle donne nel terrorismo islamico, ricerca e università, la sfida degli algoritmi per il giornalismo e la democrazia, vaccini e la necessità di saper comunicare la scienza.
Arriveranno da tutto il mondo anche i volontari, circa 200 fra studenti, aspiranti giornalisti, fotografi provenienti da 27 diversi paesi: Argentina, Australia, Bangladesh, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Canada, Egitto, Francia, Georgia, Germania, Grecia,
Camerun, India, Iraq, Italia, Olanda, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Sudafrica, Spagna, Turchia, Ucraina.
Main sponsor della undicesima edizione del Festival: Facebook, Google si affiancheranno ad Amazon ed Eni, mentre main partner istituzionale è come sempre la Regione Umbria.
Confermati gli sponsor Nestlé, Sky, e per la prima volta WordPress e Ferrovie dello Stato italiane. Partner istituzionale Comune di Perugia. Grazie al contributo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti diversi workshop saranno validi per il riconoscimento dei crediti formativi.
Cinque giorni, circa 250 eventi, oltre 500 speaker da 44 paesi diversi, e come sempre tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming.
#ijfTALK17
Quattro i talk di 17 minuti affidati a personalità del mondo dei media e non solo molto diverse tra loro, che porteranno al festival le loro storie, le loro esperienze, le loro riflessioni. Quattro incontri che affronteranno i temi al centro della discussione pubblica e ci racconteranno storie di impegno per la democrazia e la libertà.
Cameron Barr – Managing Editor The Washington Post La verità e i ‘fatti alternativi’: la sfida al giornalismo del Presidente Trump (introduce e modera Lucia Annunziata, direttrice L’Huffington Post).
Adam Mosseri – Vice President of product Facebook Tutti i segreti del News Feed (introduce e modera Jeff Jarvis, City University di New York)
Zaina Erhaim – Institute for War and Peace Reporting Coprire la guerra in Siria da giornalista, attivista e donna (introduce e modera Maria Gianniti, Giornale Radio Rai)
Evan Greer – Campaign Director Fight for the Future Come abbiamo salvato Chelsea Manning: la forza della mobilitazione online di giornalisti, attivisti, avvocati (introduce e modera Philip Di Salvo, European Journalism Observatory)
INCONTRO CON
Emiliano Fittipaldi Da Vaticano a Raggi: le inchieste sul potere. Segreti e tecniche del giornalismo investigativo
Alan Friedman, Andrew Spannaus, Caterina Soffici Occhi puntati sull’America di Trump La lunga notte di Tiki Taka Diretta del match di ritorno della semifinale di Coppa Italia e commento alla partita con Pierluigi Pardo e gli ospiti della serata
Giovanni Floris, Pierluigi Pardo, Federico Taddia Quella notte sono io. Incontro sul tema del bullismo
John Sweeney, Andrei Soldatov Trump: il candidato del Cremlino?
Firas Fayyad, Amedeo Ricucci Gli ultimi uomini ad Aleppo
Craig Newmark, Mario Calabresi Democrazia e media: riconquistare la fiducia dei cittadini Richard Gingras, Davide Casati
Corrado Formigli, Barbara Serra Perché non sconfiggiamo il califfato nero
Lercio e l’era della post-falsità
Pietrangelo Buttafuoco, Silvia Truzzi Magic Ensemble Carlo Lucarelli Intrigo italiano. Incontro con uno dei più importanti e amati maestri del noir italiano
Milena Gabanelli, Bernardo Iovene, Alessio Viola Omaggio ai 20 anni di Report Mohamedou Slahi, Barbara Serra, Larry Siems 15 anni senza accuse: Mohamedou Slahi racconta l’inferno di Guantanamo Mark Thompson, Mario Calabresi La fine del dibattito pubblico
Owen Jones, Fabio Chusi La crisi del capitalismo e la post-democrazia
Riccardo Iacona, Roberto Burioni, Andrea Grignolio L’importanza dei vaccini. Come superare disinformazione e paure Luigi Contu, Sarah Varetto, Jill Morris, Tobias Piller Europa al bivio Ece Temelkuran, Marta Ottaviani In Turchia la verità è una battaglia persa. Non lasciate che accada anche a voi Beppe Vessicchio, Antonio Sofi Zucchine e pomodori crescono con Mozart Wu Ming 1, Zerocalcare Le nuove frontiere del reportage Giulia Innocenzi, Giuseppe Cruciani Incontro / scontro fra vegeteriani e carnivori
Manuel Agnelli, Luca Valtorta Strategie dell’apnea: dal Tora! Tora! a X-Factor passando per Sanremo
A TEATRO Lirio Abbate Carminati e il caveau dei misteri d’Italia Alaa Arheed e Adovabadàn Jazz Band Incontro-concerto: Vi raccontiamo la Siria in musica
Marco Travaglio Post-verità e post-giornalismo Roberto Saviano Quelle storie che non si devono raccontare
Diego Bianchi, Makkox, Antonio Sofi, Andrea Salerno… Gazebo Live! Beppe Severgnini, Simona Bondanza, Stefania Chiale, Alessandro Collina La lingua misteriosa dei binari: i treni tra musica, letteratura, giornalismo
PANEL DISCUSSION
Fra i panel discussion segnaliamo:
Cina: tra media tradizionali e ditigali La libertà di informazione nel sud-est Europa Le fake news e l’ecosistema della disinformazione Investigare sulle mafie più potenti al mondo Come imparare ad informarsi Africa e giornalismo investigativo Dov’è l’esperta Non chiamatelo crimine di passione Come coprire i populisti bugiardi Migranti la storia di chi fa la differenza La Turchia di Erdogan e la guerra ai giornalisti Germania al voto fra miti e pregiudizi Attiviste in prima linea per la libertà di espressione Dall’Europa al Medioriente: cosa raccontano i nostri inviati Elezioni Usa 2016: l’esperienza collaborativa di Electionland Brexit, l’Europa, i media Yemen, il costo umano di un guerra dimenticata Classe dirigente cercasi Digital media e il cambiamento climatico Fact-checking collaborativo Sondaggi o astrologi? Il ruolo delle ricerche nel raccontare la politica Ripensare gli algoritmi e le metriche in redazione Da MPS a M5S: rischi e nemici dei cronisti di inchiesta Hacking democracy: hacker russi, Wikileaks, propaganda, elezioni americane Prendersi cura del mondo Persone LGBT e media nell’era dei diritti Video a 360°, realtà virtuale: presente e futuro del giornalismo immersivo Giornalismo, filantropia, indipendenza Le notizie spiegate a mio figlio (in questo panel ci sarà uno speaker di soli 10 anni) Verità e giustizia per Giulio Regeni (e non solo) Il talento e il coraggio di un fotogiornalista. Storia di Andy Rocchelli Spose schiave cospiratrici: le donne dell’ISIS Terremoto come si racconta una emergenza
Il corpo del reato (il caso Cucchi e non solo) Disabilità e sport, la lezione di Rio 2016 Banche e giornali, segreti e bugie Da Panama Papers a FootballLeaks
WORKSHOP
Tornano gli appuntamenti di Hackers’ Corner (i maggiori esperti italiani insegnano tecniche e strumenti per la sicurezza delle fonti e nella comunicazione giornalistica), Law&Order, una serie di workshop specifici per approfondire e prepararsi agli aspetti giuridici della professione e il filone Data Journalism e Fact-checking. Quest’anno inauguriamo il filone dedicato all’engagement: al coinvolgimento, alla partecipazione degli utenti, lettori, cittadini. E tutta una serie di appuntamenti dedicati alla media literacy, anche per i più piccoli con due appuntamenti su giornalismo e su coding per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.
Previsti anche i workshop formativi tenuti da First Draft Media, Amazon, Facebook e Google. Oltre 50 workshop gratuiti aperti a tutti, non solo ai giornalisti (per alcuni è previsto il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti).
PRESENTAZIONI Fra le presentazioni segnaliamo:
Scintille 13 ricercatori del Reuters Institute for the Study of Journalism – provenienti da Polonia, Austria, Finlandia, Cina, Corea, Giappone, Kenya, India, Russia – presenteranno le loro ricerche su media e democrazia, robot, video e mobile, informazione e salute, libertà di informazione, economia, agenzie di stampa e tv, sicurezza dei giornalisti in zone a rischio, ruolo dei social media, giornalismo investigativo e open data.
Italians and the UK. Storie di Italiani nel Regno Unito ieri e oggi Le nuove frontiere del reportage: dal libro al web documentary.
#Hacked Il news game interattivo di Al Jazeera sulla cyberguerra siriana Inchiesta sugli algoritmi Il giornalismo investigativo per indagare sugli algoritmi governativi
Scienza, dati e innovazione nel giornalismo digitale La versione di Quartz WordPress, le opportunità dell’open web La storia di WP, la sua comunità, e il suo contributo al web libero e aperto Truly Media Un nuovo tool collaborativo per la verifica dei contenuti generati dagli utenti online Come funziona la bolla? Analisi pratica dell’algoritmo di Facebook
Giornalismo e graphic novel La graphic novel per raccontare storie realmente accadute. Un giornalismo più avvincente e più coinvolgente soprattutto per le generazioni “digitali”
Giornalismo offshore Salvare gli archivi digitali dalla cancellazione e dalla censura
FILM E DOCUMENTARI
I Love Dick – in collaborazione con Amazon Primo e secondo episodio della serie TV Nobody speak – in collaborazione con Netflix, per la prima volta al Festival. Al centro la vicenda processuale Hogan-Gawker, il conflitto fra diritto alla privacy e libertà di informazione e come avere molti soldi può mettere a tacere i media. Un film sui pericoli e i doveri dell’informazione in un’era di disuguaglianze. Interverrà Lisa Nishimura, VP of original documentary for Netflix. Omicidio di Stato al Cairo – Il sequestro, la tortura e l’assassinio di Giulio Regeni – realizzato da La Repubblica e 42° Parallelo. In anteprima al Festival il documentario firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.
LIBRI Fra le presentazioni di libri segnaliamo:
Lacrime di sale: la mia storia quotidiana di medico di Lampedusa fra dolore e speranza di Pietro Bartolo, Lidia Tilotta Il cuore del potere. Storia del Corriere della Sera di Raffaele Fiengo
Bulletproof diaries. Storie di una reporter di guerra di Barbara Schiavulli Morte, immortalità e oblio sui social network di Giovanni Ziccardi Avremo sempre Parigi di Serena Dandini
Università futura. Fra democrazia e bit di Juan Carlos De Martin
Il giornalismo dopo Snowden di Taylor Owen
IN DIRETTA DA PERUGIA
Luca Bottura > Lateral – Radio Capital
Paolo Salerno > Le voci del Mattino – Radio Rai 1 Massimo Bordin > Stampa & Regime – Radio Radicale
RaiNews24
SkyTG24