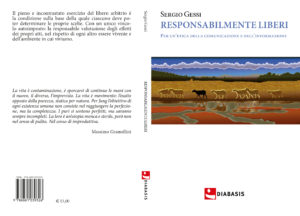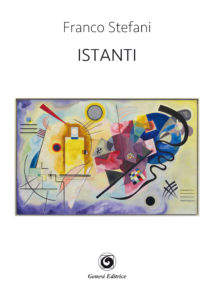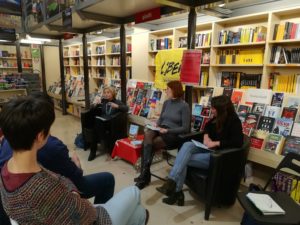“Non li avete uccisi. Le loro idee camminano sulle nostre gambe”: è la celeberrima frase sullo striscione della manifestazione all’indomani delle stragi del 1992. “Abbiamo un debito di riconoscenza”, ha detto don Luigi Ciotti nel discorso che ha concluso la manifestazione nazionale di Padova di questo 21 marzo 2019, XXIV Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Sono morti, ma in realtà per noi sono ancora vivi, perché i loro sogni, le loro speranze devono camminare sulle nostre gambe”. “Una memoria viva, che ci sfida ad assumerci sempre di più responsabilità e impegno”, “per costruire attorno a noi più vita, perché vinca la vita”, ha sottolineato il fondatore del Gruppo Abele e di Libera.
E anche a Ferrara il 21 marzo quest’anno ha collegato passato e presente, memoria e futuro, a partire dalla lettura dei nomi delle vittime, che si è tenuta giovedì mattina in Municipio in contemporanea con le altre piazze d’Italia.
“Siamo in un momento nel quale forse gli anticorpi etici sono venuti un po’ meno”, ha detto il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani e, ricordando le inchieste al Nord, in Emilia Romagna, Lombardia e le recentissime in Veneto, ha aggiunto: “siamo ormai consapevoli che nessun territorio si può dire al sicuro”. Anche per questo, ha concluso Tagliani, “E’ un piacere che questo evento si svolga qui nella casa comune, nella casa di tutti i cittadini”. Insieme a lui erano presenti il prefetto, Michele Campanaro, e il questore Giancarlo Pallini. “E’ importante per me essere qui oggi, occasioni come queste possono rinsaldare i legami nei territori e creare anticorpi”, ha affermato il prefetto. Campanaro ha ricordato come “un’esperienza importante, non solo dal punto di vista professionale”, gli anni da vice prefetto vicario a Caserta e l’omicidio di don Peppe Diana, di cui quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario. Pallini si è detto orgoglioso di provenire dalla stessa terra del sacerdote, quella Casal di Principe che ha reagito: don Peppe aveva detto “Per amore del mio popolo non tacerò” e il suo popolo si è ribellato al “clima di omertà e intimidazione”. Un clima che “nelle organizzazioni mafiose raggiunge l’apice, ma che tutti noi possiamo vivere nel nostro quotidiano”. Ecco perché, ha concluso il Questore, “non bisogna chiudersi in sé stessi”.
Magistratura, forze dell’ordine e amministrazioni non vanno lasciate sole: la battaglia contro le mafie “è una battaglia culturale e di civiltà”, ha ricordato il referente del Coordinamento provinciale di Libera di Ferrara, Donato La Muscatella. Per questo la lettura dei nomi è, non solo idealmente, “un passaggio di testimone” perché la memoria delle vittime e dei loro famigliari diventi “un valore condiviso che spinga all’impegno”. Un impegno anche e soprattutto alla ricerca della verità perché, come ha ricordato don Ciotti a Padova “l’80% dei famigliari non conoscono ancora la verità, o la conoscono solo in parte”.
E in questa staffetta, il testimone è passato da Sindaco, Prefetto e Questore, ai cittadini: in trentacinque, fra i quali aderenti ad associazioni e realtà cittadine – Emergency Ferrara, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Pro loco Casaglia, Movimento Nonviolento, Unicef, Cgil Ferrara – e giovani del Copresc di Ferrara, del gruppo scout di San Luca e della 5° F del Liceo Roiti, hanno letto l’elenco delle vittime, che parte dal 1879 e arriva al 2018, mentre i nomi risuonavano anche nella piazza municipale, ai piedi dello scalone. Un rito civile e democratico fatto di volti e di voci che si assumono la responsabilità del ricordo e dell’impegno.

La sala dell’Arengo prima dell’inizio della lettura

Alcuni momenti della lettura dei nomi

Alcuni momenti della lettura dei nomi

Alcuni momenti della lettura dei nomi

Alcuni momenti della lettura dei nomi

Inaugurazione della mostra
La mattinata è proseguita con l’inaugurazione della mostra ‘Vittime di mafia’, a cura della casa editrice Becco Giallo. Storie di nuova resistenza contro l’omertà imposta della criminalità organizzata raccontate attraverso un linguaggio vicino ai giovani, ma non solo: le graphic novel. Protagonisti della mostra sono eroi del nostro tempo, che hanno sfidato e combattuto la mafia: Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Lea Garofalo, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo e Mauro Rostagno, disegnati da Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Giacomo Bendotti, Nico Blunda, Giuseppe Lo Bocchiaro, Ilaria Ferramosca, Chiara Abastanotti e Gian Marco De Francisco. La mostra è allestita nell’atrio adiacente la Sala Arengo della residenza municipale, visitabile gratuitamente dal 21 al 27 marzo negli orari di apertura degli uffici comunali.
Nel pomeriggio, invece, due incontri per presentare due testi che allargano lo sguardo, per parlare di legalità come valore fondante di una cultura democratica e di una società solidale. “Abbiamo bisogno di parole e di pensieri che sappiano interpretare i mutamenti, che sappiano orientarci”, ha detto don Ciotti a Padova.
Il primo appuntamento, al dipartimento di giurisprudenza di Unife, con il volume ‘Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni’ (Giappichelli 2018), presentato dai curatori Luca Barbaro e Francesco de Vanna, insieme a Baldassare Pastore, professore di filosofia del diritto presso l’ateneo ferrarese, Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto presso l’Università di Firenze e Direttore del Centro interdipartimentale l’Altro diritto, Alessandra Sciurba, coordinatrice delle Cliniche legali presso l’Università di Palermo, e Thomas Casadei, professore di filosofia del diritto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e membro del CRID – Centro di ricerca interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità. “Non basta accogliere, bisogna riconoscere le persone, occorre ritrovare ciò che ci accomuna tutti a prescindere dalle culture, dalle religioni e dalle idee, dobbiamo ritrovare ciò che ci fa riconoscere, ciò che ci rende prossimi e fratelli”, ha detto con chiarezza don Ciotti a Padova, proclamando poi il suo “no alla gestione repressiva dei migranti e all’attacco ai diritti umani”. Le migrazioni sono un fenomeno strutturale e i migranti se ne vanno dai loro paesi non tanto perché “gli va”, come sostengono alcuni politici, ma spesso perché costretti dal “sistema economico dell’occidente, che ha depredato e derubato intere zone del pianeta senza alcun riguardo e pietà per chi le abitava”, ha affermato ancora il fondatore di Libera.
L’ultimo appuntamento di giovedì 21 marzo è stato alla Feltrinelli per la presentazione di ‘Vent’anni di lotta alle mafie e alla corruzione. L’esperienza di Avviso Pubblico’, con Giulia Migneco, coautrice e responsabile comunicazione di Avviso Pubblico, e Antonella Micele, vicesindaco di Casalecchio di Reno e coordinatrice regionale dell’associazione. Avviso Pubblico è la rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuovere in Italia la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: fondata nel 1996, conta oggi più di 370 aderenti, fra Comuni, Unioni di Comuni, Provincie e Regioni. Tutti amministratori che ‘a viso pubblico’ – appunto – si impegnano per la formazione dei colleghi e non solo e per (ri)dare credibilità alle amministrazioni locali: le istituzioni più vicine ai cittadini, tra i “maggiori produttori di legami sociali, di solidarietà, di reciproca fiducia tra i cittadini e nei confronti dello Stato”, come scrive nel libro Agnese Moro – ex presidente dell’associazione e figlia dell’on. Aldo Moro.
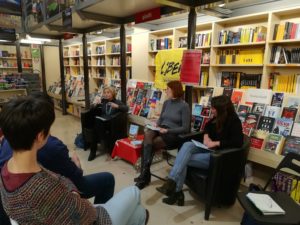
La presentazione alla Feltrinelli

La serata Da cosa nostra a casa nostra
Nel nostro territorio sono quattro i comuni aderenti: Ferrara, Cento, Fiscaglia e Voghiera. E proprio Isabella Masina, vicesindaco di Voghiera, ha parlato di Avviso pubblico come di un “aiuto fondamentale per orientarsi”, “una spalla professionale per supportare gli amministratori”. Con Antonella Micele si è invece tornati a parlare di come traghettare le esperienze di questi venti anni fatte nel futuro: è necessario e fondamentale “lavorare con le nuove generazioni, perché i giovani di oggi saranno i dirigenti di domani”. Parallelamente bisogna superare la concezione della trasparenza come ‘adempimento formale’: “non è una questione di burocrazia, ma di passione civile”. “Il buon amministrare e l’erogazione di servizi come diritti, oltre la logica del compromesso e dei favoritismi – ha concluso Micele – sono la condizione per una buona vita democratica”. E per togliere alle mafie il proprio paludoso terreno di sviluppo fatto di clientelarismo e corruzione: la criminalità si infiltra e offre servizi laddove lo Stato lascia vuoti.
Venerdì sera poi la parola è passata proprio a loro, ai giovani: al Punto 189 del Grattacielo gli scout del Gruppo Ferrara 4 di San Luca insieme ai giovani della parrocchia Immacolata hanno raccontato, anche in forma di spettacolo, la propria esperienza nelle terre tolte alla criminalità organizzata e gestite dalle cooperative, in un incontro significativamente intitolato ‘Da Cosa Nostra a casa nostra: viaggio di scoperta, conoscenza e responsabilità’.
Il programma delle iniziative ferraresi si concluderà il prossimo 29 marzo con un’altra presentazione alla Feltrinelli in via Garibaldi: ‘Castel Volturno. Reportage sulla mafia africana’ di Sergio Nazzaro, giornalista e scrittore, un viaggio duro e crudele tra Caserta e Napoli, nel delta del Volturno, per il quale Sergio Nazzaro ha ricevuto il Premio Testimone di Pace 2013.
Leggi anche:
Accad(d)e oggi 21 marzo con Libera: Orizzonti di giustizia sociale. Passaggio a Nord Est