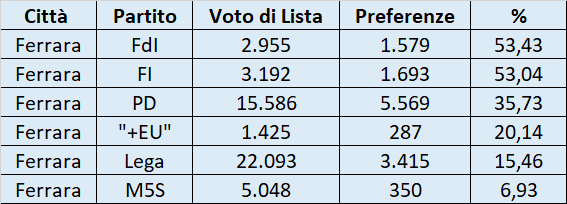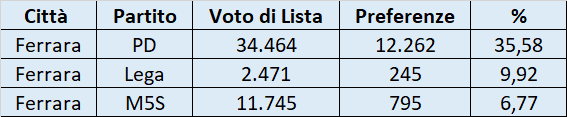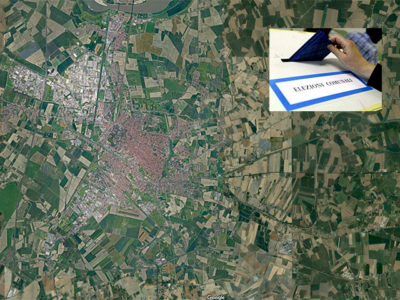Il tuo pensiero era forza e volontà,
tu eri il concetto stesso di intellettuale,
il tuo intelletto era un’arma invincibile, contro il sopruso.
Chi ti critica, ora come allora,
non sa chi eri, non sa chi sei e cosa rappresenti.
La questione morale, la forza delle idee,
contro le idee della forza.
Ti hanno ucciso ma hanno reso immortali le tue idee,
chi pensa, senza pensiero, che tu sia solo un simulacro,
non capirà mai cosa significa essere partigiano.
La tua lungimiranza ti ha fatto vivere troppo poco,
in un mondo troppo antico,
rispetto alla tua lucente modernità.
**************
Un gigante dell’intelligenza, muscoli d’acciaio del pensiero,
racchiusi in un corpo all’apparenza debole,
pensiero critico, pensiero libero, intelletto nato per essere avanguardia,
forza trainante della mente, messa a disposizione del popolo.
Ti sarebbe bastato, rinnegare le tue idee, sarebbe stato sufficiente,
avresti potuto andare in esilio, avresti potuto scappare,
ma non si scappa da se stessi e dalle proprie responsabilità verso gli altri.
Le sbarre della tua prigione erano come nuvole,
la tua mente spezzava le catene e vagava libera,
le tue preoccupazioni erano gli altri,
tua mamma, tua moglie, tuo figlio,
la tua forza, era per loro e per i tuoi ideali.
Vivo, per sempre, a traino delle moltitudini,
hai cambiato la storia, fossi vissuto in un mondo meno nero,
la avresti rivoluzionata, con le armi della ragione.
Tu odiavi gli indifferenti, ed eri partigiano della libertà e della giustizia,
in un mondo che sognavi migliore, ma che adesso a tanti anni dalla tua morte,
non ti sarebbe piaciuto
**************
Le ceneri di Gramsci, scriveva il poeta (PPP), non sono state sparse nel vento per nulla, la forza della ragione contro le ragioni della forza.
Nino, così come lo chiamavano in famiglia, ebbe la capacità di superare i suoi limiti fisici, era alto appena un metro cinquanta a causa del morbo di Pot, (una specie di tubercolosi ossea) che lo colpì dall’età di due anni e ne precluse lo sviluppo.
La forza della sua mente, riuscì per tutta la sua vita a trascinare i suoi muscoli deboli e la sua schiena anchilosata, fino a farlo diventare un gigante dell’intelletto, un culturista del pensiero moderno.
Socialista come il fratello in gioventù, fondatore dell’Ordine Nuovo, fondatore del Partito Comunista d’Italia nel 1921, con lo scisma di Livorno, fondatore de L’Unità, Marxista interpretativo, Leninista, critico già dal 1926 nei confronti dell’operato di Stalin.
Un precursore, avanti nei tempi rispetto al secolo in cui nacque, (forse pure avanti rispetto al secolo successivo), la sua modernità credo andrebbe riscoperta, molto probabilmente sarà rimpianta dalle future generazioni.
Sentire parlare di Gramsci da uno come me è come sentire parlare di Pelé da un calciatore degli amatori, ma appunto per la mia inadeguatezza, vorrei provare a spiegare perché ritengo il suo pensiero un traguardo per il futuro e non un semplice esercizio della memoria.
La “dittatura del proletariato” è un ossimoro, che fu causa, dai tempi in cui Marx la pensò, di infinite critiche mosse nei confronti dei comunisti, da parte dei loro detrattori di tutti i tempi, la frase ha un significato chiaro, per Gramsci (e anche per me), significa dare l’opportunità alle masse popolari di incidere, di decidere, di essere il loro potere.
Agli antipodi del concetto di oligarchia del partito e dei funzionari, che poi si sviluppò in Unione Sovietica.
Le masse popolari come attori del proprio futuro, le moltitudini, il quarto stato (come ben rappresentate dal pittore Pellizza da Volpedo), che si prendono in mano il potere, come non fu mai nel passato e neppure nel presente, un concetto talmente rivoluzionario da non essere capito tutt’ora da molti.
Oggi che si dibatte di cambiamenti climatici, di flussi migratori biblici, di guerre, di schiavitù dell’uomo nei confronti delle merci, dell’oppressione dei mercati nei confronti delle persone, quanto avremmo bisogno del pensiero gramsciano, applicato alla nostra presunta modernità.
La schiavitù, che pareva debellata secoli orsono, si ripresenta nel nostro secolo buio, sotto forme differenti, figlia di quel neoliberismo sfrenato, capitalismo 4.0 in un mondo senza quasi più opposizione, indifferente ai mutamenti, senza ribelli né ribellioni.
La vittoria del Capitalismo, gretto e senza limiti, dal crollo del muro alla realizzazione dei mille muri di oggi, ha falsato la visione del progresso, della modernità, portandoci a pensare che il privato è sempre bello ed il pubblico è sempre brutto.
Una visione gramsciana della società, internazionalista, non permetterebbe la schiavitù del pensiero, l’omologazione, la standardizzazione della società attuale, così come avviene oggi, in Italia e nel mondo.
Odiava gli indifferenti, Nino, perché lui era partigiano, stava chiaramente da una parte, dalla parte delle masse operaie e contadine, quelle stesse masse che ora, in questa derelitta Italia pensano che i nemici arrivino con i barconi, che il prima noi e poi loro sia cosa buona e giusta.
L’avversario politico, gira con la Ferrari o l’auto blu, non vende gli accendini in spiaggia o ai semafori. Il dividi et impera di Cesare è applicato oggi come mezzo di distrazione di massa, i penultimi contro gli ultimi, è diventato sistema di governo, nel XXI° secolo, in Europa, come in Gallia duemila anni fa.
Il concetto di intellettuale Gramsciano è lontano anni luce dal distaccato filosofo da salotto televisivo di oggi. Noi vediamo nelle TV, signori brizzolati di mezza età, dibattere sul mondo con termini difficili e poco comprensivi, che si contemplano l’ombelico della propria cultura, senza preoccuparsi se i loro concetti vengono capiti o assimilati da chi li ascolta.
Gramsci, al contrario era consapevole che l’intellettuale, l’operaio della mente, il manovale della cultura, era un’avanguardia, doveva mettersi al servizio delle classi subalterne, per svilupparne la dignità, per dar modo ai braccianti, ai contadini, agli operai di autodeterminarsi.
Come diceva Di Vittorio, per insegnare ai cafoni a non togliersi il cappello di fronte al padrone.
Così, Gramsci in carcere creò una biblioteca, gestì dei corsi di studio, insegnò l’abecedario a chi non sapeva né leggere e né scrivere. Aveva ben chiaro in mente che la cultura è rivoluzionaria.
La cultura è una delle poche speranze che abbiamo per il futuro, è l’unica arma utilizzabile per una legittima difesa consapevole e mai eccessiva.
L’esatto contrario di ciò che ci dicono di questi tempi, un tal sottosegretario odierno che gioisce perché in Italia nel 2018 ci sono state 30.000 iscrizioni in meno all’università, o quell’altro che alcuni anni fa disse: “con la cultura non si mangia”.
Certo, questo è il modo di pensare di oggi, dei nostri governanti, presenti e passati un popolo ignorante si fa poche domande, non ha strumenti per controbattere l’oligarchia dominate. Per questo motivo Gramsci pensava che un popolo istruito potesse essere la prima arma contro la dittatura, la pistola fumante contro i soprusi dei pochi, nei confronti dei molti.
“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.”
Questo pensava dei giovani.
Gramsci era l’antitesi del culto della personalità, sull’Ordine Nuovo, nel 1924 lanciò una critica feroce a Mussolini, in quanto immagine dell’uomo forte, egocentrico, nuovo imperatore di un sacro romano impero, costruito sulla menzogna e sulla cattiveria “Mussolini [… ] è il tipo concentrato del piccolo-borghese italiano, rabbioso, feroce impasto di tutti i detriti lasciati sul suolo nazionale da vari secoli di dominazione degli stranieri e dei preti: non poteva essere il capo del proletariato; divenne il dittatore della borghesia, che ama le facce feroci quando ridiventa borbonica.”
Ma, sinceramente, solo a me queste parole ricordano qualcuno? I ducetti, sono ben presenti tutt’oggi, li vediamo, li sentiamo ai telegiornali, io non credo che oggi ci sia un clima di neo-fascismo, ma di pre-fascismo, forse si.
Le parole uccidono, le parole sono pietre scagliate nei confronti delle minoranze, delle diversità, delle donne, dei deboli. Allo stesso modo fece il regime con Antonio, lo delegittimò, non lo uccise con una esecuzione sommaria, o non lo riempì di botte come da prassi, lo incarcerò e lo sacrificò, lentamente in oltre dieci anni di detenzione.
La sera del 25 aprile 1937 Antonio venne colpito da un’emorragia cerebrale. Neppure in questa estrema circostanza fu assistito adeguatamente, dal punto di vista clinico, (le suore della clinica dove fu segregato negli ultimi da due anni di detenzione, gli mandarono un sacerdote).
Gramsci si spense all’alba del 27 aprile, alle ore 4,10.
Gli ideali di Nino, i suoi pensieri, non morirono con lui.
Grazie alla cognata Tatiana, abbiamo avuto la fortuna di leggere le lettere dal carcere ed i quaderni.
Pensate, se non fosse stato incarcerato e se non ci fosse stato il fascismo, quante idee, parole e riflessioni avrebbero reso più ricca l’intera umanità.
Quanta rivoluzione del pensiero civile, illuminista, libertario e progressista, sarebbe potuta uscire da una delle menti più ricche e brillanti della storia dell’uomo.
In fondo Gramsci diceva solo che ad ogn’uno occorreva dare le stesse possibilità, sognava una mondo libero, equo, senza oppressori e senza confini, intagliato sulla pianta della giustizia sociale, dove i libri, al posto delle armi diventavano, il grimaldello per aprire le saracinesche del privilegio.
Nulla, a mio modestissimo parere di più moderno ed attuale è mai stato pronunciato, oggi, le moderne élite dominanti di politici e politicanti, vanno bene solo a contare i voti, come noi, da ragazzi contavamo le figurine dei calciatori.
Gramsci, come ricerca di un nuovo futuro, Gramsci come speranza, Gramsci che per non rinnegare i propri ideali rimase in carcere fino alla fine, pensate quanta differenza con chi ancora oggi rincorre il moderatismo, l’appiattimento verso destra del pensiero politico.
Perché è proprio in questo “mondo di mezzo”, che si generano i mostri che potrebbero distruggere il genere umano, se non la smettiamo di vergognarci della radicalità, rossa e libera come la mente di Antonio Gramsci.