LA VIGNETTA
Forza Italia Viva…!
illustrazione di Carlo Tassi
(tutti i diritti riservati)
Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, La vignetta di Cart.
illustrazione di Carlo Tassi
(tutti i diritti riservati)
Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, INTERVISTE.
La vicenda che vede coinvolto il rettore dell’Università di Ferrara, Giorgio Zauli, continua a dividere e a far discutere. Le contestazioni, relative a un presunto comportamento scorretto da parte del massimo rappresentante dell’Ateneo estense, scaturiscono a seguito della segnalazione di uno specialista di etica della ricerca scientifica, Leonid Schneider il quale, su “For better science” fin dal 15 maggio 2018 e in successivi interventi, ha accusato Zauli (e Paola Secchiero, sua collaboratrice) di aver manipolato grafici e immagini in alcune loro pubblicazioni scientifiche inerenti al campo dell’ematologia. Le imputazioni mosse da Schneider sono state successivamente condivise, fra gli altri, anche dalla giornalista scientifica Sylvie Coyaud, che della vicenda si è occupata a più riprese, scrivendone fra l’altro sul blog Ocasapiens del settimanale “D” di Repubblica e in “Oggi scienza”.
Il professor Andrea Pugiotto, presidente della Commissione etica di Unife, che avrebbe avuto titolo per intervenire, nei mesi scorsi non si è mai pubblicamente pronunciato nel merito della vicenda, spiegando che i membri della commissione – presidente incluso – sono tenuti “al totale riserbo”. Salvo poi dimettersi dall’incarico a fine agosto, unitamente ai vice Paola Migliori e Gian Matteo Rigolin, appena pochi giorni dopo il diniego opposto dal Rettorato alla richiesta di accesso agli atti della medesima commissione etica relativi alla vicenda Zauli, presentata dai colleghi di Estense.com. Ma già Schneider, il principale accusatore, fin dall’inizio aveva sollecitato l’intervento della Commissione etica di Unife. La sua richiesta, però, fu rigettata “per difetto di legittimità”. Al contrario venne accolta, dalla medesima commissione, la richiesta formulata dal rettore, che chiedeva un parere di conformità relativo alla propria condotta in riferimento al vigente codice etico.

Fra coloro che autorevolmente sono intervenuti sulla questione, si segnala il professor Lucio Picci, ordinario di Politica economica all’Università di Bologna e docente con un curriculum di notevole rilievo: studi negli Stati Uniti con una tesi di dottorato sotto la supervisione di un premio Nobel oltre a numerose prestigiose pubblicazioni. Inoltre, accanto all’attività scientifica, il professor Picci vanta familiarità con importanti istituzioni internazionali – ha collaborato tra gli altri con la Commissione Europea e con la Banca Mondiale – e nazionali, con una lunga lista che spazia fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’attuale ruolo di esperto per l’Autorità nazionale Anticorruzione. Picci, peraltro, si è occupato specificamente di corruzione accademica, criticando in più occasioni l’università italiana che, a suo avviso, “è colpevole di scarso interesse per l’etica della ricerca e di sistematiche assoluzioni all’insegna del corporativismo”. Una voce autorevole che spesso trova eco sulla stampa, come nel caso delle sue ferme prese di posizione, su varie vicende, fra le quali le più note hanno riguardato il professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna e l’attuale ministro, nonché docente universitario, Francesco Boccia.
Stanti le premesse chiedo a lei, professor Picci – che pure già è intervenuto in merito a questa imbarazzante situazione – un parere sulla vicenda che vede coinvolto il professor Zauli. In questi mesi se ne è parlato parecchio, ma chi è fuori dalle logiche universitarie forse fatica a capire. La prima cosa che le domando, dunque, è se ci può spiegare con chiarezza qual è il punto focale e cosa sostanzialmente viene contestato al rettore…
Una considerazione iniziale: trovo la vicenda avvincente come un thriller, di cui ha gli ingredienti essenziali; vi sono alcune certezze, che permettono una serie di supposizioni, per tentare di risolvere un mistero. Il punto di partenza sono i fatti noti: un sito americano che si chiama Pubpeer e che si occupa di “qualità della ricerca scientifica”, ha pubblicato materiali che, se veri, indicano violazioni delle regole di base dell’etica scientifica da parte del professor Giorgio Zauli (e di altri). Chiariamo allora, una volta per tutte, la portata delle accuse con un esempio. Supponiamo di cancellare i nomi degli autori, e per evitare qualunque personalismo di sostituirli con “tizio”, “caio”, eccetera. Se si chiedesse a qualunque scienziato in giro per il mondo di valutare quanto denunciato, l’interpellato concluderebbe che le accuse, se vere (sottolineo “se”), sono devastanti. Anche perché riguardano – ad oggi – una quarantina di pubblicazioni, e non si tratterebbe, dunque, di errori presentabili come sporadici. Aggiungerebbe poi che chi risultasse eventualmente colpevole di quanto denunciato non potrebbe in alcun modo guidare una comunità accademica seria.
Minimizzare le accuse è impossibile: questo risponderebbe qualunque scienziato rigoroso e in buona fede, senza leggere che l’autore è “Zauli” – per non farsi influenzare – ma “tizio” o “caio”. Se, ripeto ancora, quanto denunciato è vero, in toto o anche solo in buona parte.
Zauli peraltro ha diffidato il suo accusatore, intimandogli di cancellare il contenuto dell’articolo e prefigurando azioni giudiziarie in sede civile e penale. Secondo il rettore, Schneider avrebbe pubblicato “informazioni false e non provate sulla supposta inesattezza di alcune pubblicazioni scientifiche del sottoscritto”…
Attenzione: Schneider, che in ogni caso non ha cancellato un bel nulla, e anzi insiste e rincara la dose, ha ripreso le affermazioni contenute nel sito Pubpeer e, per così dire, ne ha fatto un caso. E neanche Pubpeer ha cancellato nulla, anzi, recentemente ha segnalato ulteriori pubblicazioni “incriminate” a firma Giorgio Zauli. È importante ribadire che il materiale infamante verso il professor Zauli è di Pubpeer e non di Schneider. Io non sono mai entrato nel merito di tutte queste accuse. Ho invece affermato con forza, prima dell’estate, che la questione doveva essere chiarita pubblicamente: l’Università di Ferrara aveva messo al lavoro sul caso la sua Commissione etica e non se ne era più saputo nulla. E alla mia richiesta, il rettore Zauli ha risposto in modo netto e inequivocabile, “affermando che “la Commissione Etica (nel gennaio 2019, ndr) ha archiviato il caso non essendo emersi a mio carico né elementi dolosi né di colpa grave“. Quindi, stando a quel rapporto, il rettore Zauli è innocente, anzi è vittima: e questo, prima dell’estate, mi pareva chiudesse la questione. Però, di conseguenza, nasceva un altro interrogativo dai tratti davvero inquietanti: ripeto, la vicenda è un vero thriller…
A cosa si riferisce?
Innanzitutto preciso che qui terminano le certezze e si entra nel campo delle supposizioni, dato che, come segnalato, l’Università di Ferrara sta difendendo coi denti la segretezza della relazione della Commissione etica. E’ impossibile che a fronte di accuse così gravi – se comprovate – il rettore possa essere scagionato. Per cui io deduco che la Commissione etica abbia considerato falso quanto pubblicato su Pubpeer. Ma attenzione: si tratterebbe di un falso corposo, composto da tanti documenti, grafici, tabelle relativi a decine di pubblicazioni! Un tale falso non può essere l’opera criminale di un singolo: induce a supporre l’esistenza di una vera e propria organizzazione a delinquere, mossa dall’intento di calunniare il rettore dell’Università di Ferrara…
E’ una prospettiva inquietante, non trova? E rimanda ad altri interrogativi: quali i moventi e le complicità di una tale organizzazione malavitosa? Considerato il suo carattere internazionale, non potrebbe esserci dietro la manina di una qualche potenza straniera? A chi ha pestato i calli, l’Università di Ferrara, perché si arrivasse a tanto?
Lasciamo aperti questi interrogativi… Stando alle cronache, per quanto si è capito della vicenda, emerge un aspetto che, secondo gli accusatori di Zauli, verrebbe a prefigurarsi come aggravante, al di là dell’imputazione: il fatto che il rettore avrebbe fatto scudo attorno a sé, ritenendo di non dover rendere pubblici gli atti e i documenti che potrebbero chiarire la vicenda, in un senso o nell’altro. E’ così?
Altro che “fare scudo”! E proprio qui sta il mistero… Ci attenderemmo che l’Università di Ferrara si difenda dal complotto che sarebbe stato ordito ai suoi danni. Che intraprenda un’azione legale nei confronti del sito Pubpeer e lo smascheri pubblicamente. Con facilità, peraltro: da una parte si pubblicano i loro documenti falsi, e dall’altra quelli autentici: così chiunque si renderebbe conto di dove sta la ragione e dove il torto. E invece che hanno fatto? Si sono mossi come un soldato che, anziché sparare al nemico, si scaglia contro i suoi possibili alleati: contro chi chiede di capirci qualcosa, e tra questi i giornalisti che sarebbero ben felici di raccontare al pubblico una tale inedita congiura, contribuendo a far trionfare il bene sul male. “L’Università di Ferrara vittima di un complotto internazionale”: sarebbe un vero scoop, il sogno di ogni giornalista. E invece, siamo arrivati al caso estremo di un comunicato ufficiale firmato dal rettore Zauli, in cui si propone un parallelo implicito tra chi ha chiesto trasparenza (io tra questi, ahimè) e Goebbels, il maggiore teorico dell’olocausto…
Non sono in grado di formulare neppure una plausibile ipotesi sul perché di questa scelta. Le confesso che mi pare una follia, ma forse, semplicemente, io non ho la stoffa del detective…
Al riguardo, secondo quanto scrivono sia la Nuova Ferrara che Estense, il Senato accademico starebbe valutando la possibilità di annullare – per un presunto vizio di procedura – la decisione con la quale la Commissione Etica ha archiviato la posizione di Zauli. Come interpreta questa evenienza?
Annullerebbero ora una relazione che fu approvata in gennaio? A distanza di nove mesi, ad orologeria insomma? E guarda caso, subito dopo l’annunciata richiesta di revisione (da parte di Estense.com) del diniego opposto alla richiesta di renderla pubblica? ‘Sacrificando’ il professor Pugiotto, già presidente di quella commissione, e il dirigente responsabile, che vivaddio dovrebbero rispondere di tali ipotetici ‘vizi di procedura’?
Non ci posso credere. Sembra una voce nata apposta per diffondere il sospetto che quel documento non s’ha da pubblicare, ne ora ne mai, perché a leggerlo bene non assolve nessuno, e per gettare altro fango sull’Università di Ferrara. Trucchi meschini: esprimo la mia solidarietà a Giorgio Zauli. Ma chi c’è dietro a queste macchinazioni? Utilizzano tecniche di disinformazione sofisticate: personalmente non escluderei neppure il coinvolgimento di qualche servizio segreto straniero.
E magari è proprio questa la spiegazione a una vicenda che a rigor di logica diversamente si fatica a comprendere e giustificare… Un’ultima domanda, ritornando alla realtà: lei tempo addietro aveva stigmatizzato “l’inspiegabile silenzio” dei docenti di Unife sulla vicenda. Immagino che avrà saputo del documento recentemente formulato a sostegno del rettore, sottoscritto da 240 docenti di Unife (su 642). Che ne pensa?
Mi meraviglio che le firme siano soltanto quelle che dice perché, come sosteneva Ennio Flaiano, gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori. Ma in Italia c’è anche un’altra tradizione, minoritaria, ma credo più nobile: di chi, quando di fronte si trova il potere borioso e arrogante, gli ride in faccia.
Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.
Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’
APRITI CIELO
Apriti cielo
a volte mi dico
E vorrei urlare
Per disarcionare
Quell’angoscia di vivere
che mi guida
senza meta
Apriti cielo
A volte mi dico
E vorrei piangere
Per togliermi quel peso
che mi zavorra lo stomaco
addolora dire e sentire questa tenaglia
Ma non a te
Che conosci le giornate storte tue
e anche mie
E mi aiuta
La tua scialuppa
Per cavarsi dalle onde
Dal loro mattatoio
E infilare il tuo abbraccio
Come accappatoio
Scritto da Giorgia Mazzotti il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.
Un ferrarese che tutte le estati trasmigra in riva al mare di Romagna, ma che la sua città se la porta sempre con sé e non smette mai di sentirsela e avercela intorno, anche quando sbuffa e dice “qui sì che mi rigenero”.

Quella del critico d’arte ed editore Lucio Scardino, infatti, è una casa del mare romagnolo con le pareti tappezzate dai dipinti del fiume Po e da rivisitazioni del Duomo di Ferrara, gli scaffali pieni di libri d’arte e una collezione di piatti e zuppiere che sembrano quelli di una vecchia signora inglese e che – quando li osservi meglio – scopri che invece hanno disegnato sopra il Castello Estense rivisitato in chiave avventurosa, nelle tinte monocrome del blu, del color ruggine o del marrone sulla porcellana bianca dove galleggia persino un veliero.

Qui, nell’appartamento tra i pini marittimi di Lido di Classe, tra Ravenna e Cervia, il critico d’arte ferrarese Lucio Scardino si trasferisce nel periodo estivo senza rinunciare alla compagnia delle opere di artisti a lui cari. Tra i 250 pezzi di questa collezione variegata di tele, sculture e schizzi c’è un disegno di Jenny Bassani, sorella dello scrittore Giorgio, con la borgata di Quacchio ripresa nel 1943, qualche mese prima dei bombardamenti.

Poco più in là, sulla parete c’è uno scorcio del fiume Po, colto poco prima dell’alluvione da Gastone Gaddi, nel 1951. Sculture e quadri sul tema di San Sebastiano si mescolano a un olio su tavola di Augusto Droghetti che – spiega Scardino – “rende bene le atmosfere e la prospettiva del fiume, con la visione dell’isola bianca di Pontelagoscuro sullo sfondo”. Così, tra una passeggiata in spiaggia e una capatina nella sala del cinema all’aperto, il critico-editore medita e studia, organizza e riflette, preparando lo sbarco cittadino d’autunno. Perché Ferrara, Scardino, ce l’ha sempre in testa, negli occhi e tra le dita. Ecco allora che sul tavolone rotondo, vicino alla caraffa di tè freddo e ai frollini, salta fuori un catalogo di disegni di paesaggio e il volume con il romanzo dedicato alla “Famiglia” di Lucrezia Borgia, raccontata nientemeno che dall’autore del “Padrino”, Mario Puzo.
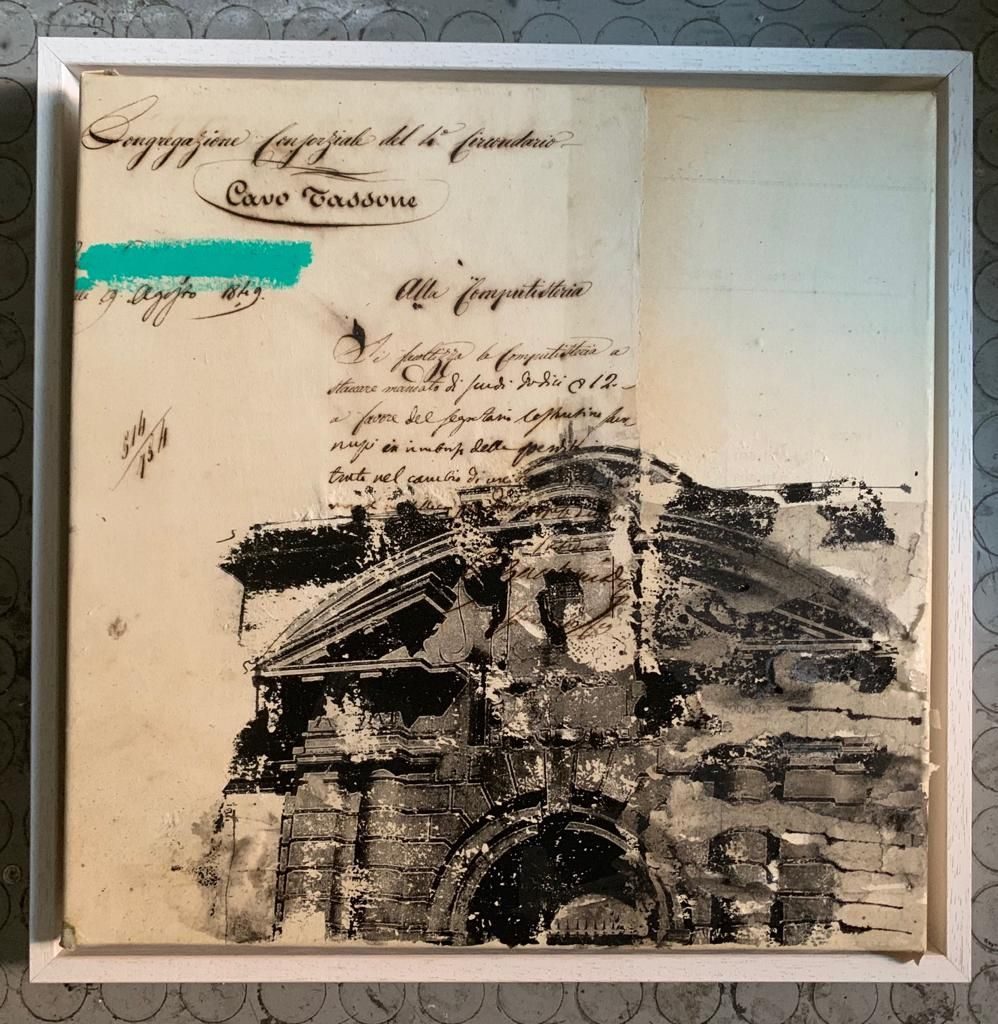
“Sto preparando due mostre” racconta il critico ed editore.
“Paesaggi d’acqua” è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata venerdì 27 settembre 2019 alla galleria Fabula Fine Art (via del Podestà 11, Ferrara) con “una quindicina di opere sul Po che andranno dall’inizio del ’900 ai giorni nostri”. Neanche a dirlo “non si tratterà di una mostra di cartoline illustrate, ma di collage d’arte moderna che rievocano il mito di Fetonte (autrice Rita Da Re), acquerelli degli argini fluviali, chiatte, barche, anse e golene; e poi immagini rievocative del mito delle ‘anguane’, le sirene che la leggenda vuole che popolino le acque dolci e le rive fluviali come quella del ‘Notturno sul Po’ realizzata da Oreste Forlani attorno al 1905″. Una versione concettuale del Po quella contenuta nell’opera di Daniele Cestari: “Qui – fa notare il curatore della mostra – il fiume è condensato in una striscia color smeraldo, unica traccia di colore sulla carta che riproduce la facciata di Porta Paula. In questo punto di ingresso a Ferrara, infatti, è stata rinvenuta un’antica barca che testimonia la presenza del corso d’acqua nei secoli passati, anche se ormai si trova all’asciutto da tempo”.
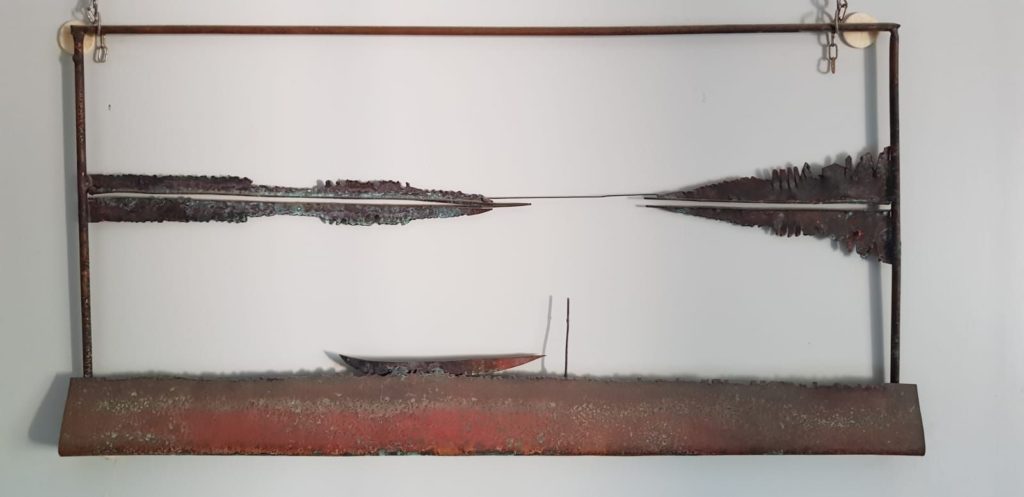
L’altra mostra in fase di programmazione è quella dedicata a “Lucrezia Borgia” con “una quindicina di opere ispirate alla duchessa ferrarese e che sta appositamente realizzando il pittore fiorentino Impero Nigiani”. Quest’altra mostra verrà allestita in dicembre 2019, sempre alla galleria Fabula Fine Art (via del Podestà 11, Ferrara).
“Paesaggi d’acqua”, 27 settembre-15 ottobre 2019, galleria Fabula Fine Art, via del Podestà 11, Ferrara. Ingresso libero.
Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.
Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’
VECCHI RICORDI
La vita
La memoria
Sono in filigrana
Dei piccoli fotogrammi
Che ritornano
Dei boomerang
Nella mente
Ricordo di te
A una cena con altri di come mi guardavi
Con una tenerezza
E un languore
Così dolci
Da magnete
Forse anch’io
Ti guardavo in maniera speciale
Poi mi sedetti accanto a te
Come un complice del mistero
Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.
Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’
PER ARTEMISIA
E adesso tu
Hai acceso la luce
Portando il mio corpo
alla fantasia del tuo abbraccio
Si la magia dell’unità
Della fusione calda
Che non ci confonda
L’immateriale lieto trasportare
delle onde magnetiche
al mistero che ci circonda
E adesso tu
Hai acceso la luce
Nelle nostre cavità
Come una sponda
di lama
Di fiamma che accarezza le labbra
di chi si chiama
A giorno
Sulla nave
Della torba
L’humus che conforta
Di volere anima e terra
In un cerchio
Che s’apre
Si sferra in nuce
E adesso tu
Hai acceso la luce
Scritto da Francesco Monini il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.
La campagna ‘Parchi puliti’ e l’intenzione dell’iperattivo vicesindaco Nicola Naomo Lodi di smantellare le panchine in città come prima misura antispaccio è una notizia che ha qualcosa di surreale. Come possibile pensare che togliere posti a sedere possa servire a contrastare gli spacciatori e bonificare i giardini del grattacielo? C’è forse bisogno di avere una panchina a disposizione per vendere e acquistare droga? Non basta girare a piedi e ‘spacciare in movimento’? O, come sta già succedendo, spostarsi in qualche altra zona di Ferrara?
La campagna contro le panchine – ad oggi non sappiamo fino a che punto verrà portata a compimento – sembra una misura talmente assurda e incongruente da indurre più all’ironia e alla satira che alla protesta civile. Così infatti Diego Marani, in un suo gustoso intervento sulla Nuova Ferrara, non resiste alla tentazione di mettere alla berlina la giunta leghista che eliminando il luogo (la panchina) pensa di eliminare il fenomeno (lo spaccio): “Seguendo questa logica, l’assessore Lodi dovrebbe allora vietare le borsette alle signore per sventare gli scippi, confiscare tutte le biciclette per evitarne il furto, chiudere le banche per scoraggiare le rapine”. Il vecchietto nella vignetta di Carlo Tassi su questo giornale propone invece come estremo deterrente una attualissima idea amazzonica: eliminare in toto gli alberi che regalano un’ombra accogliente agli spacciatori e ai malintenzionati.
Insomma, la tentazione di metterla in ridere è forte. Eppure sarebbe sbagliato prenderla sottogamba: la battaglia contro le panchine – si tratti pure di una semplice operazione propagandistica senza drastiche e definitive conseguenze – è un segnale preoccupante, rappresenta con assoluta evidenza un’idea pericolosa di governo della città. Significa voler affrontare un problema di sicurezza sociale – e quello dello spaccio a Ferrara lo è eccome – chiudendo spazi, eliminando luoghi e occasioni di incontro e moltiplicando inferriate, telecamere e controlli. Insomma, la questione è terribilmente seria. In questi giorni singoli cittadini e Associazioni stanno promuovendo una raccolta di firme contro lo smantellamento delle panchine, E’ una buona notizia.
C’è naturalmente altro. Dopo aver smontato e disperso il campo nomadi, anche verso i giovani e i pericoli della ‘movida’ di una città con più di 20.000 studenti universitari la nuova Giunta propone un giro di vite.E che ne sarà in un prossimo futuro dei festival ferraresi o dei concerti d’estate, pericolosa occasione di folle schiamazzanti?
A Ferrara tira oggi un’aria di chiusura, come se per difendersi dal malessere e dal disagio sociale non si possa fare altro che ridurre gli spazi della socialità invece di riempire e riconquistare gli spazi perduti. Panchine comprese. E’ su questo che occorre porre attenzione. Se la sicurezza diventa l’imperativo categorico, la via maestra che ispira tutte le scelte di governo della città (in assoluta continuità con l’operato dell’ex Ministro dell’Interno) allora la faccia di Ferrara è destinata a cambiare progressivamente. Come? Per immaginare il punto d’arrivo, basta avere in mente alcuni quartieri delle grandi metropoli: piazze e strade vuote, e la gente prigioniera in case blindate come casseforti.
La panchina è un bel simbolo di socialità. In panchina non sostano solo gli spacciatori. Ci si siedono gli anziani (Ferrara è una delle città più vecchie d’Italia), i ragazzi, le mamme con i bambini… In panchina ci si dà appuntamento, ci si incontra, si parla, si legge un libro, si guarda il verde dei prati e degli alberi, ci si innamora perfino. Se non ho più dove sostare (e dove bere un sorso d’acqua: le fontanelle sono sempre più rare) la città diventa solo un luogo da attraversare in fretta, non un posto dove vivere.
Non mi piace disegnare scenari apocalittici, ma senza accorgercene rischiamo di imboccare un bivio: la chiusura invece dell’apertura, la difesa invece del coraggio. Non leviamo le panchine, mettiamone altre, e aggiungiamo magari qualche fontanella.
Scritto da Giovanni Fioravanti il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, LA CITTA' DELLA CONOSCENZA / RUBRICA CESSATA.
Aveva sfiorato anche me il dubbio che la causa della situazione politica in cui versa il Paese andasse ricercata nella nostra scuola. Se invece di professarmi insegnante democratico, quello di “non uno di meno”, dell’ “I care” ne avessi bocciato qualcuno dei miei studenti, forse i barbari alla guida del paese non ci sarebbero mai arrivati.
Ma evidentemente anch’io appartengo a quella classe degli Ottimati, di cui scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera del 19 agosto, che scopre solo ora di vivere accanto a un’altra Italia, sudaticcia, incolta, ignara di cosa sia “il bene pubblico”, che detesta Greta e le Ong, che frequenta il Papeete, vota Lega e 5 Stelle: l’Italia barbara.
Questo il Galli della Loggia che, in formato ferragostano, torna a sproloquiare di scuola. Perché per parlare di scuola è sufficiente averla frequentata, avere insegnato all’università e soprattutto avere avuto una nonna maestra così scrive nel suo “L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola”. Ora ha scoperto con improvvida illuminazione che l’invasione dei Barbari poteva benissimo essere fermata:”Sarebbe bastato ad esempio fare delle riforme della scuola diverse di quelle approvate per tanti anni”. Le riforme di cui parla Ernesto Galli della Loggia le ha viste solo lui, perché l’Italia sarà pure un paese invaso dai Barbari ora, ma non ha mai smesso di essere un paese gattopardesco dove le riforme si fanno perché nulla cambi.
A seguire il Galli-pensiero si comprende che la parola “riforma” non si addice alla scuola, regno della conservazione e archivio del passato. Per la scuola deve valere il motto dei Certosini a proposito della loro comunità: “mai riformata perché mai deformata”. E ciò che non doveva essere deformata è la scuola, quella frequentata da lui, bambino e poi ragazzo: l’elementare Principessa Mafalda di Savoia (di cui apprezza che non sia stata mutata l’intitolazione), la media Ippolito Nievo e il liceo Goffredo Mameli di Roma.
Tale doveva restare, immobile nel tempo, come le memorie dell’infanzia. All’Ippolito Nievo insegnava la professoressa De Sanctis, con un passato da intellettuale fascista, che “trattava gli alunni come se fossero gli allievi di una accademia militare”, capace di lezioni di vita e di somministrare i primi rudimenti del latino in maniera indimenticabile. Una scuola in cui si respirava l’atmosfera dell’ esempio e della disciplina e che, per questo, certo non aveva bisogno di educazione civica né di cittadinanza e Costituzione. La scuola dei riassunti, con qualche mezzo canto della Divina Commedia mandato a memoria.
È sempre la scuola di ieri la scuola migliore, mai quella di oggi, per non parlare di quella di domani che non si è in grado neppure di immaginare.
Ma l’affondo Galli della Loggia lo riserva al “successo formativo” obbligatorio, considerato una deriva demagogica, una palla al piede dell’istruzione.
Galli è di quelli a cui Barbiana continua a pesare sullo stomaco, gli procura cattive digestioni e notti insonni.
A Galli della Loggia deve essere sfuggita l’ultima relazione della Corte dei Conti sulla dispersione scolastica e su come contrastarla. Altro che “democraticismi demagogici”, come sostiene con faciloneria, ad essere in gioco non è la scuola di una volta ma la politica, qui ed ora. Governi e ministri che in tutti questi anni non sono stati in grado di fornire al paese un sistema scolastico capace di garantire a ciascuno il pieno esercizio del diritto allo studio, per miseria economica e intellettuale, sarei tentato di dire.
Mentre l’Europa a Lisbona, nel 2000, apre la strada alla società della conoscenza e all’istruzione per tutta la vita, noi siamo ancora alle premesse. Prima ancora di parlare di cosa studiare e di come studiare dovremmo ragionare dell’accesso allo studio, forse non saremmo un paese con il minor numero di laureati, dopo la Romania, e con il 41% della popolazione tra i 15 e i 64 anni che ha conseguito al massimo la terza media.
La relazione della Corte dei Conti, pubblicata a fine luglio, denuncia una scuola colabrodo, che dal 1995 ad oggi ha perso per strada oltre 3 milioni e mezzo di ragazze e ragazzi, è come se fosse sparita un’intera metropoli.
Bastava a Galli della Loggia leggere le poche righe di sintesi, all’inizio della relazione, dove è messo in evidenza come il nostro sistema di istruzione soffra di una inadeguata valorizzazione di quell’immenso capitale umano che è la formazione dei giovani. Della carenza di decisione e progettualità, oltre che di una forte resistenza a mettere in discussione il modello curricolare tradizionale e gli stili professionali consolidati dei docenti, alla faccia delle riforme.
Dopo la diagnosi è suggerita la cura. Sviluppare strategie che consentano di intercettare il disagio, che riescano a rimotivare lo studente con percorsi di istruzione basati sull’esperienza dell’apprendimento e non sul contenuto (ciò che si deve insegnare), prevenendo così, sia la dispersione scolastica che l’insuccesso nei percorsi superiori (vedi università) migliorando sensibilmente la capacità di ingresso nel mondo del lavoro. Tutto l’opposto del Galli-pensiero.
Forse più che un paese di barbari, il nostro è ancora un paese barbaro. E allora perché stupirsi di Barbari, Ottimati e dei Galli della Loggia?
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.
Da: Coordinamento nazionale dei diritti umani
Il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani esprime profonda apprensione e amarezza in merito agli incendi devastanti che stanno intaccando irrimediabilmente il polmone verde della Terra: l’Amazzonia. Com’è possibile pensare di profanare uno dei luoghi più simbolici, sacri e “salvifici” dell’intero pineta? Davvero la cecità umana non consce limiti.
Pare proprio che la distruzione progressiva del mondo ad opera dell’uomo non abbia alcuna logica; eppure la ragione dovrebbe suggerire che devastare, inquinare, consumare in modo scriteriato le risorse naturali comporta a breve termine il nostro annientamento. Invece assistiamo all’ennesima follia criminale perpetrata ai danni della Natura, in funzione del Dio denaro. Ai potenti della Terra il compito di invertire la rotta, perché se è vero che i primi a subire gli effetti di un pianeta malato saranno i più poveri, prima o poi le conseguenze di una cattiva condotta ecologica riguarderanno tutti. Per chi opera nella scuola, la responsabilità di sensibilizzare i giovani è fortemente sentita da tanti colleghi. Il Coordinamento invita il MIUR ad organizzare una Conferenza internazionale nel mondo della scuola sulla difesa dell’ambiente che coinvolga tutti gli istituti di ogni ordine e grado; gli attivisti, le associazioni, le fondazioni e le aziende interessate in modo da avviare un macro progetto di salvaguardia / buone pratiche ambientali, avvalendosi anche di network e piattaforme digitali.
“La lotta per salvare l’ambiente globale è molto più difficile che la lotta per sconfiggere Hitler, perché questa volta la guerra è con noi stessi. Noi siamo il nostro nemico, così come abbiamo solo noi stessi come alleato.”
(Al Gore)
Scritto da Fiorenzo Baratelli il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI.
1.
Matteo Salvini è fuori di testa e disperato. Il deliro di onnipotenza lo ha portato in un vicolo cieco. E in un attimo le sue parole diventano confuse e assurde. Per esempio, quando dice: “Ho chiesto i pieni poteri secondo la Costituzione”. Un ossimoro da bocciatura all’esame di Diritto Costituzionale. Oppure, negando spudoratamente l’evidenza dei fatti, dichiara: “Conte ha lavorato per sfasciare”. L’augurio che formulo è che l’evoluzione della crisi di governo volga in una direzione che sanzioni il suo isolamento politico e l’inizio della parabola di un ‘piccolo uomo’ che aveva indossato la divisa di… Napoleone.
2.
Il Pd è di fronte ad una prova che ricorda la classica quadratura del cerchio. Zingaretti ha sempre sostenuto la diversità del M5s rispetto alla Lega, anche quando nel suo partito c’era chi li metteva sullo stesso piano. Ma nella trattativa non si possono dimenticare quattordici mesi di governo disastroso ed egemonizzato dalla destra leghista. Per esempio il M5s ha condiviso i decreti sulla sicurezza che sono un monumento alla disumanità. Senza il riconoscimento di una nuova fase l’eventuale nuova maggioranza sarebbe percepita come il solito ribaltone trasformista. Che regalo si farebbe a Salvini! Cercherebbe di uscire dall’angolo e incendierebbe le piazze contro la ‘casta delle poltrone’ e contro il Parlamento. Il Pd deve impegnarsi per dar vita ad un governo solido e duraturo, respingendo pasticci per paura del voto. C’è da battere una destra razzista e feroce, ma alle porte non c’è un nuovo fascismo che richieda un Badoglio dei nostri giorni. Nuovo e autorevole Presidente del Consiglio e nuovo programma di governo alternativo alla destra devono essere i due fondamenti della discontinuità.
3.
A Ferrara come sta reagendo la Lega alla crisi provocata dal suo capitano? Silenzio. Con una prevedibile eccezione: Nicola Lodi. Il vicesindaco ha ripubblicato in rete una sua foto assieme a Salvini con una semplice didascalia: “Sempre con te”. Fedele fino all’ultimo come in ogni copione che si rispetti di ascesa e caduta di un capo. Ma attenzione a non confondere questa scena con quelle drammatiche di altri fedeli che decisero di morire nel bunker insieme al proprio capo. Come ricordava il vecchio Karl Marx, spesso la storia si ripete due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa.
Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, La vignetta di Cart.
illustrazione di Carlo Tassi
(tutti i diritti riservati)
Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.
Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’
LA MIA ROSA
Tu sei la mia rosa
La mia rosa bianca
Il mio roseto
Senza dubbio
Senza Amleto
Non mi stanca
La tua luce bianca
Il tuo profumo
Dei campi
Di una civiltà contadina
Che è scomparsa
Svanita
Dalla sera alla mattina
Un amen
Tu sei la mia rosa bianca
Tersa
Pulita
Delle giornate lente
Della terra che riposa
Si tu sei la mia rosa
Scritto da Liliana Cerqueni il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.
Quando si parla di streghe si evocano inevitabilmente le pagine inquietanti del periodo dell’Inquisizione, dell’ostracismo, della delazione, delle persecuzioni, dei processi sommari, delle condanne sui roghi, le ammissioni di colpa estorte con le torture, dell’isteria di massa e dell’oscuro clima di superstizione che ha contrassegnato la nostra storia di qualche secolo fa. Nella nostra civiltà occidentale, si parla di donne invise dalle loro comunità, calunniate, indicate come colpevoli di ogni nefandezza, creature sospese tra la carnalità terrena e il soprannaturale demoniaco in grado di compiere sortilegi e malefici, provocare catastrofi, seminare il male e determinare il destino di chiunque. Ed è proprio di streghe che si parlerà nella serie tv ‘Luna Nera’, in arrivo su Netflix Original Italiana, piattaforma streaming, nel 2020. La storia di quattro donne sospettate di stregoneria nel XVII secolo in Italia, è stata liberamente tratta dal libro ‘Le città perdute. Luna nera’ di Tiziana Triana in prossima uscita, e conta sulla regia di Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi. Un evento atteso per la sua spettacolarità e originalità, per il suo carattere prettamente al femminile: donne che raccontano di donne, riesumando le tristi pagine della ‘caccia alle streghe’. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una giovane levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria e costretta a fuggire dal villaggio. Trova asilo presso una misteriosa comunità di donne accusate di praticare la magia nera… Ragione e irrazionalità, credenze e sospetti, mistero e intrigo: ecco i leitmotiv della serie tanto attesa, conclusa a luglio dopo il primo ciak dello scorso marzo.
Abbiamo intervistato in anteprima Adalgisa Manfrida, la giovane attrice che interpreta la strega Persepolis.
Vuoi raccontarci chi sei, Adalgisa?
Sono nata in Germania, a Stoccarda il 21 maggio del 1993 da papà Siciliano e da mamma Trentina. Sono la seconda di 4 figli. All’età di 3 anni con la mia famiglia mi sono trasferita in Sicilia, in provincia di Enna, dove sono cresciuta fino ai 12 anni. Dal 2006 ho vissuto in Trentino fino ai miei 19 anni, per poi trasferirmi a Roma per studiare recitazione e dove vivo tutt’ora. Ho frequentato il liceo classico e successivamente mi sono diplomata nel 2017 all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico di Roma.
Qual è stato il momento in cui hai capito che recitare sarebbe stata la tua scelta esistenziale e professionale?
A 12 anni frequentai un corso di teatro a scuola. Le ore di prove al pomeriggio volavano, tornavo a casa continuando a ripetere tutte le battute. Lo spettacolo andò in scena all’anfiteatro greco di Morgantina, in Sicilia, alle 5 del pomeriggio. Ero paralizzata dalla paura, era pieno di gente, c’era la luce del giorno, non era buio come nel teatrino in cui provavamo, e potevo quindi vedere tutte quelle persone distintamente. Poi successe che la gente cominciò a ridere, a ridere quando entravo, a ridere di ciò che dicevo. Una vertigine. Il desiderio di quella paura e di quella vertigine non mi hanno ancora lasciato.
Che ruolo ha avuto la tua famiglia nelle scelte che hai fatto?
Quand’ero piccola, non avendo uno spazio dove provare con gli altri ragazzini lo spettacolo con cui saremmo dovuti andare in scena nel paesino nel quale abitavo, ci recavamo dell’officina di mio padre che è meccanico. Ogni sera alle 18, lui e mia madre svuotavano una parte di quel posto, pulivano, mettevano per terra dei cartoni ed ecco il palcoscenico che ci serviva. I miei genitori hanno sempre preso seriamente i miei sogni, tanto quanto me, e ciò mi ha permesso di non pensare mai che fossero stupidi o irrealizzabili.
Come è stata la tua formazione in Accademia?
Sono stati tre anni di duro lavoro, costantemente in bilico tra la sorpresa di ciò che potenzialmente e realmente si può essere e il timore del fallimento, anche nelle cose più stupide. Lavori ogni giorno su te stesso, i tuoi limiti ti appaiono in modo molto più evidente e bisogna riuscire a non scoraggiarsi, a continuare a lavorare, senza scuse, alibi e giustificazioni.
Cosa significa per una giovane come te, decidere di vivere da sola a Roma, studiare e lavorare? Quali sono state le criticità e quali gli aspetti positivi?
Avevo 19 anni e i soldi contati. Essere finalmente in una città che già inspiegabilmente amavo, senza nessuno che sapeva chi fossi e viceversa fu una vera gioia. Trovare un lavoro degno e onesto per mantenersi e pagarsi le lezioni, invece, è stato duro, tra datori di lavoro aggressivi, turni lunghissimi, paghe da fame, tremendo. Mi sembrava di soccombere in una realtà che non avevo previsto, ero piena di rabbia. In qualche modo quella frustrazione mi ha spinta a fare di tutto per uscirne, e ho puntato tutto sul provino in Accademia.
Quali sono le attitudini, le caratteristiche e i ‘talenti’ richiesti nella professione di attore?
Forse la capacità di ascoltare allo stesso tempo dentro e fuori di sé, di rispondere a questo ascolto con l’istinto, la spontaneità, la creatività, il corpo e l’intelligenza. Forse la capacità di farsi da parte, essere diverso da se stesso o forse, al contrario, essere perfettamente al centro di ciò che si è. Forse nessuna di queste cose. Ognuno è ciò che è, spinto alle volte da una grande forza per diventare altro, migliore, completo. Felice di potersi esprimere totalmente.
Quali le differenze tra recitazione in teatro, televisione e cinema?
Non credo che ci sia una differenza di sostanza nel lavoro dell’attore; ti è richiesto di fare, in fondo, la stessa cosa. Forse è diversa la gestione del lavoro e dei suoi tempi: a teatro provi per 4/5 settimane ogni singolo movimento, battuta, impari ad abitare ogni situazione e il suo spazio. Su un set è possibile che questo tempo non ci sia, che una scena venga costruita in quel momento e bisogna essere molto disponibili a cambiare ciò che si sta facendo da un momento all’altro.
Come sei arrivata alla scrittura, molto importante per la tua crescita e affermazione personale, nella nuova serie che uscirà i primi mesi del 2020 ‘Luna nera’? Puoi anticipare qualcosa? Che tipo di esperienza è stata?
“Luna Nera” è stata la mia prima esperienza sul set. Mi sono stupita per tante cose del tutto nuove per me, del fatto che si possa parlare pianissimo (a teatro non puoi farlo!), che basta l’accenno di uno sguardo, un sospiro. Il set è sempre stracolmo di persone che lavorano contemporaneamente, sorgono piccoli imprevisti in continuazione, a volte bisogna attendere diverse ore e diventa fondamentale imparare a gestire le proprie energie per non arrivare stanchi e deconcentrati.
Come vedi il tuo futuro professionale? In Italia o all’estero?
Il mio futuro professionale lo vedo ovunque ci sia la possibilità di migliorarmi, che sia l’Italia o l’estero non è importante. Ovviamente per un attore la lingua è fondamentale e io amo l’italiano, è la mia lingua, ma mi piacerebbe far parte di un progetto, sia teatrale che cinematografico anche all’estero.
Avremo occasione di seguire Adalgisa Manfrida, la strega Persepolis, nelle sue vicende movimentate, insieme ad Ade, Valente e Tebe, Leptis, Janara e molti altri personaggi che ci permetteranno un tuffo nel passato, ricordando che la strada dell’emancipazione della donna, la conquista della pari dignità di genere e il riconoscimento del suo contributo alla civiltà, è lastricata di vergognose parentesi.
Scritto da Francesco Monini il . Pubblicato in OPINIONI, In Evidenza.
Le cose non vengono per caso. Nello stesso giorno, mentre al Senato va in scena l’ultimo atto dell’ex governo del cambiamento, si chiude la lunga odissea della Open Arms con lo sbarco immediato degli ultimi novanta migranti. Naturalmente l’emergenza continua e c’è da chiedersi che ne sarà dei 356 imbarcati sulla Ocean Wiking e della feroce politica dei “porti chiusi” e della “sacra difesa dei confini” che ha rappresentato il fulcro della fortunata propaganda malpancista del dimissionario Ministro degli Interni. Qualcuno a sinistra ha una credibile politica alternativa per riaprire le porte alla immigrazione legale e impostare un serio confronto con gli altri stati europei? Io non riesco ancora a vederlo.
Mentre il mazzo di carte torna nelle mani del presidente Mattarella – e tutti si appellano alla sua sapienza e prudenza istituzionale – il commento unanime sui media è che questa volta Matteo Salvini abbia toppato, sbagliando clamorosamente i tempi e i toni e cacciandosi alla fine in un vicolo cieco. La prova ultima sarebbe il ritiro da parte della Lega della mozione di sfiducia presentata pochi giorni prima e l’estremo tentativo di una ricucitura con l’alleato pentastellato. “Fuori tempo massimo”, hanno risposto in coro gli esponenti del Movimento 5 stelle.
E’ quindi finita la grande ascesa di Salvini? Si romperà quell’incantesimo che ha permesso alla Lega di vincere una dopo l’altra le elezioni (europee, regionali, municipali) e di arrivare a sfiorare il 40% nei sondaggi? Basta guardare le piazze piene di folle acclamanti che in tutta la penisola accolgono il grande capo leghista per rendersi conto che Matteo Salvini non solo resterà in campo ma continuerà ad essere il protagonista indiscusso attorno a cui ruoterà la scena politica italiana. A maggior ragione se in autunno si tornerà a votare.
A meno che Mattarella… Non sono un esperto e nemmeno un indovino, ma l’unica alternativa alle elezioni anticipate sembra davvero poco praticabile. Diventa difficile pensare che da questa crisi al buio possa sortire un governo con un programma credibile e condiviso, capace di portare a termine la legislatura. Il governo giallo-rosso, la strana alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, pur sponsorizzata da Renzi e da Prodi, si presenta come un esercizio di acrobazia politica. Una soluzione ancora più complicata e pasticciata del passato governo giallo-verde
C’è in realtà un’unica vera ragione – che tutti sanno ma che nessuno dice, né il Pd né i 5 Stelle – che favorisce, almeno in teoria, la somma giallo-rossa e la formazione di un nuovo governo. Non è certo la vicina scadenza di una Finanziaria lacrime e sangue e il probabile e paventato aumento dell’Iva: perché, al di là dell’allarme generale, nessun partito ha una ricetta per uscire dal buco nero dei nostri conti in rosso. E non è nemmeno la conclamata volontà grillina di portare a termine l’iter per il taglio del numero dei parlamentari. L’unica cosa che oggi accomuna Pd e 5 Stelle è la paura delle elezioni anticipate; una paura matta (quasi una certezza) che la destra, e la Lega in particolare, capitalizzi il consenso degli ultimi mesi e faccia il pieno di voti.
Naturalmente Pd e 5 Stelle si dichiarano prontissimi al confronto elettorale. Giurano di non badare a interessi di bottega e di avere a cuore solo il bene del Paese. Ma queste sono cose che si devono dire, ritornelli che lasciano il tempo che trovano. La vera posta in gioco, la vera grande preoccupazione è impedire a Matteo Salvini di stravincere le elezioni anticipate e diventare Presidente del Consiglio.
Il tempi della crisi sono strettissimi e Mattarella ha giustamente una gran fretta. Se anche dovesse partire una trattativa tra Pd e 5 Stelle, non avranno a disposizione due mesi come quelli che servirono per scrivere il famigerato contratto tra Salvini e Di Maio. Se alla fine vincesse la grande paura (di perdere le elezioni anticipate) e si arrivasse comunque a un accordo giallo-rosso, c’è da scommettere che il nuovo governo sarà diviso e litigioso come o più di quello che lo ha preceduto. Con una prospettiva di vita molto breve.
Matteo Salvini è stato il coautore e il principale protagonista dello sciagurato governo giallo-verde, ma questa volta ha ragione. Piuttosto che un altro pasticcio, meglio le elezioni subito. Piuttosto che arrendersi alla paura, meglio affrontarsi in campo aperto.
Scritto da Gianni Venturi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, Diario in Pubblico, In Evidenza.
Un silenzio surreale avvolge le file degli ombrelloni mentre da lontano si staglia il palco ‘dell’evento’ jovanottiano su cui si erge un immenso pupazzo e delle sfere che ricordano palle di gelato. L’avvio è previsto per le 16 mentre il discorso delle dimissioni di Conte alle 15, ma il mormorio eccitato anticipa alle 14 il bagno di folla (e di qualcosa d’altro). ‘Lui’ non apparirà che in tarda serata, ma prima si potrà fare di tutto e di più; come del resto promettono i politici in aula per le dimissioni Conte. Del popolo ‘itagliano’ non emerge che questa individuazione del caos come sublimità della natura tatuata italiana. I due Mattei si danno battaglia, l’uno col Vangelo e le parole di un santo papa mentre l’altro, il Renzi, sacrifica le offese personali a un dio laico che lo riporti i cima all’onda su cui vuole restare. Mi prende un lieve sentimento di nausea. Al supermercato afferro un bottiglia di ottimo Lagrein che avrebbe dovuto accompagnare gli spaghetti aglio, olio. Illuso. La commessa che mi conosce da anni e che sa della mia sobrietà delicatamente mi sottrae la bottiglia. Impossibile venderla per evitare d’introdurre nella zona rossa alcolici. Siamo alla farsa. Il guitto si farà i milioni sfruttando l’ingenuità del popolo bue così come milioni di cittadini aspetteranno di votare il dio del Papeete o qualcuno di quegli individui che ci governano. Spontaneo mi sovviene il titolo di un passo tratto dalla celeberrima opera del grande Eduardo De Filippo ‘Napoli milionaria’. Eccola nel commento dello stesso De Filippo
“Le offre una tazzina di caffè. Amalia accetta volentieri e guarda il marito con occhi interrogativi nei quali si legge una domanda angosciosa: ‘Come ci risaneremo? Come potremo ritornare quelli di una volta? Quando?’. Gennaro intuisce e risponde con il suo tono di pronta saggezza: ‘S’ha da aspettà, Ama’. Ha da passà ‘a nuttata”.”
Ce la faremo? Come Eduardo lasciamoci una nota di speranza e assolviamo i 25 mila qui al ‘Laido’ e i milioni di italiani che attendono.
La serata sta per chiudersi. Ho cenato al Bagno Onda Blu e da lontano, quasi un sussurro, arrivava ad ondate la musica del Giovanotto cosi come con la bocca ‘a cul de poule’ dei politici che uscivano dal Senato appariva, imbarazzo, timore, dispetto e ira. ‘A nuttata sta per passare. Che accadrà? Fra due giorni ci sveglieremo giallo-rossi? O no?
Impassibili i ‘pet’ assistono alle evoluzioni degli umani. Talvolta mi piacerebbe svegliarmi col pelo. Ma è un sogno: forse triste, naturalmente irrealizzabile.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.
Da: MediaMente
Festival filosofia 2019: Persona, maneggiare con cura. Dal 13 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
Da venerdì 13 a domenica 15 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo quasi 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli, tutti dedicati al tema “persona”. Tra i protagonisti 54 relatori, di cui ben 24 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Augé, Bodei, Bianchi, Cacciari, Crouch, Ehrenberg, Galimberti, Giovannini, Marzano, Massini, Nancy, Quante, Recalcati, Rosen, Roy, Severino, Vegetti Finzi. In programma anche otto “menu filosofici” per ricordare Tullio Gregory
Dedicato al tema persona, il festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana. La diciannovesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.
Piazze e cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il pubblico sul tema “persona”, che indica una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico (come per esempio nel caso del lavoro), sia nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.
L’edizione 2019, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta ventiquattro voci nuove, su un totale di 53 relatori. Tra gli autori stranieri, due terzi sono al loro debutto al festival.
Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri, Marc Augé, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano (Lectio “Rotary Club Gruppo Ghirlandina”), Stefano Massini (Lectio “Coop Alleanza 3.0”), Jean Luc-Nancy, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Emanuele Severino, Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio.
Tra i “debuttanti”, Michel Agier, Leonardo Caffo, Colin Crouch (Lectio “Gruppo Hera”), Alain Ehrenberg, Paolo Flores d’Arcais, Enrico Giovannini (Lectio “Confindustria Emilia Area Centro”), Danilo Martuccelli, Michael Rosen (Lectio “BPER Banca”), Olivier Roy, Michael Quante.
Il programma filosofico del festival propone anche la sezione “la lezione dei classici”: esperti eminenti commenteranno i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della persona.
Se le lezioni magistrali sono il cuore della manifestazione, un vasto programma creativo (ancora in corso di definizione) coinvolgerà performance, musica e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti: David Riondino (con un concerto bandistico), Pamela Villoresi (con un recital sul tema del lavoro), Telmo Pievani e i Deproducers (con uno spettacolo sull’evoluzione di Homo sapiens), Lino Guanciale (in una conversazione con Roberto Escobar su Canetti), Chiara Valerio (in un reading da un suo testo inedito), Michele Dalai (con uno spettacolo su Gino Bartali giusto tra le nazioni), Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua (in un dialogo-spettacolo sulla chiusura degli ospedali psichiatrici), Lella Costa (in un recital su Edith Stein). Non mancheranno i mercati di libri e le iniziative per bambini e ragazzi.
Oltre trenta le mostre proposte in occasione del festival, tra cui le personali di Vittorio Guida e Luisa Menazzi Moretti prodotte da Fondazione Modena Arti Visive. A Carpi una mostra ai Musei di Palazzo dei Pio presenta incisioni di Picasso, Kirchner e Chagall sul tema della maschera, mentre a Sassuolo una personale di Mustafa Sabbagh è dedicata alla condizione dell’umano.
Prima edizione dopo la scomparsa di Tullio Gregory, il festival omaggerà la figura del grande maestro, tra l’altro, riproponendo alcuni dei più significativi tra i suoi “menu filosofici” per quasi ottanta ristoranti ed enoteche delle tre città.
Il festival è promosso dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Infoline: Consorzio per il festivalfilosofia, tel. 059/2033382 e http://www.festivalfilosofia.it
Festivalfilosofia 2019: Divenire persone
Festivalfilosofia 2019: Divenire personeNelle piazze e nei cortili del festival si discuterà di autonomia e diritti delle persone, di maschere e peculiarità del volto, di costituzione del Sé in tutte le fasi della vita e dei generi d’identità, sempre oscillanti tra io e noi
L’edizione 2019 sarà imperniata sulla parola chiave persona. In oltre 50 lezioni magistrali saranno affrontate le varie declinazioni di questo tema, una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico, sia nelle questioni della vita individuale. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.
Strutturato per gruppi di questioni, il programma filosofico porterà pertanto in primo piano un lessico concettuale a più voci dove si confronteranno prospettive filosofiche plurali e anche divergenti.
1. Genealogie della persona
La prima pista affronta alcuni degli assi concettuali e storici ancora operativi nell’uso contemporaneo di questa categoria. Tra le tracce di lunga durata significativa è quella religiosa, che risale fino alla questione della natura umana e divina, come mostrerà Enzo Bianchi. Una seconda traccia, di cui parlerà Emanuele Stolfi, rinvia al diritto romano, nel quale la summa divisio tra persone (liberi e servi) e cose costituisce uno dei perimetri originari in cui si è svolto il discorso istituzionale e morale intorno alla persona. Questo dispositivo è stato successivamente recuperato su un piano filosofico e morale, ma sempre ispirato al primato del classico, nella visione umanistica di un antropocentrismo fondato sulla «dignità dell’uomo», su cui interverrà Massimo Cacciari in una lezione dedicata alla memoria di Tullio Gregory. Più a ridosso della contemporaneità, ulteriori svolte hanno segnato la riflessione sulla persona. In ambito fenomenologico, come mostrerà Roberta de Monticelli, è emersa la questione del rapporto tra l’evidenza della soggettività, che è corporea e relazionale, e l’«individualità essenziale» in cui è racchiuso il segreto dell’irripetibile unicità di ogni persona, capace di portare la propria novità nel mondo. Sul terreno della biopolitica, per converso, la critica alla persona ha mostrato la necessità di pensarla sempre in relazione all’impersonale, ovvero al collettivo, o in altro senso all’organico, per mostrare come la consistenza del vivente (umano, ma non solo) sfugga all’astrazione giuridica e istituzionale che pare inevitabile, data la struttura della persona: ne discuterà Roberto Esposito.
Un’ulteriore soglia problematizza la questione chiamandoci a discutere lo statuto delle persone non-umane e la soggettività animale: Leonardo Caffo farà il punto sulle sfide poste alla filosofia dalla questione delle specie, mentre Luisella Battaglia indicherà come il riconoscimento dei diritti degli animali implichi una vera e propria estensione della nostra comunità. Emanuele Coccia spingerà la riflessione fino a domandarsi se non esista un “io vegetale” che accomuna i viventi.
2. Maschere e volti
Il secondo terreno di analisi riguarda il significato etimologico e, come si vedrà, iconologico, della persona, che in latino indica la maschera (in greco la parola si affermerà in epoca bizantina per indicare la persona morale del sapere giuridico e verrà tradotta con prosopon, ossia con un termine che anch’esso rinvia al significato arcaico avente a che fare col volto e l’immagine). Marc Augé, membro del Comitato scientifico del festival, ne ricostruirà la dimensione antropologica e rituale, mentre Remo Bodei, Presidente del Comitato, si soffermerà sul rapporto tra maschera e volto che emerge anche nella disciplina del ritratto. Uno speciale tipo di maschera, con le sue implicazioni culturali ed etiche, è il tema della lezione di Maria Bettetini, che discuterà il significato iconologico del velo in varie pratiche culturali e religiose. Carlo Sini, discutendo lo statuto del corpo tra soggettività e automatismo, mostrerà come il corpo che siamo possa essere la nostra prima maschera. Jean-Luc Nancy farà vedere come siano la pelle e la sua fragilità, esponendo il corpo al mondo, a costituire il nostro primo legame con esso.
3. Lessico dell’individuo
Nella terza pista tematica si farà il punto sui diversi lessici dell’individualità, della soggettività e della singolarità, per cogliere i contesti e le caratteristiche peculiari dell’idea filosofica di persona. Mentre la questione dell’individuo si pone sul piano ontologico in relazione alla totalità, facendo emergere anche il carattere illusorio delle parti rispetto al tutto dell’Essere (è la proposta di Emanuele Severino), è possibile anche rintracciare ampia evidenza di una trasformazione che l’individualità ha subito in epoca contemporanea. Come indicherà Danilo Martuccelli, gli individui contemporanei ambiscono a essere uguali solo a se stessi e incomparabili con chiunque altro. In questo processo di singolarizzazione, il cui esito paradossale è spesso il conformismo assoluto, Mauro Magatti intravede l’opportunità di ripensare un individuo che, dalla propria crisi, riscopra il valore fondante e generativo della reciprocità. La soggettività, del resto, non è un dato ma una costruzione, un complesso processo di edificazione di sé e del proprio carattere, come mostrerà Salvatore Natoli.
Ogni esistenza è d’altronde essenziale e intangibile. Ai gesti di violenza biblica che attaccano la singolarità della vita, facendone per contrasto brillare il valore, è dedicata la lezione di Massimo Recalcati.
In un contesto completamente differente, la singolarità è una caratteristica cosmologica, come nel caso dei buchi neri, dove i sistemi fisici perdono la capacità predittiva. Questo affascinante tema, che ha a che fare con le più avanzate teorie sull’origine dell’universo, verrà discusso da Mariafelicia De Laurentis e Massimo Pietroni (in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dibattito condotto da Marco Cattaneo).
A come sopravvivere nel mondo conservando la scintilla dell’umanità e con l’ausilio del racconto sarà dedicato l’intervento di Stefano Massini (Lectio Coop Alleanza 3.0).
4. Io e noi
Il tema dell’identità, che non si sovrappone a quello dell’individuo, indica una questione che dal piano individuale (non solo cognitivo, e nella nostra epoca neanche esclusivamente corporeo, ma anche digitale), si carica tuttavia anche di valenze politiche. Funzionale e costruttiva, l’identità rinvia sempre all’appartenenza, a una cultura o alla comune umanità: tutti concetti porosi e non essenzialistici, di cui provare a sondare limiti e potenzialità. Nathalie Heinich indicherà il contesto individuale di formazione dell’identità, decostruendo tutto quello che nel discorso pubblico passa per “identitario”, senza a rigore esserlo, mentre Donatella Di Cesare farà vedere come, in un mondo che non sa più pensare il fuori, l’identità valga soprattutto come cancellazione dell’alterità. Su un diverso piano, Silvia Vegetti Finzi mostrerà viceversa che essere se stessi è un’arte che si impara nel lungo passaggio tra infanzia e vita adulta.
Il transito dell’identità e della personalità dal piano individuale a quello collettivo comincia con Carlo Galli, il quale discuterà le istituzioni pubbliche per evidenziare come la politica si fondi su figure che implicano una soggettività generale, mentre Colin Crouch (nella Lectio Gruppo Hera) affronterà il tema dell’appartenenza e dell’identità collettiva tra globalizzazione e rinascita delle nazioni. Al tema dell’identità culturale – e in particolare alla questione dei valori europei nel loro rapporto con le radici religiose del cristianesimo – sarà invece dedicata la lezione di Olivier Roy.
C’è un campo tutto nuovo nel quale il crinale tra privato e pubblico, identità individuale e immersione nella “community”, viene articolato in forme spesso senza precedenti: è quello del web e dell’identità digitale cui non sfugge ormai gran parte delle persone. Paolo Ercolani ne misurerà limiti e potenzialità – tra soggettività social e perdita di realtà – mentre Davide Sisto mapperà un fenomeno di grande portata antropologica, ossia quello della sopravvivenza digitale (negli account social delle persone decedute e nelle tracce dei propri dati), per cui si profila un vero e proprio nuovo rapporto tra i vivi e i morti.
5. Sé come altro
La quinta pista ruota attorno alla costituzione psichica del Sé e alle prove cui è sottoposto. Umberto Galimberti si chiederà se ciascuno, preso come persona, sia uno o molti, mentre Alain Ehrenberg farà il punto sull’individuo contemporaneo interrogandosi sul rapporto tra la meccanica delle passioni oggetto delle neuroscienze e le patologie da cui è affetto il soggetto in una società ad elevato livello di prestazione. Focalizzandosi sul caso dell’autismo, Marco Francesconi ne prenderà spunto per segnalare che la “mente pieghevole” è caratteristica di ogni persona, mentre Massimo De Carolis, indicando come ogni identità riposi sull’imperfezione, mostrerà come la personalità sia sempre una costruzione politica.
L’essere se stessi si dipana tra la vita e la morte, ponendo questioni “bioetiche” che si possono filosoficamente racchiudere nella formula della “memoria del Sé”, come quando si pone la domanda su cosa resti di noi di fronte a malattie che sembrano cancellare memorie e personalità (ne parlerà Michela Marzano nella Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina): è in gioco, lo sosterrà Michael Quante, l’idea fondamentale dell’autonomia personale. Delicato e dilemmatico è il momento del fine vita, in cui traspaiono le esigenze di restare sovrani della propria vita (ne parlerà Paolo Flores D’Arcais) e di salvaguardare la vita con la cura fino all’estremo (su cui interverrà Vincenzo Paglia).
6. Diritti delle persone
Si giunge infine nella sesta pista all’idea della persona come fondamento di autonomia morale e dei diritti. Mediatrice tra uomo/donna e cittadino/cittadina, la categoria di persona è il perno dell’idea contemporanea dei diritti umani, ossia del set di tutele giuridiche che spetta a chiunque, indipendentemente dalla sovranità degli Stati e dall’idea di cittadinanza. Frutto, come si è visto, di una lunga genealogia, questo tema ha anch’esso una premessa classica: mentre Ivano Dionigi mostrerà le politiche di inclusione romane e la loro attualità, Maurizio Bettini ricostruirà il significato classico dell’idea di “ius humanum”, con le analogie e le differenze rispetto al concetto di diritti umani.
Una delle virtù essenziali che si attribuiscono alla persona è quella della dignità, sul cui principio interverrà Michael Rosen nella Lectio BPER Banca. Gustavo Zagrebelsky, in prospettiva analoga, indicherà che la prima forma di riconoscimento, nonché la prima tutela giuridica, sta nel “diritto di avere diritti”.
Uguaglianza di fronte alla legge e differenza delle culture saranno il tema della lezione di Michel Agier, che ci ricorderà come tutti siamo sottoposti all’essere stranieri, mentre Roberto Mancini si soffermerà sull’importanza di riconoscere dignità e solidarietà alle persone nei processi economici. Sempre in chiave economica e sociale, Enrico Giovannini si interrogherà sul ruolo delle persone e sul destino dei posti di lavoro nella quarta rivoluzione industriale (Lectio Confindustria Emilia Area Centro), mentre Chiara Saraceno affronterà la doppia e intrecciata disuguaglianza che riguarda disparità di genere e mercato del lavoro, con i costi umani e sociali che essa comporta. Sempre muovendosi entro una questione di genere, Elena Pulcini indicherà come la vulnerabilità, presa come condizione esemplare dell’epoca contemporanea, possa divenire una risorsa per chi voglia praticare la responsabilità e la cura del mondo.
7. La lezione dei Classici
Completerà come di consueto il programma filosofico la sezione “Lezione dei classici”: grandi interpreti del pensiero filosofico presentano le opere che hanno maggiormente segnato la riflessione sul tema “persona”.
Giuseppe Cambiano presenterà la “Politica” di Aristotele per risalire, nella discussione della polis e del ruolo degli schiavi, a una delle prime dicotomie tra persone e cose. Fabrizio Amerini si dedicherà alla “Summa teologica” di Tommaso d’Aquino per commentare un’influente teoria della persona, tra teologia trinitaria e antropologia.
Venendo alla prima età moderna, Nicola Panichi commenterà i “Saggi” di Montaigne, vero e proprio spartiacque nella visione della soggettività e dell’autobiografia. Discutendo “Per la pace perpetua” di Kant, Massimo Mori mostrerà i dilemmi del diritto cosmopolitico tra diritto di migrazione e politiche di ospitalità, mentre Angelo Panebianco, con una lezione su “La democrazia in America” di Tocqueville, analizzerà la prima compiuta versione dell’individualismo.
Più a ridosso del contemporaneo, Remo Bodei si focalizzerà sull’idea multipla di persona che emerge in “Uno, nessuno e centomila” e più in generale nell’intera opera di Pirandello.
Con una lezione su “Totalità e infinito” di Lévinas, Silvano Petrosino ricostruirà una delle proposte filosofiche più cruciali nell’attuale dibattito su empatia, riconoscimento, centralità del volto per la morale e il rapporto all’altro, mentre Laura Boella guiderà il pubblico alla scoperta di “La persona e il sacro” di Simone Weil, un testo nel quale cura per gli altri e aspirazione alla trascendenza si gemellano.
Con una lezione su “Sé come altro” di Paul Ricoeur, infine, Francesca Brezzi ripercorrerà alcuni concetti chiave di uno dei più significativi autori della filosofia dopo il personalismo.
Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e personaggi
Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e
personaggiUn nutrito programma di eventi, tutti gratuiti, affiancherà le lezioni magistrali del festivalfilosofia dal 13 al 15 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
1. Genealogie della persona
Modelli e soglie dell’umano raccontano ed esibiscono la storia della civiltà e le frontiere della persona
Alla radice della nostra civiltà sta il dilemma se adottare le leggi del cosmo o le leggi dell’io. Nel dialogo immaginario tra Lucrezio e Seneca “Quando la vita ti viene a trovare”, venerdì 13 alle ore 22 presso il Teatro Storchi a Modena, il latinista Ivano Dionigi fa incontrare due personaggi con visioni rivali del mondo, icone della bigamia del nostro pensiero e della nostra anima (produzione: Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con: Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival). La mostra di Vittorio Guida “Where Are We Now? Volumi I e II”, presso la Palazzina dei Giardini a Modena, racconta viceversa un futuro già fattosi presente, in una efficace sintesi di primitivo e digitale, interrogandosi su ciò che siamo oggi o, meglio, su “dove” siamo oggi (produzione: Fondazione Modena Arti Visive). A Sassuolo, i maestri ceramisti Bertozzi & Casoni, nel Museo loro dedicato, celebrano e rivisitano, con la mostra “Ritratto”, l’ambiguità di un’opera canonica come il volto di Mademoiselle Rivière di Ingres (1805) con una inedita versione scultorea, dove il volto femminile risulta sostituito da quello di una giovane gorilla (produzione: Museo Bertozzi & Casoni, presentazione: venerdì 13 alle ore 17 con un intervento di David Riondino).
Seguendo lo statuto del corpo e il suo rapporto con l’identità personale, la mostra “Prosopon” ripercorre lavori di Hermann Nitsch sulle forme e gli organi: il Teatro Anatomico di Modena che la ospita si riappropria così della sua natura celebrativa sull’indagine del corpo (curatori: Elena Corradini, Francesco Silvestri, Tiberio Cattelani, produzione: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, con: Archivio Cattelani, Ago Modena Fabbriche Culturali, presentazione: venerdì 13 ore 19.30). Presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, la mostra “Leggere il corpo. Illustrazioni anatomiche tra Cinquecento e Seicento” segue l’evoluzione scientifica e iconografica della rappresentazione del corpo umano dalle tavole anatomiche di Berengario da Carpi ai trattati e alle tavole xilografiche e calcografiche di incisori dei secoli XV-XVII (curatrice: Milena Ricci, a cura di: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena).
Grazie a brani musicali inediti, a immagini suggestive e a una scenografia costruita ad hoc, una conferenza scientifica diventa un’esperienza immersiva alla portata di tutti. Con Telmo Pievani e Deproducers in “DNA” il pubblico avrà l’occasione di ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo Sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica, attraverso uno spettacolo appassionante che sottolinea il valore della ricerca scientifica sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di se stessi attraverso la conoscenza (Carpi, Piazza Martiri, venerdì 13 ore 22).
Corpo non è solo quello degli animali umani ma anche quello dei non umani, con le relative differenziazioni: “L’attrazione fatale degli animali” consentirà di evidenziare come molti animali sviluppino differenze per attrarre l’altro sesso (Modena, Museo di Zoologia, curatori: Elena Corradini, Ivano Ansaloni, Andrea Gambarelli, a cura di: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, presentazione: venerdì 13 ore 17.30). Nei dipinti di Riccardo Sghedoni, veri e propri ritratti di specie, si mostrerà viceversa che razza di razza siamo: “Umani e altri animali” (Modena, Riccardo Sghedoni Art Factory).
Sulla soglia tra umano e artificiale, lo spettacolo “Creature” vedrà protagonisti giovani attori e studenti delle scuole di Modena e Sassuolo, già impegnati nel Progetto Clip del festivalfilosofia, con la messa in scena di un viaggio nel capolavoro di Mary Shelley “Frankenstein” (Complesso San Filippo Neri di Modena, a cura di: STED, con il coordinamento di Tony Contartese, Marco Marzaioli, Marina Meinero, produzione: festivalfilosofia, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 16).
La fabbricazione dell’umano è al cuore anche della mostra di Metronom a Modena, “Antropotecniche”, che presenta il lavoro di cinque artisti, Bundurakis, Christto & Andrew, Desaubliaux, Kard, Schiesari, i quali si confrontano con la rappresentazione e la costruzione di corpo e figura, tra umano e postumano, per mezzo di fotografia, sculture digitali, stampa 3D (curatrice: Marcella Manni, produzione: Metronom).
Venerdì 13 alle ore 22, sulla falsariga del noto autore di fantascienza Isaac Asimov, Sandra Tassi propone nel reading de Il Leggio il divenire persona di un automa “difettoso”, fino alla accettazione libera e volontaria della propria morte, condizione ultima e necessaria per una vita autentica: “Il sogno di una vita. Legittimi desideri di un robot” (Modena, Palazzo Santa Margherita – Chiostro, a cura di: Associazione culturale “Il Leggio”).
Nuove soglie dell’umano, dall’Homo Sapiens all’Intelligenza Artificiale, sono misurate nel gioco a quiz “Anthropos o Androide? Sfida te stesso e scopri quanta Intelligenza Artificiale è in te!”, che misura il livello di “evoluzione digitale” (a cura di: Ufficio Comunicazione del Comune di Modena e Palestra digitale – MakeitModena, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, Piazza Grande – Ufficio Relazioni con il Pubblico, venerdì 13 ore 17-21, sabato 14 ore 17-21). L’Intelligenza Artificiale non esiste. A partire da questa provocazione, Energy Way cura e propone un percorso laboratoriale attraverso i differenti stadi di programmazione di una rete neurale, per mostrare quanto l’Intelligenza Artificiale sia, in realtà, profondamente umana: “Educare a pensare” (Modena, Via Sant’Orsola, 33; sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-13; 15-18). Andrea Lazzarini e Andrea Zanni propongono in “Umani e digitali” una conversazione tra studiosi, esperti di informatica umanistica e il pubblico stesso sull’opera “Della pubblica felicità” di L.A. Muratori, svolgendo una sessione interattiva sull’annotazione collaborativa degli archivi digitali grazie all’uso delle tecnologie digital humanities (Ago Modena Fabbriche Culturali – Future Education Modena, a cura di: Gallerie Estensi con Ago, Centro DHMORE e Ati Extense, max. 25 partecipanti, sabato 14 ore 15; 16.30).
Collegata alla conversazione “Umani e digitali”, la mostra “Gigapixels!!” permette di scoprire l’affascinante processo che dall’oggetto fisico porta alla creazione di surrogati digitali ad altissima definizione, a partire dalla celebre collezione di mappe della Biblioteca Estense (Modena, Palazzo dei Musei – Biblioteca Estense, curatore: Luca Panini, a cura di: Gallerie Estensi, Franco Cosimo Panini).
I benefici della tecnologia sulle persone, con la lunga storia di innovazione di Olivetti, sono invece presentati nella mostra “Una storia di innovazione” (AGO Modena Fabbriche Culturali, a cura di: Olivetti S.p.A., in collaborazione con: Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Area Centro).
Al Crogiolo Marazzi di Sassuolo, la selezione di “Non è l’Ennesimo festivalfilosofia” (a cura di: Tilt Associazione Giovanile – Ennesimo Film Festival, sabato 14 alle ore 21) indaga la persona immersa nella contemporaneità sotto diversi aspetti: nel campo sociale, lavorativo, nell’affermazione del sé all’interno della società o della propria comunità, nel bisogno di emergere e in quelle che sono le più comuni azioni dell’essere umano.
2. Maschere e volti
Nel volto e nel ritratto è inciso il carattere delle persone, in un continuo gioco di finzione e rappresentazione
Lo statuto rituale e iconografico della maschera, con l’influenza che i manufatti provenienti dal mondo africano e australe hanno esercitato sull’arte contemporanea, è ricostruito nella mostra “Personae”, nell’ambito della XIX Biennale di Xilografia contemporanea di Carpi, in cui si propongono una cinquantina di incisioni realizzate da Picasso, Kirchner, Chagall (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio, curatori: Manuela Rossi, Enzo Di Martino, produzione: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dei curatori). Farà da cornice alla mostra lo spettacolo itinerante e installativo “Volti di polvere”, sul tema del doppio della persona e sulla maschera quale oggetto in relazione simbolica con l’aldilà (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio e Archivio Storico Comunale, a cura di: Musei di Palazzo dei Pio, Teatro Comunale di Carpi, Archivio Storico Comunale; venerdì 13 ore 20, 21, 22; sabato 14 ore 21, 22; domenica 15 ore 18, 19). Sempre presso Palazzo dei Pio, l’esposizione “Personalità della materia” raccoglie capi, art book e trend book realizzati dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano, provenienti da diverse realtà geografiche, allo scopo di tradurre la materia in espressione della personalità, servendosi del vestiario come interfaccia tra singole individualità e collettività (a cura di: Scuola Postgraduate di IED Milano, con: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza degli organizzatori).
A Modena, invece, la mostra di Tommaso Mori “R-Nord”, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, presenta ritratti fotografici di oltre 200 abitanti di un quartiere della città di Modena, con articoli, documenti, progetti architettonici e urbanistici originali (AGO Modena Fabbriche Culturali – Chiesa di San Nicolò, curatore: Matteo Balduzzi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Con “Cantiere permanente. La messa in scena del sé” Fondazione Modena Arti Visive avvia un progetto a lungo termine volto a valorizzare le collezioni di fotografia, grafica e disegno di Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a cui verranno in futuro dedicate alcune sale in modo permanente. Il tema “Persona” è il primo episodio in questa direzione: un’indagine su come gli artisti abbiano affrontato la soggettività e la messa in scena del sé, in un allestimento sperimentale in continuo divenire (Palazzo Santa Margherita – Galleria Civica, curatori: Chiara Dall’Olio, Daniele De Luigi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Al MATA – Ex Manifattura Tabacchi, Luisa Menazzi Moretti, con “Solo”, a produzione Fondazione Modena Arti Visive, propone scatti su volti e persone smarrite, ignare sul da farsi. Sempre a produzione Fondazione Modena Arti Visive, il laboratorio “I Wanna Dance with Somebody. Set fotografico aperto a tutti” crea un’atmosfera di musica e colori, un fondale e tanti accessori per ideare il proprio personalissimo look e portarsi a casa un ritratto fotografico in stile anni Ottanta (sabato 14 ore 20-23, domenica 15 ore 15-19). I fili comuni del progetti proposti da Fondazione Modena Arti Visive sono discussi nella conversazione “In sé fuori di sé”: Vittorio Guida, Luisa Menazzi Moretti, Tommaso Mori affrontano i concetti di identità e alterità, di individuo e gruppo, di essere e apparire, attraverso le loro opere più significative (Palazzo Santa Margherita – Chiostro, conduce: Daniele Pittèri, a cura di: Fondazione Modena Arti Visive, sabato 14 ore 22.30).
Presso i Musei Civici di Palazzo dei Musei a Modena, sono allestite due esposizioni. La prima, “Faccia a faccia con la mummia”, con le avanzate tecnologie digitali del designer 3D Cicero Moraes, è dedicata a un’ipotesi di ricostruzione del volto della mummia di bambino esposta nella mostra “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico di Modena” (curatrice Cristiana Zanasi, a cura di: Musei Civici, presentazione: venerdì 13 ore 17.30). La seconda testimonia il percorso artistico di Oscar Sorgato, pittore di origini modenesi e protagonista del movimento del Chiarismo; in “Tenera è la luce”, i suoi paesaggi e i suoi ritratti ci restituiscono uno spaccato sociale della Milano degli anni Trenta, con una particolare attenzione alla condizione femminile. Alcune delle figure ritratte saranno animate dai racconti sonori composti per l’occasione dagli scrittori Andrea Vitali e Roberto Barbolini (curatori: Stefano Sbarbaro, Cristina Stefani, a cura di: Musei Civici, Collezione Koelliker di Milano, presentazione: venerdì 13 ore 18). A trarre ispirazione dalla mostra è anche il laboratorio “Così ti dipingo”, che permetterà a bambini e famiglie di servirsi di un’autentica sala di posa (Palazzo dei Musei, a cura di: Dida – laboratorio didattico, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-19). Sempre a cura del Dida, in collaborazione con il Teatro dell’Orsa, lo spettacolo “L’acciarino magico sono io”, con Bernardino Bonzani, porterà in scena una delle più belle fiabe di Andersen, in cui l’autore si è immedesimato nel protagonista (Palazzo dei Musei – Dida – laboratorio didattico, venerdì 13 ore 21).
Presso la Galleria Estense, con “Personart. Alla ricerca del tuo sosia in Galleria!”, tramite un software elaborato dal Dipartimento di Ingegneria di Modena allestito nella sala 21 della Galleria, si propone ai visitatori di partecipare ed interagire con l’installazione, per poi addentrarsi nel percorso museale alla ricerca dei “personaggi” che il software avrà identificato come più simili al loro volto (curatrice: Martina Bagnoli, a cura di: Gallerie Estensi, AlmageLab – Unimore, presentazione: venerdì 13 ore 11 alla presenza di Martina Bagnoli e Rita Cucchiara).
Sempre attorno al ritratto ruota l’esposizione che propone opere della Collezione e Archivio storico di BPER Banca, in un percorso che ne mostra la caratteristica di immagine parlante sospesa tra verità e illusione, tra somiglianza e idealizzazione, tra mimesi e introspezione: “Protagonisti in posa. Il ritratto tra Rinascimento e Barocco” (Modena, produzione: La Galleria. Collezione e Archivio Storico BPER Banca, curatrice: Lucia Peruzzi, Presentazione: venerdì 13 settembre ore 16:00 alla presenza della curatrice).
La visita “Un ritratto collettivo. Storie e volti da Collegio dei Nobili a Fondazione San Carlo” illustrerà uno dei luoghi più suggestivi della Modena Barocca e presenterà i giovani nobili che furono allievi dell’antico Collegio San Carlo, futura classe dirigente tra il XVII e il XIX secolo (Fondazione Collegio San Carlo, conduce: Patrizia Curti, a cura di: Fondazione Collegio San Carlo, 45’, max. 30 partecipanti, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ore 19.30).
Sabato 14 alle ore 21 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti si mette in scena la realizzazione di una celebre scena lirica, tratta dal Don Giovanni di Mozart, in cui il tema dello scambio di persona apre le porte ad una riflessione su quello dell’ambiguità della “maschera”: “Lo scambio di persona”, a cura di Modena Città del Belcanto. Tra maschere ed enigmi, le persone del Carnaval di Schumann sono invece oggetto dello spettacolo-concerto “Ritratti fantastici”, con video coreografie dei personaggi che attraversano la partitura, proiettate presso il Teatro San Carlo domenica 15 alle ore 20.30 (a cura di: Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – Sede di Modena).
Altri ritratti, dell’umanità più varia – commesse, negozianti, studenti, medici, viaggiatori, operai e anziani – sono quelli dei quadri di Clara Malavasi in “Anime per strada” (Modena, Redecocca Art Gallery, curatori: Giuliano Della Casa, Teresa, Mariangela, Stefano e Giovanna Righi Riva, presentazione: venerdì 13 ore 17 alla presenza dei curatori).
Le opere di Flavio Pellegrini, in “Diario degli umori”, sono volti, aperti al confronto, di persone pronte ad indossare la maschera che la situazione richiama attingendo dal “personale” sedimento di esperienza (Modena, Studio d’Arte La Darsena, curatori: Angela Balestri e Siro Leonelli, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Infrangendo la barriera tra finzione e realtà, lo spettacolo “Da persona a persona” conduce il pubblico a reagire fisicamente e mentalmente a episodi della vita reale, con il teatro Forum che mette in scena dei quadri in cui ciascuno è chiamato a interpretare le forme e i rituali dell’interazione quotidiana (Modena, Palazzina Quartiere 1; con Margherita Salati, a cura di: Coordinamento delle Banche del Tempo della provincia di Modena e Reggio Emilia, con DES Modena, sabato 14 ore 15.30-18.30, domenica 15 ore 9.30-12.30).
“Ritratto scomposto” è una performance fotografica in cui l’artista Ivana Galli dedica a ogni singolo soggetto una sessione individuale di 15 minuti, penetrando l’identità degli individui che ritrae per svelarla a loro stessi (Modena, Bottega Consorzio Creativo, a cura di: Consorzio Creativo, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza dell’artista).
Nell’operare pittorico di Silvia Paci, in “Senza maschera levare”, i suoi lavori si presentano attraverso personificazioni ibride, modello vivente delle diverse personalità che vivono nell’essere (Modena, ArtEkyp Open Studio, produzione: ArtEkyp Open Studio, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza dell’artista e dei curatori).
Le opere di Marco Lombardo ed Ersilia Sarrecchia, in “Effetti personali”, hanno come matrice comune il ritratto fotografico, raccontando i personaggi attraverso l’immagine scaturita dal rapporto e dall’incontro tra artista e soggetto (Modena, Rana Rossa 3.0, curatrice: Silvia Petronici, a cura di: Rana Rossa 3.0, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza degli artisti).
La rassegna cinematografica “Portraits”, curata da Alberto Morsiani al Filmstudio 7B di Modena, presenta storie di ordinaria anormalità, con ritratti filmati di esseri umani considerati in sé o nelle loro funzioni sociali, alle prese con differenze di etnia, sesso, età, cultura. Ritratti di persone comuni però eccezionali, come il Memmo, garzone di bottega poi testimone di personaggi ed epoche irripetibili, in “Il venditore di colori” di Daniele Costantini (Ita/Svi 2019, 62′), venerdì 13 ore 19.30, o come i due adolescenti perduti del tremendo Rione Traiano di Napoli, che grazie a uno smartphone escono per qualche tempo da una “normalità” di morti e droga in “Selfie” di Agostino Ferrente (Fra/Ita 2019, 78′), venerdì 13 ore 17,50. O come gli abitanti neri di New Orleans, che cercano, anch’essi, di sfangarla col mestiere duro del vivere, in “Che fare quando il mondo è in fiamme?” di Roberto Minervini (Ita/Usa/Fra 2018, 123′, v.o. con sottotitoli), sabato 14 ore 17.10, o come un transessuale filippino ramingo per il mondo in cerca di accoglienza, in “Shelter – Addio all’Eden” di Enrico Masi (Ita/Fra 2019, 81′), domenica 15 ore 16.20, o come, infine, gli italiani qualunque di “Normal” di Adele Tulli (Ita/Sve 2018, 70′), impietosa radiografia di una esistenza conformista, domenica 15 ore 18. Ritratti, però, anche di persone eccezionali, come un tetro monaco buddista birmano, che purtroppo diventano normali quando riescono, con la loro influenza, a rendere “normale” l’intolleranza e la violenza sugli altri: “Il venerabile W.” di Barbet Schroeder (Fra/Svi 2018, 100′, v.o. con sottotitoli), sabato 14 ore 19.30.
Tutti i filosofi protagonisti della 19° edizione di festivalfilosofia sono ritratti a penna su carta da Giuliano Guatta in “Fisiognomica del pensiero” (Modena, D406 presso Studio fotografico Rolando Paolo Guerzoni, a cura di: Galleria D406, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza dell’artista). Contrapposta a questa parte di “ritrattistica ufficiale”, l’autore ha inoltre realizzato dei ritratti/autoritratti, dedicati ai maggiori pensatori del secolo scorso.
Domenica 15 alle ore 19.30 il Teatro dei Venti organizza “Malaparata”, una sfilata itinerante per le vie del centro di Modena, un’allegoria dei vizi dell’uomo che utilizza la musica, le maschere, i trampoli e gli strumenti del teatro di strada, affrontando il tema del diverso, incarnato da un Pulcinella in gabbia senza maschera.
3. Lessico dell’individuo
Messe in scena, racconti e mostre ruotano attorno a nomi propri e discendenze familiari, identità e riti di riconoscimento
Dormono, dormono sulla collina… I protagonisti degli epitaffi tombali dell’Antologia di Spoon River tornano a nuova vita con David Riondino in “Non al denaro, non all’amore né al cielo di Fabrizio De André”, omaggio d’autore all’album omonimo (1971) del cantautore ligure (Modena, Piazza Roma, a cura di: Biblioteca civica Antonio Delfini, venerdì 13 ore 21).
Sulle tracce dei nomi propri che nei secoli hanno caratterizzato gli abitanti della comunità modenese, la mostra “Nomen omen. Le carte delle identità” propone un suggestivo percorso attraverso carte e documenti conservati all’Archivio Storico del Comune di Modena, alla ricerca della nostra identità, solida ma talvolta fragile, di persone e di cittadini (Palazzo dei Musei – Archivio Storico, curatori: Gabriella Roganti, Giuseppe Bertoni, a cura di: Archivio Storico del Comune di Modena, presentazione: venerdì 13 ore 18.30). Punteggiano la mostra i racconti dal vivo, il serio e l’ironico, dello scrittore modenese Ugo Cornia: in “Scutmai. Nomi, nomignoli e altre umanità” ispirandosi ai documenti d’archivio presentati nella mostra, intreccia elementi autobiografici ad esilaranti aneddoti su nomi e soprannomi di famigliari, antiche origini e improbabili discendenze (Palazzo dei Musei – Archivio Storico, a cura di: Archivio Storico del Comune di Modena, sabato 14 ore 18; 18.45; 19.30). Sui registri canonici, traccia dei movimenti migratori, e in particolare sui registri dei battezzati di diverse epoche e di diverse località, si incentra la mostra “Battesimo” (Archivio storico diocesano di Modena – Nonantola, curatrici: Federica Collorafi, Laura Farina, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Cosa accade quando sulla terra irrompe una persona che traccia una scia indelebile, quasi fosse una meteora? “Polvere di stelle” racconta, con le performance di quattro attori, le vite di David Bowie, Margherita Hack, Amy Winehouse e Domenico Troili (Museo Universitario GEMMA, a cura di: Pensieri Acrobati, in collaborazione con: Museo Universitario GEMMA).
Il percorso guidato e breve laboratorio “Chiamami col mio nome” conduce 20 persone per ogni turno (prenotazione consigliata) a conoscere “personalmente” e dare nome alla flora urbica presente nelle strade del centro storico di Modena (Palazzo Universitario – piano terra, a cura e conduzione di: G. Bosi, G. Barbieri, F. Buldrini, P. Torri, produzione: Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia, venerdì 13 ore 15.30; 17; sabato 14 ore 10; 11.30; 15.30; 17; domenica 15 ore 10; 11.30; 15.30; 17).
Sempre dedicato all’importanza dei nomi è il dialogo tra pittura e narrazione, per grandi e piccini, “Tarantolin rabbioso. Una storia per filo e per segno”: bambini da 3 anni in su sono coinvolti nella ricerca di un nome, attraverso la nota fiaba dei fratelli Grimm (Modena, Palazzo Santa Margherita – Biblioteca Delfini, a cura di: Biblioteca Civica Antonio Delfini, con: Sassolini Tracce di Fiaba, domenica 15 ore 17, 45′). Sabato 14 alle ore 17, il laboratorio di pittura e collage “Il mio nome, il nome mio…” si ispira alla stessa fiaba per creare sperimentazioni con la pittura e le lettere del nome di bambini tra i 6 e i 9 anni (Palazzo Santa Margherita – Biblioteca Delfini, a cura di: Biblioteca Civica Antonio Delfini, con: Sassolini Tracce di Fiaba, 25 posti dal 2 settembre, previa iscrizione).
Le sculture fatte esplodere dall’artista Matteo Mezzadri nel suo studio e ritratte nel preciso momento della loro distruzione, in “L’opera e la polvere”, rievocano i tragici episodi della cronaca recente, tuttavia quelle stesse opere non scompaiono nel nulla, ma al contrario riaffermano la loro presenza, la loro stessa essenza (Modena, ROPE Contemporary Art Gallery, curatrice: Federica Petricca, produzione: ROPE Contemporary Art Gallery, presentazione: sabato 14 ore 17 alla presenza dell’artista e della curatrice).
Seguendo un processo chimico, Tommaso Mori, in “Aeterna (2019)”, genera luce a partire da una goccia del proprio sangue, del proprio io, unico e irripetibile, creando un’installazione site-specific evocativa e immersiva a testimonianza della potenzialità generativa di ogni essere umano (Modena, GATE 26A, a cura di: GATE 26A, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza dell’artista). In un gioco didattico sulla conoscenza della storia, i partecipanti del laboratorio “Memorie dei nomi” dovranno scoprire un particolare importante – un fatto, una data, un’identità – a partire da una “pietra della memoria”, una delle stele o monumento commemorativo di eventi del 900 (Modena, Casa del Mutilato, a cura di: Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra – sezione di Modena, presentazione: sabato 14 ore 18.30 con letture di Andrea Ferrari, venerdì 13 ore 17-20, sabato 14 ore 10-13; 17-20; domenica 15 ore 10-13).
Tra fotografia, scultura e video, facce malate, ferite identitarie e reliquiari post-umani rappresentano il Grado Zero che “Mustafa Sabbagh” in “MKUltra: personal data” rintraccia e cataloga per la cultura (Sassuolo, Galleria Paggeriarte, produzione: Comune di Sassuolo e festivalfilosofia, in collaborazione con: Galleria Marcolini, presentazione: sabato 14 ore 18.30 alla presenza dell’artista).
4. Io e noi
Singolare e collettivo, privato e pubblico, orizzontale e verticale vengono attraversati da prospettive creative
Una sorprendente accoppiata, quella tra il filosofo e critico cinematografico Roberto Escobar e l’attore Lino Guanciale, introdotti da Claudio Longhi, conversa attorno a Massa e potere di Elias Canetti per discutere le implicazioni di un pensiero che ha fatto del confine tra io e noi uno sterminato campo d’indagine: “Massa e individuo. Canetti oggi tra filosofia e teatro” (Modena, Piazza Roma, a cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione, sabato 14 ore 22.30).
Al rapporto tra individui e comunità è dedicata anche “VIXI. Persone e personaggi al trapasso dalla vita alla morte”, che valorizza il patrimonio dell’Archivio storico di Carpi mostrando come cerimoniali e tradizioni della ritualità funebre pubblica vengano interiorizzati e vissuti nella dimensione privata delle persone comuni, poste di fronte all’evento ultimo che caratterizza la fragilità umana (Carpi, Archivio Storico Comunale, a cura di: Archivio Storico Comunale e Centro Etnografico di Carpi, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Un diverso slittamento tra privato e pubblico è quello della “mostra-esperienza” “L’importanza di chiamarsi Francesco” condurrà i visitatori del Palazzo Ducale di Sassuolo in un viaggio attraverso le personalità di tre duchi, Francesco I, Francesco II e Francesco III d’Este (1698-1780), ricorrendo a un sussidio immersivo tramite la proiezione di una rappresentazione simil-ologramma che metterà in scena un dialogo immaginario e impossibile fra i tre (curatori: Angela Fiore, Federico Fischetti, Simone Sirocchi, produzione: Gallerie Estensi, Unimore, presentazione: venerdì ore 18.30 alla presenza della Direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli e dei curatori).
Analogamente, con la mostra “Illustrissimo Principe et Excellentissimo Signore” si ripercorrono, attraverso i documenti conservati dall’Archivio di Stato di Modena, le diverse fasi di costruzione, legittimazione e celebrazione del potere ducale estense, dalla “persona ficta” o persona pubblica, all’individuo (a cura di: Maria Carfì, Lorenza Iannacci, Miles Nerini, Riccardo Pallotti e Annalisa Sabattini, con il coordinamento di: Patrizia Cremonini, produzione: MIBAC – Archivio di Stato di Modena, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza dei curatori, con visita guidata a cura di Paolo Cova). Correda la mostra il laboratorio “Di proprio pugno. Scrittura e personalità della firma” (con: Giorgia Filossi, a cura di: MIBAC – Archivio di Stato di Modena, domenica 15 ore 16-18).
“Nella mente di chi guarda. Memoria, dignità e identità del quotidiano” è un’esposizione collettiva che riunisce artisti di rilevanza internazionale e artisti emergenti, che attraverso linguaggi diversi raccontano l’umano e il corpo, tra storie religiose e quotidiane, valorizzando l’arte come simbolo della responsabilità verso il prossimo, della tensione all’altro e dell’educazione alla diversità, forza motrice nel dialogo tra le persone (Modena, Chiesa di San Giovanni Battista, curatori: Marco M. Coltellacci, Laura Solieri, Alessandro Mescoli, coordinamento: Federica Sala, Andrea Barillaro, Massimiliano Piccinini, Sergio Bianchi, contributi critici di: Ilaria Dall’Olio ed Enrico Turchi, produzione: Arcidiocesi di Modena – Nonantola, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza degli artisti e dei curatori, con performance di Karin Dolin alle ore 18.30 e dei Multispilla alle 19.30). Nella mostra dei Musei del Duomo di Modena “Corpi celesti. Reliquiari antichi e preziosi tra cielo e terra” sono esposti circa 40 reliquiari che conservano i resti mortali di persone considerate sante in virtù dei loro meriti (curatrici: Giovanna Caselgrandi, Francesca Fontana e Diana Marchi, a cura di: Musei del Duomo, presentazione: venerdì 13 ore 16.30 alla presenza delle curatrici).
L’angelo che si fa uomo è la figura centrale e iconica di intercessione celeste, presente in tutte le religioni, ed è il soggetto dell’artista Fabrizio Loschi, in “Aladiterra. L’alba di un contratto”, presso Mazzini 43 a Sassuolo (curatori: Elena Bernardi, Francesco Raffaele Mutti, a cura di: Whiteside, Discromie, Amoof Consulting, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza dell’artista). Sempre a Sassuolo, i laboratori “Sono perché siamo” mettono a disposizione spazi a misura di famiglie dove grandi e piccoli (0-14 anni), attraverso giochi e attività pratiche, sperimentano l’essere persona, nella relazione con sé, l’altro, la memoria (Villa Giacobazzi – Parco Vistarino, a cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo, sabato 14 ore 9.30-12.30; 15-19; domenica 15 ore 9.30-12.30; 15-19).
Se tra io e noi vi è connessione, è anche perché i singoli raccontano la propria identità e l’appartenenza culturale sulla propria pelle. Cinque progetti fotografici, di Castelli, De Filippo, Federzoni, Rossi, Ravera, raccontano i “Segni distintivi” che concorrono alla personalizzazione del Sé, presso il Centro Culturale G. Alberione di Modena (curatore: Gianni Rossi, a cura di: Fotoclub Colibrì BFI, presentazione: venerdì 13 ore 17.30 alla presenza degli artisti).
5. Sé come altro
La differenza che siamo, il nuovo che vogliamo diventare, la scoperta di emozioni che non conoscevamo
Sabato 14 alle ore 22, Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua raccontano in “Tra parentesi” la vera storia di un’impensabile liberazione, con la chiusura degli ospedali psichiatrici frutto dell’opera di un ampio movimento sociale, il cui leader fu Franco Basaglia. Attraverso le tante storie minime di uomini e di donne che l’internamento lo hanno vissuto sulla propria pelle si delinea una storia che non è finita e che non potrà mai finire (Sassuolo, Piazza Garibaldi).
Siamo esseri le cui funzioni vitali sono concentrate in organi involontari, viviamo se il cuore batte. Ma a cosa serve il cuore e che rapporto c’è tra cuore, persona e memoria? Chiara Valerio, in “A questo serve il cuore”, mette in scena un racconto che, dalla mitologia greca, dalla letteratura e dai cartoni animati arriva al diritto (Modena, Piazza Roma, sabato 14 ore 21).
Sulle musiche di “Schubert”, con Marco Sgarbi, Federico Nicoletta, Diana Hobel, voce recitante, testo e pianoforte si alternano e si accompagnano per raccontarci la sua vita doppiamente outsider: omosessuale e artista non (ancora) affermato, Schubert vive in un limbo, quale “non persona” costretta dietro a una maschera, una narrazione, un’identità che non gli corrisponde appieno (Modena, Teatro San Carlo, produzione: Amici della Musica Modena, venerdì 13 ore 21).
Nel percorso “Expand yourself”, otto installazioni interattive, basate su evidenze pedagogiche e supportate da tecnologie aumentative e intelligenza artificiale, porteranno il pubblico di ogni età a sperimentare tre dimensioni fondamentali del rapporto tra apprendimento e persona: immedesimazione, introspezione, informazione (Ago Modena Fabbriche Culturali – Future Education Modena, a cura di: Future Education Modena, venerdì 13 ore 17- 22, sabato 14 ore 17-22, domenica 15 ore 9-13).
Il laboratorio “Scelte di fine vita” permette di sperimentare un breve momento di Death Education, simulando, in un ambiente protetto, la compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento: l’esperienza intende aiutare ad affrontare le difficoltà psicologiche e culturali relative alla rimozione di malattie e perdite, attraverso l’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione e alla condivisione delle scelte rispetto ai propri percorsi di cura (Modena, Palazzo Universitario – Aula Magna, a cura di: Fondazione ANT Italia Onlus, in collaborazione con: Polo Museale Unimore, venerdì 13 ore 15-19, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 15.00-18.00).
La rassegna cinematografica a cura della Biblioteca Loria di Carpi si concentra sul tema de “Il doppio”, del sosia, della dissociazione. Si inizia con l’uomo duplicato in “Enemy” di Denis Villeneuve (Canada/Spagna 2013, 90′), inedito nelle sale italiane, venerdì 13 alle 21, proseguendo alle ore 22.30 con il cult “Strade perdute” di David Lynch (USA/Francia 1997, 135′), thriller allucinato come un incubo che tratta dell’incapacità di un uomo di mantenere il controllo sulla propria vita. Sabato 14 alle ore 21, si proietta il grande classico di Akira Kurosawa “Kagemusha – L’ombra del guerriero” (Giappone 1980, 153′), in cui, nel medioevo giapponese, un sosia arriva all’immedesimazione totale con l’interpretato, il valoroso principe Takeda, fino ad assumerne il valore e il coraggio di fronte alla morte; chiude alle ore 23.35 “Inseparabili” di David Cronenberg (Canada/USA 1988, 115′), con i gemelli Elliot e Beverly e un delirante triangolo.
Protagonista della sonorizzazione live di “Soundtracks – Musica da Film” è “Lo Sconosciuto” di Tod Browning, con la doppia identità di Alonzo (Modena, Palazzo Santa Margherita – Chiostro, a cura di: Centro Musica Comune di Modena – Progetto Sonda azione Residenze Artistiche, Associazione culturale MUSE – progetto Arts & Jam, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Regione Emilia-Romagna, con la Direzione di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, sabato 14 ore 21). Il laboratorio esperienziale di scoperta del diverso oltre la pietra, “Metope empatiche e sguardi curiosi”, pienamente fruibile dalle persone con disabilità visiva, consente di interrogarsi su cosa è persona e cosa non lo è, attraverso le creature scolpite (Modena, Museo Lapidario del Duomo, conduzione: Nadia Luppi, Cristina Mori, a cura di: Musei Civici di Modena, Coordinamento Sito UNESCO, in collaborazione con: Musei del Duomo di Modena, sabato 14 ore 19; 20; 21; 45′).
Il ricordo e l’oblio, a differenza della memoria che attribuiamo anche alle macchine, sono cifra identitaria della persona insieme con le lacrime e il sorriso: la mostra “La persona che resta” si compone di un’istallazione video-scultorea di Armida Gandini (Gustose e dolcissime), di un video e di 6 scatti fotografici di Cinzia Naticchioni Rojas, e di 5 opere pittoriche di Stella (Modena, Galleria ArteSì, curatrice: Cristina Muccioli, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza delle artiste e della curatrice).
“Sospira” è una performance site-specific, con teche installative, ideata e interpretata da Elisabetta Di Terlizzi e Laura Gibertini, il cui oggetto è la definizione dell’identità attraverso l’espressione del corpo e la narrazione dell’identità biologica precedente e successiva alla coscienza (Modena, OM Studio, a cura di: OM Studio, venerdì 13 ore 18-19, sabato 14 ore 16.30- 17.30, domenica 15 ore 16.30-17.30, 20′).
Un’installazione scultorea con le identità multiple di Teseo e Pirandello è l’opera di Laura Tarugi in “Uno: centomila, centomila: uno”, accompagnata da interventi performativi in sede di mostra venerdì 13 ore 19.30, 20.30 e 21.30 e sabato 14 ore 15.30, 16.30, 19.30, 20.30 e 21.30 (Studio Torti 10, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dell’artista).
Venerdì 13 ore 21 lo spettacolo “Persona in dialogo” ricostruirà vita e pensiero di Carlo Maria Martini, con proiezioni, letture sceniche, intermezzi musicali e testimonianze eminenti (Modena, Chiesa di San Bartolomeo; a cura di: Associazione di Volontariato “Ho Avuto Sete”, in collaborazione con: Centro culturale F.L. Ferrari, Fondazione Culturale Ambrosianeum, Istituto Luce-Cinecittà, Fondazione Carlo Maria Martini).
Nutrito è il programma del Castello dei ragazzi di Carpi. Il percorso espositivo ispirato ai libri di Clotilde Perrin “Le Emozioni siamo Noi” propone sagome tridimensionali ad altezza di bambino, che riproducono i personaggi delle storie, presentando i tratti emotivi più caratteristici e permettendo ai visitatori di giocare attraverso particolari interattivi (Palazzo dei Pio – Torre dell’Uccelliera, a cura di: Castello dei ragazzi, Franco Cosimo Panini Editore, presentazione: sabato 14 ore 19 con intervista all’artista).
La narrazione di Monica Morini, Bernardino Bonzani, “Batticuori in valigia. Paura, amore e barattoli di felicità” racconta le emozioni in storie che sono ponti e domande, formule, mantelli, ripari potenti contro ogni paura (Biblioteca ragazzi Il falco magico, a cura di: Castello dei ragazzi, con: Teatro dell’Orsa, sabato 14 ore 17, domenica 15 ore 17; 18.30). Il laboratorio creativo “Barattoli di felicità” porta i bambini dai 6 anni in su a dare forme e colori alle memorie felici (Biblioteca ragazzi Il falco magico, a cura di: Castello dei ragazzi, con: Teatro dell’Orsa, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 18, con iscrizione dal 2 settembre). Il workshop con Clotilde Perrin “Dentro di te, dentro di me. Parole e emozioni di tutti i colori” prende spunto dall’albo “Le emozioni siamo noi” e vuole stimolare i partecipanti, dai 6 agli 8 anni, a riflettere sulle emozioni, utilizzando grandi fogli bianchi e assemblandoli in piccoli pop-up (a cura di: Castello dei ragazzi, Franco Cosimo Panini Editore, sabato 14 ore 16.30, domenica 15 ore 16.30, con iscrizione dal 2 settembre).
Il laboratorio creativo “Dacci un taglio!”, dai 4 anni in su, invita a creare nuovi e originali meccanismi animati per svelare e nascondere i segreti di rabbia, tristezza, gioia, disgusto e paura (a cura di: Castello dei ragazzi, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 18).
6. Diritti della persona
Laboratori, racconti e mostre mettono a tema esclusione e inclusione, tra riconoscimento e diritti
Forse abbiamo dato per scontati, anche con i nostri figli, tanti diritti, conquistati: salari adeguati, orari umani, diritto di sciopero, all’assistenza, alla sicurezza. È doveroso ricordare, allora, le condizioni di vita, le fatiche e le lotte, delle donne e degli uomini che ci hanno preceduto: lo si farà con Pamela Villoresi in “100 anni di lavoro” attraverso racconti, musica e poesie in un affresco lungo un intero secolo (Modena, Piazza Grande, venerdì 13 ore 22).
Una donna, che si impegna per i diritti delle donne, e una vita sempre in prima linea: Edith Stein è un luminosissimo enigma, che in qualche modo riassume il Novecento e parla di noi, al punto da essere divenuta patrona di tutta l’Europa come Santa Teresa dalla Croce. Lella Costa ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero nello spettacolo “Ciò che possiamo fare”, domenica 15 alle ore 21 (Sassuolo, Piazzale della Rosa). Altre voci di vittime della persecuzione nazista provengono dai volti e dalle storie passate per Fossoli: volti di donne che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale e che con le loro storie raccontano una prospettiva femminile, ricostruendo la storia come tessuto di eventi umani, in “Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: Fossoli” (Ex Sinagoga, curatori: Elisabetta Ruffini, Dario Carta, produzione: Fondazione Fossoli, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza dei curatori e degli autori, interviene Roberto Rugiadi, figlio di Frida Misul). 7 donne ci vengono incontro nell’itinerario teatrale “Frida e le altre. Accogli il mio abbraccio”, offrendo un contatto diretto, tra attrice e spettatore, e un modo inusuale, intimo di visitare il Museo Monumento al deportato, attraverso le lettere delle condannate a morte delle Resistenza (a cura di: Fondazione Fossoli, con: Teatro dell’Argine, venerdì 13 ore 20-22).
Nessuno lo sapeva, ma tra il 1943 e il 1944, l’eroe dello sport Gino Bartali, a rischio della vita, ha salvato centinaia di persone dalle persecuzioni nazi-fasciste. Nel suo racconto “Il vecchio e il Tour”, Michele Dalai, con l’ausilio dell’archivio sonoro per la regia di Guido Bertolotti, ricostruisce la storia di un uomo giusto, campione di sport e sacrificio (Carpi, Piazza Martiri, sabato 14 ore 22.30).
A Modena, la mostra “Keine Papiere” di Collettivo FX denuncia la condizione di chi non ha documenti, l’apolide, esponendo biglietti e “fotografie viaggiate”, un dipinto a tappe che diverrà libro d’artista (Palazzo dei Musei – Biblioteca Poletti, curatrice: Carla Barbieri, a cura di: Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dell’artista).
Dove sono le nostre radici in quanto Persone? È sufficiente nascere umani per essere umani? Il percorso sensoriale, di circa 10′, proposto da “Considerate che questo è un uomo” accosta il passato al presente, invitandoci a ribaltare lo sguardo per riflettere e puntare a un futuro più umano (Modena, Centro di accoglienza “Papa Francesco” – chiostro, a cura di: Bambini nel deserto ONLUS, Caritas diocesana modenese, Centro missionario diocesano-animazione e formazione, venerdì 13 ore 16-21; sabato 14 ore 10-13.30; 16-21; domenica 15 ore 10-13.30; 16-21).
Presso il Complesso San Filippo Neri di Modena, “Riti d’accoglienza” presenta alcuni dei “contesti de-umanizzanti” accaduti nella storia fino ai giorni nostri, attraverso video, testimonianze, foto, articoli di giornale, portando singoli o gruppi a conversare con chi – nella propria vita e nella propria professione – ha compiuto un “percorso di ri-umanizzazione” (a cura di: Fondazione San Filippo Neri, 30′, sabato 14 e domenica 15 ore 11-13; 16-19).
Nei laboratori “In prima persona. Esercizi di riconoscimento” i temi della solidarietà e del volontariato saranno presentati in maniera giocosa, interattiva e divertente, per tutte le età (Modena, Piazza Matteotti, a cura di: Centro Servizi per il Volontariato di Modena, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 15-19).
La donna in musica si rivela di volta in volta in una veste simbolica, vincente, sofferente, assoggettata: “Donne senza maschera” presenta la musica al femminile nel Seicento presso la Chiesa di San Bartolomeo di Modena (a cura di: Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense, sabato 14 ore 21).
Presso il Teatro San Carlo di Modena, invece, “Ogni mare ha un’altra riva” mette in scena la storia di due fratelli, che si perdono e si ritrovano lungo la rotta dalle acque del Mediterraneo al canale Saint Martin di Parigi, sottratti all’indifferenza statistica e restituiti alla loro dignità di individui (produzione: Associazione Artisti Drama, sabato 14 ore 21).
Il tema scelto per la mostra fotografica “Invisibile” è l’invisibilità della persona, che in molti casi corrisponde alla “non-persona”, figura spogliata di personalità, essere a cui non è riconosciuto lo statuto di individuo responsabile e la titolarità di diritti e doveri, umani e civili (Modena, Complesso culturale San Paolo – Cortile del Leccio, curatrice: Maura Pozzati, a cura di: Associazione Donne Fotografe – ITALIA, presentazione: sabato 14 ore 17 alla presenza della curatrice e delle artiste).
Tre giorni per ampliare la propria conoscenza del Pilastro europeo dei diritti sociali, con “WelFARE? Benfatto!”, che presenta il progetto su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione (Modena, Palazzo Comunale – Galleria Europa, a cura di: Comune di Modena – Centro Europe Direct, con il sostegno di: Rappresentanza a Milano della Commissione europea).
Quasi sempre invisibili, le vittime della guerra reclamano il riconoscimento del loro diritto di umanità: “L’Ospedale di tutte le guerre – The Hospital of all the Wars” di Alessio Mamo, Marta Bellingreri è una mostra fotografica che, attraverso undici storie, racconta l’inizio di un nuovo capitolo per altrettante vittime dei conflitti (Modena, Complesso San Paolo, produzione: Medici Senza Frontiere, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza degli autori).
Il percorso teatrale “Attraver-siamo” porta gli ospiti dagli 8 anni in su in viaggio sulle orme di Enea, facendo emergere i temi dell’accoglienza, del diverso, del nuovo. Il pubblico si ritroverà a vivere diversi ruoli, ad essere straniero e – all’opposto – ad essere colui che accoglie lo straniero (Sassuolo, Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine, a cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete, venerdì 13 ore 16.30; 17.30, sabato 14 ore 10.30; 11.30; 16.30; 17.30, domenica 15 ore 10.30; 11.30; 16.30; 17.30).
Il gioco di ruolo educativo online “Hold The Line – Scelte di confine. Nei panni di una persona migrante” stimola i partecipanti a vivere, come sulla propria pelle, le possibili vicissitudini e le difficoltà delle loro scelte che caratterizzano, sin dal momento di approdo nel nuovo Paese, il percorso delle persone migranti richiedenti Protezione Internazionale (Sassuolo, Via Cesare Battisti, a cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, venerdì 13 ore 16-19, sabato 14 ore 10-13; 14-19; domenica 15 ore 10-13; 14-19; ci si iscrive sul posto oppure su Eventbrite, 40′).
Con “Scarti? La dignità non si butta”, un’installazione in più “stanze” esplora il tema della “dignità” e del ridare valore a ciò che viene considerato “scarto” (oggetti e persone), concludendosi con un percorso iconografico e fotografico che mostrerà casi eloquenti del passaggio da scarto a valore (Sassuolo, Villa Giacobazzi – Parco Vistarino, a cura di: il Melograno e Nuovamente, in collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo, sabato 14 ore 10-12; 16-18; domenica 15 ore 10-12; 16-18).
Francesco Cannadoro in “#cucitialcuore. Oltre gli ostacoli” documenta con immagini e filmati la difficoltà di integrazione delle esigenze connesse alla disabilità (in particolare quella infantile) in una società, quella italiana, che non è ancora “a misura” di disabile (Modena, Salotto Culturale Aggazzotti, curatori: Maja Argenziano, Renzo Pavignani, Lorenzo De Vinco, Elisa Perri, a cura di: Ideas4u, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza dei curatori e dei protagonisti, con letture di Daniele Sirotti).
La mostra “Lo avete fatto a me” viene raccontata da Luigi Ottani con otto volti incorniciati, mentre Roberta Biagiarelli, autrice teatrale e curatrice della mostra, realizza un’ambiente vocale-musicale che accompagna il visitatore nel percorso (Modena, Complesso San Paolo, a cura di: Babelia & C. Progetti Culturali, performance: sabato 14 ore 19.30 alla presenza dell’artista e della curatrice).
Il concerto di Ologramma “…anche fragile”, attraverso un percorso nella musica d’autore, presenta la forza del suono e del riconoscimento reciproco attraverso le vibrazioni, i toni, le storie che aiutano a non sentirsi soli, condividendo la propria fragilità con gli altri (Modena, Piazza Roma; produzione: Istituto MEME Modena, CEMU Centro Europeo Musicoterapia, UPGB Università Popolare “Gregory Bateson” Modena, sabato 14 ore 18).
Due spettacoli a cura del Comune di Sassuolo si inseriscono nella serie di produzioni “teatro in casa”, per un numero limitato di spettatori e obbligo di prenotazione, con la regia di Ennio Trinelli e in collaborazione con GaiaitaliapuntocomEdizioni, festival Urla dal Silenzio, Cooperativa Sociale Svoltare ed Europa Teatri: in “Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese. Racconto di una fuga” il giovane attore Pierre Panival Bangouri ci racconta un emozionante spaccato della cultura del suo paese tra tradizioni, danze, cultura e devastazione morale, politica, sociale (venerdì 13 ore 19, sabato 14 ore 19, domenica 15 ore 19), mentre in “Jeux du Sable. Una traversata del deserto” Guainou Ibrahim testimonia il dramma di un’intera generazione di esseri umani in pochi metri quadrati, partendo da un gioco di bambini con la sabbia che scivola dalle mani ed alcuni bastoncini (venerdì 13 ore 21, sabato 14 ore 21, domenica 15 ore 21).
I Cortili di Ago propongono a Modena due serate speciali per il festivalfilosofia dedicate al rap, genere in cui si esprime la soggettività e la voglia di riscatto, a partire dalle esperienze della marginalità urbana: venerdì 13 alle 21.30 gli Assalti frontali in concerto in “Periferie della città, centro dell’anima”, mentre sabato 14 alla stessa ora Murubutu, in una serata di parole e musica, presenta “La cura del rap” (Modena, Ago Modena Fabbriche Culturali, a cura di: Ago e Laika Mvmnt).
Scritto da Claudio Pisapia il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI.
“Salario minimo proposto dal M5s? Prima viene il taglio delle tasse. Prima di ridistribuire bisogna crearla la ricchezza”.
Frase questa del Ministro Salvini che da buon padre di famiglia ammonisce i suoi compagni di governo sulla necessità di dover accumulare prima. Poi creare ricchezza e infine ridistribuire. Non fa una piega. Peccato però che uno Stato funzioni un po’ diversamente da una famiglia o da un’impresa per cui l’investimento può e deve essere fatto prima per creare sviluppo poi, assicurando nel contempo una equa ridistribuzione.
Ma seguiamo il suo ragionamento guardando ai dati e mettendoli in relazione alle sue parole partendo da una domanda: quanta ricchezza è necessaria per poter passare alla ridistribuzione?
A fine 2018 la ricchezza finanziaria privata nel mondo ha raggiunto i 206 trilioni di dollari, secondo l’ultimo report del Boston Consulting Group (Global Wealth 2019: Reigniting Radical Growth). L’Italia occupa la nona posizione tra le nazioni più ricche al mondo con ben 5 mila miliardi di dollari di ricchezza finanziaria personale (il che significa quasi il triplo del Pil attuale che è pari a circa 1.768 miliardi di euro). E il futuro appare roseo, visto che si prevede che tale ricchezza toccherà i 5,6mila miliardi di dollari nel 2023.
Qui si parla di ricchezza finanziaria, quindi se aggiungessimo anche la ricchezza mobiliare arriveremo ai fatidici 9.000 miliardi (euro più, euro meno) che diviso i 60.000.000 milioni di abitanti darebbero 150.000 euro a testa. Ovviamente sappiamo che non è così e nemmeno sarebbe giusto lo fosse. Infatti il punto è quello che abbiamo evidenziato prima e cioè: che livello di ricchezza serve per passare alla ridistribuzione (cioè mettere un po’ di danaro in giro per le imprese, fare opere pubbliche e assumere lavoratori e magari dare soldi sufficienti per i bisogni primari alle persone momentaneamente in difficoltà)?
La ricchezza è già tanta e continua a crescere insieme alle disuguaglianze. I milionari (chi ha ricchezze sopra il milione di dollari) sono 22 milioni su quasi 8 miliardi di esseri umani. In un anno sono aumentati del 2,1% e detengono il 50% della ricchezza finanziaria mondiale. In Italia ci sono 400 mila milionari, nel 2013 erano la metà, a dimostrazione che la ricchezza sta crescendo anche in Italia insieme alle disparità, visto che contemporaneamente sono aumentati anche i poveri.
A Salvini evidentemente non basta, avrà le sue ragioni e forse me le sono perse. Colpa mia, uso poco twitter e non vado in spiaggia dove c’è musica ad alto volume. Lui vorrà arrivare magari a 800 mila oppure a un milione di milionari attraverso una forte riduzione di tasse e maggior ordine pubblico che possa essere di supporto all’avvio di nuove attività imprenditoriali.
Del resto la Flat Tax era stata ipotizzata dal ‘grande amico del popolo’ Alan Friedman, ispiratore delle politiche popolari di Reagan e della Thatcher. Tassa che assicura risparmi di cento o mille euro alle classi medio-basse e qualche centinaia di migliaia o un milione di euro a quelle alte. E poi ci si attende che i beneficiari di cotanta generosità statale ricambino ricoprendo lo stivale italico di aziende e che assumano fino alla piena occupazione. Più o meno quello che non è successo quando siamo passati dalle 32 aliquote alle 5 di adesso che hanno visto l’aliquota più alta passare dal 72 al 43 percento.
Ma Salvini continua ad andare bene perché anche il Pd era ed è di destra, anche il Pd è neoliberista e predica l’accumulo prima della ridistribuzione e dell’investimento, gli equilibri di bilancio e le regole eterne del rifiuto del deficit. È storia odierna che i voti della Lega si sono incontrati con quelli del Pd e persino con quelli della Bonino. Tutti d’accordo contro i no del Movimento 5 Stelle. Quelli che forse vorrebbero cominciare a distribuire quanto già c’è.
In assenza di una sinistra abbastanza forte in questo mondo confuso sono gli unici a fare cose di sinistra con il reddito di cittadinanza, il salario minimo e il decreto dignità. Quindi distribuire e investire prima perché le persone possano spendere per rimettere in circolo l’economia e permettere allo Stato, oltretutto, di operare in fase anticiclica. L’unico dubbio che mi sfiora è che magari non sanno cosa stanno facendo e non so se questo possa assolverli dal governare seriamente.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI.
di Nicola Grandi*
Si dice che il modo migliore per non far conoscere agli altri i propri limiti sia quello di non cercare mai di superarli. Ciò dovrebbe valere soprattutto quando ci si inoltra in terreni con i quali non si ha particolare dimestichezza. Di certo, l’articolo di Silvia Ronchey pubblicato una ventina di giorni fa su Repubblica (12 luglio) non è ispirato alla saggia prudenza cui l’aforisma ci invita. Lo spunto sono i risultati della rilevazione Invalsi 2019. Già il titolo del pezzo, “I nostri ragazzi diventati analfabeti”, è ingannevole, perché prefigura uno stadio precedente di piena e completa alfabetizzazione e un recente peggioramento degli indicatori. Gli argomenti che la Ronchey usa per interpretare la situazione (non i dati, che non vengono citati, se non sporadicamente) sono molteplici e spesso il nesso tra essi pare piuttosto labile se non azzardato. Uno però merita di essere approfondito, perché viene menzionato in modo talmente semplicistico da risultare assolutamente distorto:
“Fin dall’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso, nel nome della cosiddetta democratizzazione della cultura, si assisteva a fenomeni bizzarri. Una collana, pubblicata da una casa editrice di partito, ideata e curata da un grande accademico nel nome di una ‘educazione linguistica democratica’, proponeva libri in cui non fosse usato che un numero limitato di vocaboli. La lotta al nozionismo, che aveva animato il Sessantotto e i suoi seguaci, nei licei di tendenza di quegli anni si prolungava nella condanna della complessità della parola”.
Una premessa è doverosa: citare per nome il proprio interlocutore dovrebbe essere una elementare forma di rispetto. Ma tant’è… Ovviamente l’accademico in questione è Tullio De Mauro e la collana cui si fa riferimento è quella dei ‘Libri di base’, pubblicata dagli Editori Riuniti. Detta così, sembra che questi libri avessero come finalità programmatica quella di una consapevole drastica riduzione del lessico italiano che, con nesso causale, avrebbe contribuito alla diminuzione del Q.I. (quoziente intellettivo, ndr) degli italiani a partire dagli anni ’70, al ritmo di ben 7 punti a generazione (dati citati dalla stessa Ronchey): una consapevole, pianificata semplificazione lessicale, poi evidentemente sintattica e, di qui, delle capacità di pensiero e ragionamento. Il tutto in nome di una presunta (immagino che le virgolette indichino più meno questo) educazione linguistica democratica.
Credo sia utile ricordare che la collana in questione, di carattere dichiaratamente divulgativo, aveva lo scopo di rendere accessibili ad un pubblico vasto contenuti spiccatamente specialistici. E per farlo, questi contenuti ed il loro lessico tecnico venivano presentati e introdotti attraverso un uso preferenziale del vocabolario di base, che, è bene ribadirlo, non intende sostituire i necessari specialismi, ma diventa strumento per renderli comprensibili anche a chi non fa parte della ristretta comunità degli specialisti di un particolare ambito disciplinare. Insomma, spiegare la fisica a chi non è fisico, la civiltà bizantina a chi non è bizantinista e così via. Si tratta, per inciso, di un’iniziativa che oggi darebbe lustro a un qualunque dipartimento alla voce ‘terza missione’!
Il numero di parole del vocabolario di base non è così limitato: ammonta a 7.000 elementi e rappresenta quella porzione del lessico italiano usata e compresa dalla maggior parte degli italiani. Questa “cosiddetta democratizzazione della cultura”, dunque, significa innanzitutto allargare le basi sociali della conoscenza e garantire l’accesso al sapere anche a chi, per vicende e scelte personali, non ha potuto accedervi percorrendo la via maestra, cioè frequentando l’Università. E la democratizzazione della cultura, fenomeno tutt’altro che bizzarro dal mio punto di vista, non può che passare da un allargamento della base sociale della lingua.
Chiunque abbia letto le Dieci Tesi per una educazione linguistica democratica del ‘Gruppo di intervento e studio nel campo dell’educazione linguistica’ – e chiunque scriva di educazione linguistica, soprattutto se lo fa nella pubblicistica generalista, dovrebbe farlo o rifarlo prima di mandare alle stampe gli articoli – sa molto bene che le Dieci Tesi non tracciano solo una visione della scuola. Vanno ben oltre: tracciano una visione della società. Confinare alla scuola la portata dell’educazione linguistica democratica, esonerando innanzitutto l’Università da qualunque compito educativo in chiave linguistica, significa creare i presupposti per perpetuare quel quadro che le prove Invalsi hanno tracciato. E che è molto più complesso di quanto appaia non solo nell’articolo della Ronchey, ma in molti altri interventi che negli ultimi giorni hanno affrontato il tema (finalmente, verrebbe da dire!).
Riportare che il 35% degli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità non sa comprendere un testo di media complessità significa poco o tanto. Dipende dalla prospettiva di analisi.
Occorre però una premessa: le prove Invalsi, sulle quali sarebbe bene aprire un confronto ad hoc, rilevano la comprensione di testi scritti. Restano fuori dalla rilevazione sia la dimensione della produzione, sia quella dell’oralità. Esse dunque ci danno senza dubbio una visione sulla lingua, ma è una visione parziale.
Detto questo, conviene partire dalla diacronia. Ed è lo stesso rapporto Invalsi 2019 a dire, in modo chiaro, che i nostri ragazzi non stanno affatto diventando analfabeti. Lo nota anche Mila Spicola sul blog di Huffpost. Per il grado 8 (terza secondaria di primo grado), il rapporto Invalsi 2019 riporta:
“In Italiano la percentuale di alunni che raggiunge o supera il livello 3 diminuisce nel 2019 di 2,4 punti nel Nord Ovest e di 2,9 punti nel Centro, mentre aumenta nel Sud di 4,6 punti. Nelle altre macro-aree le variazioni sono minime e non significative”. Diminuisce, quindi, la forbice tra il Sud e il resto del paese. Per il grado 10 (seconda secondaria di secondo grado), “si registra nel 2019 in tutte le aree e in entrambe le materie un aumento statisticamente significativo di alcuni punti percentuali della quota di alunni che raggiunge o supera il livello 3. In Italiano, la percentuale di alunni a questo livello o superiore cresce nel Nord Ovest di 2,3 punti, nel Nord Est di 2,8 punti, nel Centro di 4,0 punti, nel Sud di 2,5 punti e nel Sud e Isole di 4,1 punti.” (entrambe le citazioni sono tratte da pag. 111 del rapporto).
Il quadro non diventa magicamente rassicurante, ma i dati smentiscono l’idea di declino progressivo che caratterizza molti commenti poco informati. E crea almeno uno sfondo diverso sul quale proiettare le cifre. Concentriamoci sui risultati per l’italiano al grado 13, corrispondente agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (per i quali non è possibile una valutazione comparativa rispetto alla rilevazione precedente). Cito dalla pagina 53 del rapporto Invalsi: “Considerando tutti gli studenti del grado 13, nella prova di Italiano il Nord Ovest e il Nord Est ottengono un punteggio significativamente al di sopra della media italiana (200), il Centro consegue un risultato pari a quello medio nazionale, mentre il Sud e il Sud e Isole conseguono punteggi significativamente più bassi di 11 e 15 punti rispettivamente. Si noti che a far scendere l’area Sud al di sotto della media italiana contribuisce soprattutto la Campania, sola regione il cui punteggio è significativamente inferiore ad essa”. Quella forbice che al grado 10 pareva ridursi, al grado 13 si fa invece paurosamente ampia.
Per completare il quadro, facciamo più di un passo indietro e diamo un’occhiata alla scuola primaria. Al grado 2, secondo anno della primaria, “non si registrano in Italiano differenze significative tra le macro-aree: i punteggi medi delle cinque zone in cui il Paese è suddiviso oscillano entro un intervallo di uno o due punti sopra e sotto la media nazionale, cosicché si può affermare che in seconda primaria esse conseguono risultati sostanzialmente simili” (pag. 41). Invece “in quinta primaria il Nord-Ovest registra un punteggio significativamente più alto della media nazionale (200) di 4 punti, mentre il Sud e Isole ottiene un punteggio significativamente più basso di circa 8 punti. Il risultato delle altre tre aree, Nord Est, Centro e Sud non si discosta invece dalla media italiana. Al di là della loro significatività statistica, complessivamente le differenze dei risultati delle macro-aree, tolto il Sud e Isole, si limitano a qualche punto in più o in meno rispetto alla media generale” (pag. 43).
Cosa ci dicono, dunque, i dati delle rilevazioni Invalsi? Innanzitutto che, nel complesso, la scuola primaria funziona bene. Poi, che il divario tra Nord e Sud emerge alla fine del primo ciclo e, letteralmente, esplode nella scuola secondaria di secondo grado. E che i risultati dell’apprendimento si mantengono in media più che soddisfacenti fino alla secondaria di primo grado, poi il quadro peggiora. Perché? Probabilmente perché nell’istruzione secondaria di secondo grado le scelte tra scuole radicalmente diverse si ampliano in modo significativo, le differenze sociali smettono di attenuarsi e lo scenario si fa molto disomogeneo (e questo pone un interrogativo cruciale: ha senso misurare con lo stesso strumento realtà così diverse?); probabilmente perché tra i 14 e i 18 anni i modelli culturali di riferimento si fanno più forti e portano spesso ben lontano dalla scuola; probabilmente perché la stessa attenzione delle famiglie (quasi morbosa alla primaria) si fa via via meno intensa…
Ma le Invalsi ci dicono anche che quel famoso 35% di maturandi che fatica a comprendere un testo di media difficoltà si concentra al Sud, in istituti tecnici e professionali e in situazioni di disagio sociale le cui radici sono ben lontane dalla scuola.
Alzi la mano chi può dirsi sorpreso.
Le prove Invalsi hanno fotografato la scuola o l’Italia? Vogliamo riversare sulla scuola le responsabilità di queste diseguaglianze o vogliamo capire che la scuola, tra mille difficoltà e combattendo contro un crescente discredito sociale, fa ancora miracoli?
L’Italia è uno stato giovane, l’italiano, come lingua nazionale, lo è ancora di più. E come un bimbo che cresce ha bisogno di sostegno e supporto. Lo Stato che supporto dà, oggi, alla scuola?
La risposta è superflua, basta guardare gli investimenti nell’istruzione e nella formazione insegnanti, vera questione da affrontare di petto.
In questo quadro, incolpare l’educazione linguistica democratica significa confondere malattia e medicina! Se avessimo creduto e investito di più in una educazione linguistica davvero democratica oggi commenteremo dati molto diversi. I dati Invalsici dicono che la situazione è seria, ma non irrecuperabile. Basta saperli leggere. O forse basta volerli leggere.
* docente ordinario del dipartimento di Filologia classica e Italianistica – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Scritto da Liliana Cerqueni il . Pubblicato in Eventi, IL QUOTIDIANO, In Evidenza.
In Siberia si annega o si brucia: immagine contraddittoria ma tragicamente reale di un vasto territorio in ginocchio, di cui su stampa e Tg si parla troppo poco o si tace. La terribile alluvione del mese scorso e l’incendio che continua a imperversare attualmente offrono un panorama apocalittico di proporzioni vastissime e senza precedenti che riguarda le regioni siberiane di Krasnoyarsk, Irkutsk e la Yakuzia, tutto l’estremo Nordest della Russia.
Una catastrofe ambientale senza precedenti per estensione, virulenza e impatto sui delicati equilibri di quei territori, a cui si aggiungono anche le coste del mar Artico, la Groenlandia, il Canada e l’Alaska, dove si segnalano incendi e focolai. Una cortina di fuoco e fumo che invade il Nord del mondo, proprio quei Paesi freddi in cui è difficile immaginare un fronte ardente preoccupante. Cambiamenti climatici che vedono salire le temperature oltre i 30°, accompagnate da venti forti? Responsabilità umana legata a comportamenti dolosi e pratiche poco chiare?
Scorrono ipotesi, convinzioni, illazioni, chiavi di lettura differenti di questi fenomeni che chiedono chiarezza innanzitutto, risposte e spiegazioni accreditate e attendibili. Nella regione di Krasnoyarsk la popolazione ha dato vita in questi giorni a una grande manifestazione di protesta, chiedendo le dimissioni del governatore che aveva cinicamente dichiarato che “combattere gli incendi non è redditizio”.
Abbiamo raggiunto telefonicamente lo scrittore Nicolai Lilin, che in Siberia ha lasciato parenti, amici e un pezzo del suo cuore, impegnato quotidianamente a seguire a filo diretto ciò che accade nelle regioni colpite dalla devastazione con notizie di prima mano, trasmesse da coloro che stanno vivendo il dramma. “Le proporzioni dell’incendio sono impressionanti – racconta – le ricadute non sono solo ambientali ma anche sociali, umane, perché quelle foreste, tutte le foreste sono i polmoni dell’umanità. Le fiamme stanno trasformando il paesaggio in un enorme buco nero con pesanti conseguenze sull’habitat e la salute della gente di cui vedremo gli effetti. Siamo vicini ai 4 milioni di ettari spazzati via dal fuoco, destinati a crescere ogni giorno se non arginato e circoscritto. Un disastro sociale, economico e ambientale a cui non si sta dando voce in tutta la sua rilevanza nei media internazionali. Arrivano foto satellitari sempre più allarmanti e il vento che soffia è come un lanciafiamme che alimenta ulteriormente il rogo. Il fumo arriva fino in Alaska e Canada e la fuliggine viene trasportata dall’aria e raggiunge zone anche lontane centinaia di chilometri, come il Tatarstan, dove alla gente è consigliato di indossare mascherine. La resina degli alberi e la torba emettono esalazioni che si respirano; la torba, in particolare, per la sua conformazione conserva il calore e le braci e continua a covare e bruciare sottoterra.
Chiediamo a Lilin della gente, la sua gente, e lui racconta degli sforzi che i civili stanno facendo perché, fino qualche giorno fa dovevano contare solo sulle loro forze. “Si sono formate squadre di volontari locali che fanno del loro meglio, poco. Ivan, un mio amico, ha usato i suoi soldi e il suo mezzo agricolo per contrastare il fuoco e, insieme agli altri tentare di salvaguardare il villaggio. Inutilmente, perché è bruciato tutto. Le persone sono profondamente colpite, arrabbiate e impotenti davanti alle autorità locali che non intervengono. L’oro verde, il legname, che è un business enorme legale e sommerso, porta un indotto di 49 miliardi l’anno come esiti della vendita in Cina. E i treni carichi di tronchi non smettono di viaggiare. Nel frattempo, la gente è costretta ad abbandonare i luoghi in cui è sempre vissuta”.
Lilin specifica che i primi incendi sono divampati già a marzo e molte persone segnalarono il pericolo: “La Taiga è la loro vita, la loro casa, il loro sostentamento, il loro futuro. Ma che futuro può avere un territorio grande due volte il Belgio che arde perennemente e che avrà la prospettiva di ricrescere e ripopolarsi della fauna nell’arco di 100 anni? “Danni enormi alla flora e alla fauna, alla qualità di acqua e aria – ribadisce Lilin – Non si è parlato di numeri riguardanti vittime umane ma ci sono dispersi, persone scomparse, che sicuramente saranno andate incontro alla morte, date le circostanze. Solo in questi ultimi giorni il presidente Putin, in una riunione straordinaria, ha dato ordine di impegnare l’aeronautica militare per contrastare dall’alto le fiamme, e di inviare mezzi di terra per intervenire. Merito, forse, anche della mobilitazione sul web che ha attirato l’attenzione sulla drammatica situazione”.
“Non si sta togliendo futuro solo alla Taiga, ai suoi villaggi, alla gente che la popola da sempre in un rapporto ancestrale col territorio, alla sua potente foresta boreale, alla sua fauna costituita da lupi, orsi, linci, visoni: si sta togliendo futuro a tutti noi – conclude Lilin – con i cambiamenti del clima, l’incuria, l’indifferenza, il cinismo di chi predilige il business alla salvaguardia della vita”.
Scritto da Redazione di Periscopio il . Pubblicato in STORIE & RACCONTI, In Evidenza.
racconto di Maurizio Olivari
foto di Giordano Tunioli
Nel paese di Augusto, abitato da appena 1457 anime, non esisteva il cimitero e quando qualcuno passava all’altro mondo lo portavano in un paese distante circa quindici chilometri. Una distanza che pareva immensa perché bisognava percorrere una strada in parte sterrata che scendeva verso valle con pendenze, in certi punti, anche del dodici per cento.
A scendere tutti i santi aiutano, dicevano i vecchi del paese, ma quando si deve risalire, con la bicicletta o a piedi, tutto diventa più difficile.
Almeno una volta al mese si sentiva la necessità di andare a trovare i propri defunti e per gli abitanti che stavano invecchiando diventava un problema.
Augusto in paese era una istituzione. La delegazione comunale lo aveva impiegato fin da giovanissimo come messo, come postino, come operatore ecologico, come attacchino e come unico collaboratore del capo delegazione, che era il proprietario dell’unico negozio della borgata dove si vendevano generi alimentari e, una volta al mese, pesce fresco. In un’ala del negozio c’era anche un piccolo reparto di merceria, stoffe, alcune anche di buona fattura, filo e bottoni, articoli di ferramenta e i giornali quando arrivavano.
Augusto, sul problema del cimitero lontano, ascoltava con pazienza le lamentele dei suoi compaesani. Un giorno decise di fare una raccolta di firme per avere in paese un cimitero tutto per loro. Domande in carta bollata, preventivi di spesa, richieste di autorizzazioni agli enti preposti.
Dopo mesi finalmente, Augusto, nelle vesti di postino, consegnò al capo delegazione la busta del Comune e restò in attesa di sapere dal suo capo l’esito dell’autorizzazione alla costruzione del cimitero. Dopo la lettura di decine di comma e citazioni di articoli di legge, l’ultima riga recitava: Visto ecc… ecc… si respinge la richiesta.
Non rimaneva che dare la notizia ai suoi compaesani, deciso comunque a trovare una soluzione che potesse almeno soddisfare le persone più anziane.
Augusto aveva perso i genitori quando era ancora bambino e praticamente era stato adottato dalle famiglie del piccolo paese e anche per questo sentiva il bisogno di aiutare quegli anziani che praticamente gli avevano fatto da genitori.
Con i suoi cinquant’anni trascorsi tutti al paese, aveva conosciuto molti dei defunti e prese una decisione importante per il bene di tutti. Una volta la settimana sarebbe andato al cimitero del comune vicino a portare fiori e dire preghiere sulle tombe, in nome e per conto dei parenti che non potevano andare.
Si segnò i nomi dei defunti, chiese ai parenti quali fiori portare e quali preghiere recitare tra ‘Ave Maria’ e ‘Padre Nostro’.
L’inizio della sua missione non fu molto impegnativo: dovette soddisfare solo quattro richieste, cioè dieci garofani, tre Ave Maria e un Padre Nostro.
Raggiunto il cimitero in motorino, iniziò il rito cominciando dalla tomba dei suoi genitori per poi passare a quelle dei suoi compaesani. La prima tomba fu quella di Ulderico Passatori, morto nel 1945 durante la guerra di liberazione. Era uno dei partigiani nascosti nelle montagne e pronti all’azione per liberare il paese dai tedeschi. Un giorno ebbe notizia che alcuni tedeschi si erano accampati proprio nel suo podere e, mosso dal timore che insidiassero la sua famiglia, lasciò il nascondiglio e scese da solo in paese deciso ad affrontarli. Era già nei pressi di casa sua quando moglie e figlia lo videro e gli corsero incontro per impedirgli di trovarsi di fronte ai tedeschi. Ma le due donne non riuscirono a fermarlo, affrontò i militari spavaldo e armi in pugno, e venne freddato quasi subito dai colpi di una mitragliatrice.
La vedova, ora molto anziana, non era mai riuscita a superare la perdita del marito e a distanza di tanti anni continuava a pensare ai tedeschi con odio sussurrando “maledetti”. Per lui un garofano rosso e un ‘Padre Nostro’.
La seconda tomba fu quella di Giuseppina, e lì non riuscì a trattenere la commozione. Era stata la sua amica del cuore, la compagna di studio e di gioco. Da bambini amavano salire su in collina e attraversare il bosco raccogliendo mazzolini di fiori da portare a casa. Un giorno, mentre si trovavano in un tratto impervio della collina, Giuseppina vide uno splendido fiore giallo e blu, magicamente spuntato nella parete rocciosa che scendeva a picco nel burrone. “Lo prendo io!” disse la ragazzina con slancio. “Attenta, non sporgerti tanto” ammonì Augusto.
Fu un attimo: Giuseppina scivolò e gridò, Augusto con un balzo riuscì ad afferrarle un braccio tenendosi aggrappato a un ramo. Ma era impossibile per un ragazzino mantenere le due prese, lei urlava terrorizzata mentre la sua mano lentamente si staccava da quella di lui. Volò per almeno una trentina di metri, sotto lo sguardo impotente e disperato di Augusto.
Sopra quella lapide rivisse ogni attimo di quella tragedia che non aveva mai dimenticato, sentendosi in qualche modo in colpa per non essere stato abbastanza forte da salvarla. Per lei un garofano rosa e una ‘Ave Maria’.
La terza tomba fu quella di Giorgio il fornaio. Per Augusto il fornaio era stato quasi un secondo padre. Tutte le mattine lo accoglieva in negozio con una tazza di latte in cui inzuppare una pagnotta appena sfornata, e gli passava un dolce da portare a scuola come merenda. Augusto ricambiava la cortesia con sincera gratitudine e si prodigava aiutandolo nelle ore libere e consegnando per suo conto il pane a domicilio.
Ma il destino aveva colpito Giorgio negli affetti più cari: la nascita di una figlia ritardata e la perdita precoce della moglie lo avevano costretto ad affidare la bambina a un istituto. Per questo Giorgio aveva perso il sorriso. Ogni giorno che passava il fornaio si intristiva sempre di più e nemmeno l’allegra presenza del piccolo Augusto lo consolava granché. Una mattina il forno rimase chiuso, porta e finestre erano sbarrate. Passò poco tempo e lo trovarono appeso a una trave del retrobottega con una corda stretta attorno al collo. In un biglietto a terra chiedeva scusa per il suo gesto e lasciava un saluto per Augusto, con la preghiera di andare qualche volta a trovare la figlia all’istituto. Augusto mantenne l’impegno andando a trovarla ogni mese. Nel piccolo vaso sulla tomba depose un garofano giallo recitando un ‘Padre Nostro’.
La quarta ed ultima tomba fu quella della nonnina del paese, una ultracentenaria che se n’era andata da questo mondo il giorno dopo il suo centoquattresimo compleanno, per il quale avevano fatto una grande festa, donandole un grande mazzo di fiori e una bella pergamena incorniciata con gli auguri di tutti.
La chiamavano nonna sorriso, perché quando incontrava le persone, regalava sempre una parola buona e talvolta una battuta spiritosa ridendo di gusto. Sul letto di morte, il suo viso aveva un’espressione serena, come era stata in tutta la sua vita. Augusto guardò la sua foto sulla lapide e la salutò con un bacio, poi posò delle margherite, i suoi fiori preferiti, e questa volta non pregò affatto. La nonnina infatti diceva sempre di non pregare per essere aiutati ma di aiutarsi da soli pensando con ottimismo, o qualcosa del genere.
Augusto e i suoi compaesani erano soddisfatti di questa idea. Tutte le settimane, per tutto l’anno, le sue trasferte al cimitero del paese vicino erano state puntuali e senza imprevisti.
Un giorno di pieno inverno, aveva nevicato e le strade erano impraticabili. Doveva essere il giorno di visita al cimitero ma tutti quanti in paese sconsigliarono Augusto di partire. “Troppo pericoloso scendere con il motorino oggi… andrai la prossima settimana!” gli dissero.
Augusto non ne volle sapere, prese i fiori e andò.
Giunse ben presto la sera e Augusto non era ancora tornato. Così, qualcuno in paese cominciò a preoccuparsi.
Il mattino seguente decisero di cercarlo, alcuni a valle, altri in cima verso il bosco. Vicino a un dirupo trovarono il motorino e più sotto, in mezzo alle rocce, il corpo senza vita di Augusto. Era proprio il punto dove tanti anni prima era caduta Giuseppina. “Era destino” disse qualcuno.
Tutti chiesero e ottennero di non seppellirlo nel cimitero del paese vicino ma dove aveva sempre vissuto. Alle porte del borgo, in un fazzoletto di terra sotto un grande acero, con una piccola lapide di marmo bianco e la scritta “Qui riposa uno di noi, accanto a noi”.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.
Da: Save the Children
Yemen: fabbrica italiana delle bombe annuncia sospensione forniture ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Soddisfazione del Coordinamento che chiede Stop alle armi per bombardare lo Yemen
Commentando la notizia con cui, la sera del 30 luglio, l’azienda RWM Italia ha reso nota ai propri lavoratori la sospensione per 18 mesi delle esportazioni ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti nel rispetto della “volontà politica del parlamento e del governo”, il Coordinamento della società civile italiana che dal 2015 chiede la fine delle forniture di bombe usate per colpire la popolazione dello Yemen ha dichiarato quanto segue.
“Esprimiamo soddisfazione per una decisione che avrebbe dovuto essere presa e che avevamo sollecitato da tempo. Il comunicato della RWM Italia fa correttamente riferimento agli indirizzi espressi dal parlamento con la risoluzione approvata dalla maggioranza il 26 giugno e dal Consiglio dei ministri il 12 luglio. Quest’ultima decisione, tuttavia, è stata solo riferita sui social dal viceministro del Consiglio Di Maio e continuiamo a sollecitare l’invio di un atto ufficiale”.
Del Coordinamento fanno parte: Amnesty International Italia, Comitato per la riconversione RWM e il lavoro sostenibile, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari Italia, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Save the Children Italia.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in INTERVENTI, In Evidenza.
Da: Elena Buccoliero
Gentile Direttore,
desidero fornire alcuni chiarimenti ai lettori e in particolare al signor Paolo Pennini che, a proposito della necessità di un’indagine sul lavoro dei Servizi Sociali ferraresi per i minori, mi ha chiamata in causa in un suo intervento su Ferrara Italia, il 24 luglio scorso, tratteggiando la mia attività in modo per molti versi impreciso. L’occasione mi è gradita come possibilità di informazione e riflessione su temi sensibili.
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Non esiste una “fondazione regionale contro il reato sui minori (!)”, così come ha scritto il signor Pennini, bensì una Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. Tra gli interventi più recenti ricordo gli aiuti alle famiglie delle due donne uccise nell’incendio doloso che ha colpito la sede della Polizia Municipale di Mirandola, ai bambini orfani dopo il femminicidio del febbraio 2019 a Modena, ai familiari del giovane di Zocca freddato da un ragazzo poco più giovane nel settembre scorso. Tra i casi ferraresi, il sostegno ai familiari di Marcello Cenci, Pier Luigi Tartari, Roberto Tosi Savonuzzi.
La Fondazione e-r per le vittime dei reati è una realtà unica in Italia, in linea con quanto le direttive europee richiedono a tutti gli Stati membri in tema di supporto alle vittime. Avviene infatti che, nel nostro Paese, chi subisce un reato anche gravissimo avrà (forse) un risarcimento dopo anni, a procedimento penale concluso, ma prima di allora – salvo appartenga ad alcune tipologie specifiche, es. vittime di usura, terrorismo, mafia… – viene lasciato solo ad affrontare tutto ciò che dal reato discende: difficoltà economiche, problemi sanitari o di assistenza, esiti traumatici di ogni genere.
Proprio per questo sin dal 2004 l’Emilia Romagna volle dotarsi di un organismo specifico e autonomo che ha per soci fondatori la Regione, le Province (restano ormai solo sulla carta) e i Comuni capoluogo, cui si sono uniti negli anni altri Comuni o Unioni e l’Università di Parma. Suo compito è sostenere tutte le vittime di gravissimi reati dolosi, siano essi uomini, donne o bambini.
Ad oggi parliamo di oltre 700 persone aiutate. Quasi la metà sono minorenni, in massima parte in quanto vittime indirette delle violenze sui genitori (maltrattamenti sulla madre, femminicidio, omicidio del padre, lesioni gravissime), molto più raramente perché vittime di violenza, in famiglia e non solo. Per questi ultimi si sconta l’assenza di servizi pubblici specifici sul maltrattamento e abuso all’infanzia, che sarebbero invece previsti dalla norma e assolutamente necessari.
Mi occupo di questa Fondazione dal 2014 e non ne sono la presidentessa, come scrive il signor Pennini, ma la direttrice. La differenza è rilevante: il Presidente – attualmente Carlo Lucarelli – oppure il suo Vice, insieme ai due Garanti (nominati, tutti, dall’Assemblea dei Soci e operanti a titolo gratuito) decide gli aiuti alle vittime; la direttrice, più modestamente, cura i passaggi attuativi e contribuisce a far conoscere la Fondazione, perché sia accessibile a chi ne ha bisogno e abbia le risorse per poterle aiutare. In questi anni la Fondazione ha accolto istanze provenienti dai Sindaci di tutta la regione, inclusi quelli della Val d’Enza. I rapporti intrattenuti con i Comuni di quel territorio sono spiegati in modo articolato dal presidente Carlo Lucarelli in un comunicato consultabile qui.
L’impegno a favore di bambini e adolescenti
Non lavoro per Asp, come erroneamente ritiene il signor Pennini. Sono una dipendente del Comune di Ferrara, part-time, presso l’Ufficio Diritti dei Minori nel Settore dei Servizi alla Persona.
L’ufficio, peculiarità tutta ferrarese, nasce nel 2013 per sostenere la rete degli interventi di protezione dei minori, dalla scuola, ai servizi territoriali, all’associazionismo dedicato. Il patto fin dal principio fu che, essendo giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dal 2008, non mi sarei mai occupata di singole famiglie, proprio per non incorrere in casi di conflitto d’interesse, ma avrei svolto interventi di supporto al sistema nel suo complesso.
Collaboro con altri settori comunali e con molti enti esterni (scuole, Prefettura, Università di Ferrara, Ufficio Scolastico Territoriale, tutti i servizi sociali della provincia, AUSL, associazioni…) e non entro nel merito di singole vicende familiari, né potrei farlo, anche se questo ha comportato qualche diniego a famiglie che speravano di trovare in me un mediatore nel rapporto con i servizi.
Sono una sociologa. Mi sono occupata dei temi trascritti dal signor Pennini con azioni di ricerca, organizzazione di convegni o corsi di formazione, coordinamento di gruppi di lavoro, formazione e supporto ai tutori volontari per MSNA istituiti con la l.n. 47/17. Svolgo moltissimi incontri con insegnanti, studenti o genitori per spiegare le logiche e le possibilità della giustizia penale minorile e ho realizzato su questo materiali di divulgazione, come pure sulla violenza assistita, sull’affido, o sull’impatto della violenza nella vita dei sopravvissuti.
Tra i temi sensibili affrontati vi è certamente quello dei bambini fuori famiglia, su cui la nostra città è probabilmente più aggiornata di altre, e il mio è ancora una volta un compito di analisi. Il primo report è stato redatto sui dati del 2015, il successivo studio al 31.12.17 illustrato il 12 luglio 2018 in Commissione Consiliare, luogo per eccellenza di dibattito politico su temi complessi, e conservato agli atti di quell’audizione. Ne è seguita l’organizzazione di una visita alle strutture cittadine di accoglienza per una rappresentanza di consiglieri comunali di differenti parti politiche. La visita è avvenuta il 9 marzo 2019 e ha riguardato una comunità per minori, una casa-famiglia e una comunità madre-bambino.
Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.
Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’
AI FENICOTTERI IN VOLO
Una nuvola rosa passeggia nel cielo
Bassa
Sopra il dorso del mare
Scivola
Quasi sembra volare
E questa fantasia di cipria
Sul volto sbarbato del vento
Il sole esalta
Come un fiore
Fatto di un bosco di petali
Le parole si sgonfiano nell’inseguire tale bellezza
Perdono fiato e luce
Mentre la nuvola passa
E smarrisce il suo smalto
Che vola lontano
Un fiore
Di cespi di petali
La cipria
Di Venere
Questi uccelli che compatti volano simulando i tramonti
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in STORIE & RACCONTI, In Evidenza.
di Maurizio Olivari
VORREI
Vorrei
camminare stretto a te
per le strade di un paese
anche senza nome,
lasciare che dicano di noi
sono felici, sono innamorati.
Vorrei
salutare con te
un vecchio stancamente appoggiato al muro di casa
tristemente avvolto dai suoi ricordi.
Vorrei
dire ciao ad un bambino
che gioca allegro nel cortile
con la palla di stracci
dai mille colori.
Vorrei
camminare stretto a te
vicino al mare
che schiaffeggia il molo
e dire buongiorno
ad un marinaio senza età
che accarezza le reti del suo domani
Vorrei
distendermi accanto a te
quando la luna
diventa regina del cielo
e dirti buona notte Amore
continuo a sognare.
DRINK
Ci siamo ubriacati
con 1/4 di passione
1/4 di dolcezza
un pizzico di complicità
1/4 di allegria
una spruzzata di fantasia
due cubetti di sesso.
Ci siamo ubriacati
col nostro amore
shakerato.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.
Da: Save the Children
Save the Children al Giffoni film Festival per parlare di diritti dell’infanzia
In occasione del centenario dell’Organizzazione, martedì 23 luglio alle ore 17, intervento di Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia- Europa di Save the Children ed autrice del libro “I figli dei nemici”, storia di Eglantyne Jebb, fondatrice dell’Organizzazione
Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, Film Festival domani incontra i giovani del Giffoni 23 luglio alle 17, nella Sala Blu della Multimedia Valley.
Un interessante dibattito vedrà i ragazzi dialogare con Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia – Europa di Save the Children ed autrice del libro “I figli dei nemici” edito da Rizzoli, in cui si ripercorre la nascita dell’Organizzazione ad opera di una donna straordinaria, Eglantyne Jebb che nel 1919, all’indomani della Prima Guerra Mondiale, decise di soccorrere i bambini austriaci e tedeschi che morivano di fame a causa del blocco navale imposto dalle nazioni vincitrici.
Tanti gli argomenti che saranno toccati nel corso dell’incontro, a partire dal centenario di Save the Children, ripercorrendo la sua storia, per atterrare alle sfide attuali per tutelare l’infanzia. Cento anni di storia segnati da emergenze umanitarie, in Italia e nel mondo, in cui a pagare il prezzo più alto sono stati i bambini. Ieri come oggi, dalle due Guerre Mondiali alla tragedia dei bambini del Biafra, dai conflitti in Vietnam e nella ex Iugoslavia al genocidio ruandese e alla terribile carestia degli anni ’80 in Etiopia, sino ad arrivare agli orrori vissuti oggi dai bambini in Siria e in Yemen. E ancora tutti gli interventi oggi sui fenomeni che hanno un forte impatto sulla vita di milioni di bambini, come la povertà educativa e la dispersione scolastica, passando per le disuguaglianze e le discriminazioni in Italia.
Il fil rouge sarà quello dei diritti: proprio Eglantyne Jebb, infatti, fu in grado di anticipare il concetto, rivoluzionario per l’epoca, che anche i bambini fossero titolari di diritti, e scrisse la prima Carta dei Diritti del Bambino, adottata poi dalla Società delle Nazioni e che successivamente ispirò l’attuale Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che proprio quest’anno compie 30 anni.
La masterclass, rivolta ai giovani, intende anche promuovere una riflessione relativa alle ragioni dell’esistenza delle organizzazioni e dell’impegno umanitario, a si può proteggere e promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza oggi, anche attraverso importanti iniziative di partecipazione attiva dei ragazzi.
Scritto da Gianni Venturi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, Diario in Pubblico, In Evidenza.
“Spesso la noia di vivere ho provato. Era il lamento del gabbiano sopra la casa e il degrado del Laido abbandonato”.
Per dare dignità (?) pseudo letteraria alle mie sempre più insofferenti calate marine al Lido/Laido degli Estensi mi affido al Poeta ricordando con estrema nostalgia gli anni felici al Forte dei Marmi quando Eusebio/Montale soggiornava all’“Alpe Mare” e noi si viveva in collina. Unico legame tra le due villeggiature marine là il Bagno Blu di Marina di Pietrasanta, qui l’“Onda Blu” .
Arriviamo stremati, carichi di bagagli e di libri, sollecitamente aiutati dai nostri ‘scudieri’. Mi aspetta il sacrario canoviano di stampe e oggetti trasferiti da Firenze e da Bassano del Grappa a cui aggiungo il poster dell’ultima conferenza tenuta assieme all’amico carissimo Andrea Emiliani per la presentazione del suo fondamentale volume Opere d’arte prese in Italia nel corso della Campagna napoleonica 1796-1814 e riprese da Antonio Canova nel 1815 (Carta Bianca, 2018). Un altro pezzo importante della mia vita che se ne è andato con la scomparsa dell’amico e Maestro.
Lento pede mi dirigo al bagno costeggiando i ruderi di un hotel un tempo glorioso, ‘La conca del Lido’; sul muro perimetrale a caratteri colossali s’inneggia all’organo femminile “W la f…” che campeggia orgogliosamente come se fossimo in qualsiasi periferia degradata dell’Italia di oggi. Buche nella strada sconnessa ti accompagnano fino al supermercato che si sa ormai rappresenta il luogo per eccellenza degli ‘itagliani’. Incuranti e sprezzanti delle esigenze del turismo a luglio avanzato si decide di rifare marciapiedi e strade e di rinnovare la rete idrica; così l’ultimo tratto della nostra via risulta ancora impercorribile per lavori e dall’alto il gabbiano detta il ritmo del lavoro con urla scomposte e, come direbbero i pronipoti che debbono percorrere la strada per arrivare al paradiso dei giornalini, grandina cacca sui passanti. Di conseguenza corro a comprare un telo per proteggere la macchina che installato alle ore 13 alle 17 è già stato rubato. La gelida poliziotta a cui telefono mi dice, incisiva, che è assolutamente proibito coprire le macchine sul suolo pubblico ma solo su quello privato; tuttavia, al massimo, ci avrebbero fatto la multa, ma rubare il telone, no! Quello no. Tremante ringrazio e mi propongo di dare lavoro ai lava macchine che puliranno il prodotto escrementizio dei gabbiani.
Sui viali in attesa dello smantellamento della ‘folie’ inventata anni fa da una celebre archistar bolognese è tutto un fiorire di cartelli: ‘vendesi’, ‘affittasi’. La notte, un lugubre silenzio sovrasta il centro nemmeno più interrotto da qualche spettacolino da ‘café chantant’ e allora il cuore si scioglie e mi ritrovo a rimpiangere il Lido d’antan. Le serate al cinema o a sentire qualche cantante famoso, quasi fossimo in un romanzo di Bassani. Alla storia non si può sfuggire specie se si era un giovane intellettualino allevato in Toscana ma sempre con le radici saldamente ancorata alla città dalle cento meraviglie. Molti mi rimproverano e mi domandano “ ma perché ci vai”? E non regge la scusa evidente di evitare l’afa della città, per un’afa altrettanto potente del mare. Al bagno, imbarazzatissimi, mi dicono che è proibito recarsi in bicicletta fino all’ultima fila di ombrelloni, un percorso di circa 4/500 metri, perciò mi si offre un ombrellone appena fuori lo stabilimento dove il mare s’intravvede in lontananza: Faute de mieux, in mancanza di meglio, accetto la situazione addolcita dall’idea che l’anno prossimo si attrezzeranno con carretti semoventi per la gioia dei diversamente giovani. Il mio amico, il bagnino Luca, laureando in filosofia del linguaggio, capitano, mi pare, della squadra di hockey, mi sorride tra l’arruffìo della barba bionda, pronto a segnare l’ultimo libro che sto leggendo. Mi offro di prestarglielo, ma lui sorride e mi confessa che i libri li vuole avere. Bravoooooo!
Siamo circondati da campi di Beach Volley dove ragazzetti decenni giocano tra una imprecazione e talvolta una bestemmia amorosamente accuditi da parenti e amici.
Sorge allora la nostalgia delle vacanze montane Mi sveglio la mattina con l’odore penetrante dei tigli che mi ricorda tempi felici e mestamente ritorno al presente e l’addio all’amatissima Sterzing- Vipiteno. Qui per undici giorni si svolge l’Orfeo Music Festival 2019, la manifestazione che porta a Vipiteno straordinari musicisti, direttori d’orchestra, cantanti, virtuosi di strumenti, quattro direttamente dal Bolshoi, che insegnano a selezionati giovani. Poi- meraviglie delle meraviglie- due volte al giorno un concerto gratuito nella sala del Municipio e dopo quello del pomeriggio, il ritorno in hotel sul calessino trainato dai miei ragazzi-cavalli, Poldo e Paghira.
Così si consumano i ritorni mentre sulla spiaggia infuocata risuona mestamente la domanda: “ma il sindaco di Comacchio che fa?”
Silentium.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in In Evidenza.
Da: Save the Children
Migranti: Save the Children, è necessaria una solida riforma delle norme dell’UE per proteggere i diritti dei bambini
In occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni di questa settimana, l’Organizzazione chiede che venga ridiscusso l’accordo di Dublino
Per proteggere i diritti dei bambini che hanno affrontato il pericoloso viaggio attraverso il Mar Mediterraneo, sono necessari profondi cambiamenti delle regole dell’UE in materia di migrazione. È questa la richiesta che Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, rivolge in occasione dell’incontro dei ministri della giustizia e degli affari interni dell’Unione Europea, che si riuniscono questa settimana per discutere delle politiche migratorie all’interno dell’UE.
Il rinnovo di Parlamento e Commissione Europea, potrebbe essere l’occasione per interrompere l’attuale situazione di stallo e concordare regole volte a condividere le responsabilità legate all’arrivo di migranti e rifugiati alle frontiere dell’Europa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare il loro impegno per la protezione della vite in mare e scongiurare ulteriori morti di bambini, donne e uomini in fuga dalla Libia.
Anche se sempre meno rifugiati e migranti attraversano il Mar Mediterraneo, dai dati emerge che si alzano le probabilità di morte – nel 2018, 1 persona su 14 è morta affrontando il viaggio via mare, mentre nel 2017 era 1 su 38 persone. Nel frattempo, continuano a accendersi dibattiti sullo sbarco in sicurezza dei migranti, anche dei bambini.
Mentre la situazione della sicurezza in Libia peggiora giorno dopo giorno, i rifugiati e i migranti hanno poche opzioni: o rimangono intrappolati nel Paese o fuggono attraverso il Mediterraneo o il deserto nigerino. Solo una minoranza è stata evacuata e reinsediata dalle Nazioni Unite in altri paesi.
Save the Children supporta i bambini migranti e rifugiati in Italia e in Spagna: supportiamo i minori che soffrono di ansie, paure e disorientamento dopo essere stati detenuti in Libia e aver vissuto il terribile viaggio attraverso il Mediterraneo. Le vite di questi bambini e delle loro famiglie non dovrebbero essere negoziabili.
“I negoziati sul regolamento di Dublino, che disciplina l’accoglienza dei richiedenti asilo che arrivano nell’UE e per i quali ogni Stato membro è responsabile, sono stati bloccati per troppo tempo. Chiediamo al nuovo Parlamento, alla Commissione e al Consiglio di riavviare i negoziati e concordare una riforma che ponga i diritti dei bambini al primo posto. Ora è il momento per tutti gli Stati membri dell’UE di trovare una modalità sostenibile per condividere la responsabilità dei richiedenti asilo in arrivo, garantendo un giusto equilibrio tra gli Stati in prima linea, come l’Italia e la Grecia, e stati chiave per l’accoglienza di richiedenti asilo come Germania e Svezia” ha dichiarato Anita Bay Bundegaard, direttore e rappresentante dell’UE per Save the Children.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre proteggere la vita dei migranti e dei richiedenti asilo che attraversano il Mediterraneo, tra i quali ci sono molti bambini, e cooperare per garantire gli sbarchi delle persone soccorse, in maniera rapida e sicura. Save the Children sottolinea che questo dovrebbe essere fatto in modo coordinato e focalizzato sulla ricerca di una soluzione tra la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE.
“Chiediamo ai ministri europei che parteciperanno al Consiglio Giustizia e Affari interni di dimostrare che vogliono portare l’Europa fuori da questa situazione di stallo e mettere al primo posto la sicurezza e la dignità dei bambini” ha concluso Bay Bundegaard.
Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in In Evidenza, COMUNICATI STAMPA.
Da: Save the Children
Terremoto Centro Italia: Save the Children, l’inaugurazione della nuova scuola di Amatrice notizia che apprendiamo con gioia per i bambini e le bambine del territorio
L’Organizzazione ribadisce l’importanza di garantire la continuità scolastica per i minori colpiti dalle emergenze e il diritto a una scuola sicura nelle aree sismiche
“Apprendiamo con gioia la notizia dell’inaugurazione della nuova scuola per i bambini e le bambine di Amatrice: un luogo di apprendimento e aggregazione fondamentale per il loro futuro e che segna una tappa molto importante per la vita della comunità e per il processo di ricostruzione in corso”, ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children, in occasione dell’inaugurazione della nuova scuola “Romolo Capranica”, alla quale è presente anche l’Organizzazione.
“Già dai giorni immediatamente successivi al sisma del 24 agosto 2016, i bambini e i ragazzi di Amatrice hanno avuto la possibilità di continuare a studiare e apprendere nella scuola provvisoria costruita a tempo di record dalla Protezione civile del Trentino. Dopo l’abitazione, la scuola è infatti un elemento cruciale per i bambini colpiti dalle emergenze e garantire loro la continuità scolastica, in un contesto tanto delicato, è essenziale per la loro crescita e per il loro benessere. Questo è stato il senso che sin da subito ha guidato anche l’intervento di Save the Children, con i nostri operatori che già dalle ore immediatamente successive al terremoto hanno allestito, nel campo gestito dall’Agenzia Regionale di Protezione civile della Regione Lazio, il nostro Spazio a misura di bambino, la scuola bianca – come la chiamavano i bambini di Amatrice – dove poter giocare, apprendere e stare insieme ai loro coetanei in un ambiente sicuro e protetto”, ha proseguito Raffaela Milano.
“In questi quasi tre anni siamo stati al fianco dei bambini di Amatrice, e delle altre aree colpite dal terremoto, e abbiamo potuto conoscere la loro resilienza e il loro grande desiderio di continuare a studiare, coltivare le loro passioni e seguire i loro sogni. La ricostruzione della scuola Romolo Capranica è un esempio importante, che auspichiamo fortemente possa essere replicato anche in altre zone, dove altri bambini continuano a vivere in condizioni di precarietà e necessitano di interventi adeguati, a partire dalla scuola, che non possono essere ritardati ulteriormente. È infine fondamentale assicurare ai bambini che vivono in aree sismiche il diritto a una scuola sicura. In tal senso, proprio per garantire la sicurezza scolastica di tutti i minori e del personale nelle scuole italiane, abbiamo presentato, insieme a Cittadinanzattiva, un Manifesto di nove punti per una proposta di legge che superi l’attuale frammentazione normativa e garantisca spazi sicuri e protetti per l’apprendimento e l’istruzione”, ha concluso Raffaela Milano.