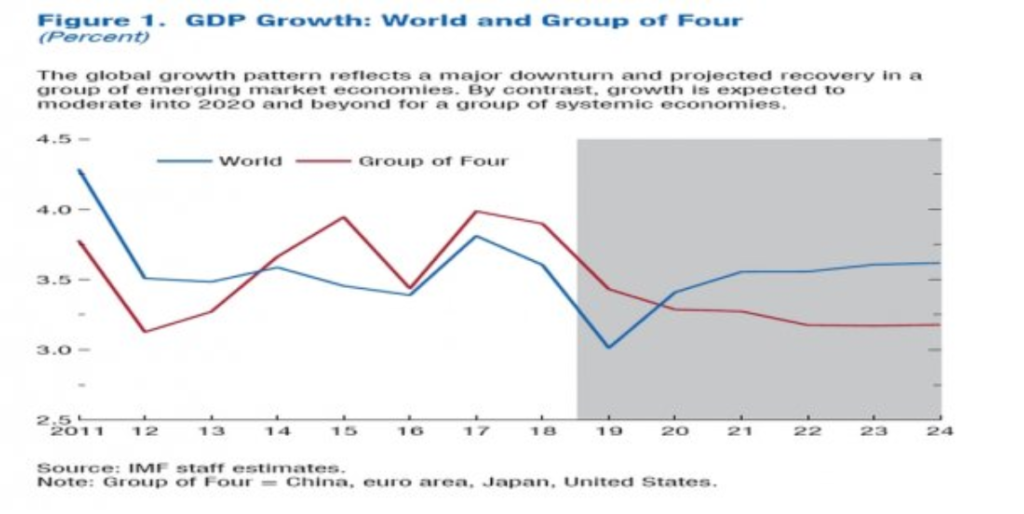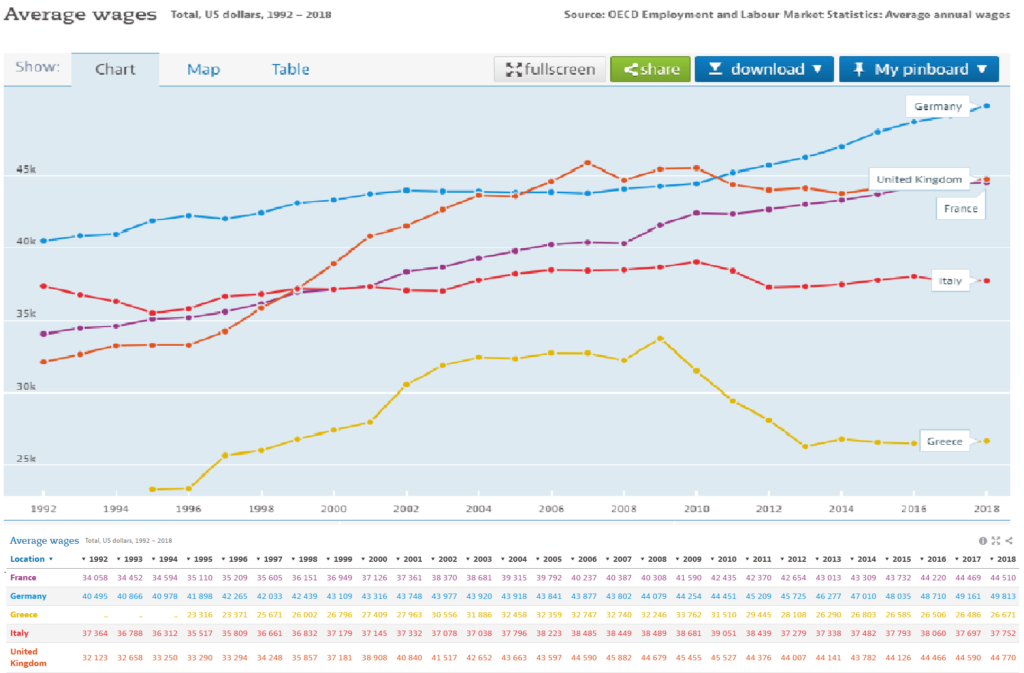Vite di carta /
La noncuranza con cui lascia cadere nel vuoto le parole
Vite di carta. La noncuranza con cui lascia cadere nel vuoto le parole
Molte cose accadono di mercoledì. Da molti anni registro che accadono perché al mio paese è giorno di mercato: aumentano le auto in circolazione, molte persone escono dalle case o affluiscono dai paesi vicini e dalla campagna per aggregarsi nella piazza.
Abbiamo una piazza grande a Poggio Renatico ed i banchi del mercato sono numerosi e vendono un po’ di tutto. Chi deve fare la spesa settimanale, oppure ha bisogno di andare per uffici aspetta il mercoledì; di mercoledì si possono depennare dalla lista delle commissioni da fare quasi tutte le voci, e se si arriva presto in piazza e non c’è troppa gente si riesce a fare tutto. Viva l’efficienza, che quando siamo indaffarati (e cioè, quasi sempre) diventa un valore.
Per me che ne scrivo il mercato del mercoledì assume da sempre un bel po’ di significati aggiunti. Mi entra in circolo una umanità così piena di umori che mi fa scattare dentro una sorta di corto circuito, e allora vanno a braccetto quotidianità e letteratura.
Anch’io faccio i miei giri entrando e uscendo dalla piazza, e mi fermo a parlare con tutte le persone che mi conoscono; molte di loro riesco a incontrarle solo in questo giorno della settimana. Pure, un doppio fondo nella mia valigia di parole mi accompagna e mi fa sentire la mia voce mentre parlo, mentre ascolto o mentre rispondo a domande. Mi fa stare dentro e fuori al tempo stesso.
Eccomi per esempio in una estate di molti anni fa, durante la mia adolescenza. Sono in piazza con mia madre che è la regina tra le bancarelle, conosce tutti i venditori sia che si tratti di compaesani, sia che vengano dai dintorni.
Il più distante è di San Pietro in Casale (inutile dire che la globalizzazione non c’è ancora) e parla un dialetto bolognese molto marcato. Ha un banco di scarpe molto belle, che espone in base ai prezzi raggruppando sotto la stessa cifra, in lire, i modelli più diversi e dai colori variopinti. Sono tutte scarpe da donna e sono campioni.
Oggi il venditore è più sornione del solito. A chi gli chiede se può provare un certo paio di scarpe risponde sì con la testa; chi invece gli chiede se ha l’assortimento dei numeri di un certo modello non ottiene risposta. Mia madre, che di scarpe e di pellami se ne intende, sferra un attacco dopo l’altro. Gira e rigira tra le mani un bel paio di mocassini color verde tenero, dalla linea affusolata e aggraziata, che mi invita a calzare. E intanto chiede di quale ditta sono, osserva che il pellame è di buona qualità, fa le prove per verificarne la morbidezza, mi sottrae e poi tiene con le due mani la scarpa destra e la piega ad arco trovando che si flette che è un piacere.
Io intanto. Mi trovo in mezzo tra l’entusiasmo di lei, così ciarliera in questo suo giretto del mercoledì (è l’unico svago che si prende durante la settimana, per molte ore ogni giorno la vedo seduta alla macchina per cucire, per cucire la pelle) ed il silenzio incantato che avvolge lui.
E ancora una volta lievito al di fuori dalla situazione; vedo mia madre e il venditore bolognese incastonati come diamanti in una bambagia dorata. Il caldo di luglio è appiccicoso come il miele. Le parole che lei ha pronunciato passano scavando piccoli cunicoli sospesi; sono tutte dirette verso di lui che è raggiunto dai tanti spruzzi di miele sonoro. Ma non parla.
Come? E la comunicazione dov’è? Mi sento indispettita per la noncuranza con cui lascia cadere nel vuoto le parole. Ho nella testa ben demarcate le liste di quello che si fa e di ciò che non si deve fare, come su di una lavagna quando alla scuola elementare tiravamo una riga centrale per scrivere i buoni da una parte e i cattivi dall’altra.
Devono passare molti anni prima che io ritrovi la serena accettazione di mia madre nelle parole di un poeta. Leggo i testi che il grande Eugenio Montale ha scritto per la moglie Drusilla, quando rivela di lei la capacità di capire gli uomini “anche al buio” col suo “radar da pipistrello”. La Drusilla che dando il braccio al poeta ha sceso con lui le scale della vita ed ha mediato sapientemente il rapporto del marito con la quotidianità.
Come la Drusilla, mia madre ha capito che il bolognese è stanco, oggi. Oppure è avvilito per qualcosa. Va comunque lasciato “nel suo”. Le persone sono così: non c’è alcun bisogno di esprimere giudizi per una volta che sono “spastati”.
E così dai miei libri, dai tanti che ho letto, come se una seconda madre mi stesse parlando, ho imparato. E ancora leggo, e imparo ogni volta. Anche se non è mercoledì.
Sono davvero tanti. Da esprimere uno alla volta finché potrà avere vita questa rubrica.
Incomincio.
Per leggere gli altri articoli e indizi letterari di Roberta Barbieri nella sua rubrica Vite di carta, clicca [Qui]