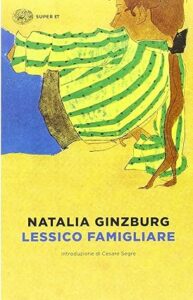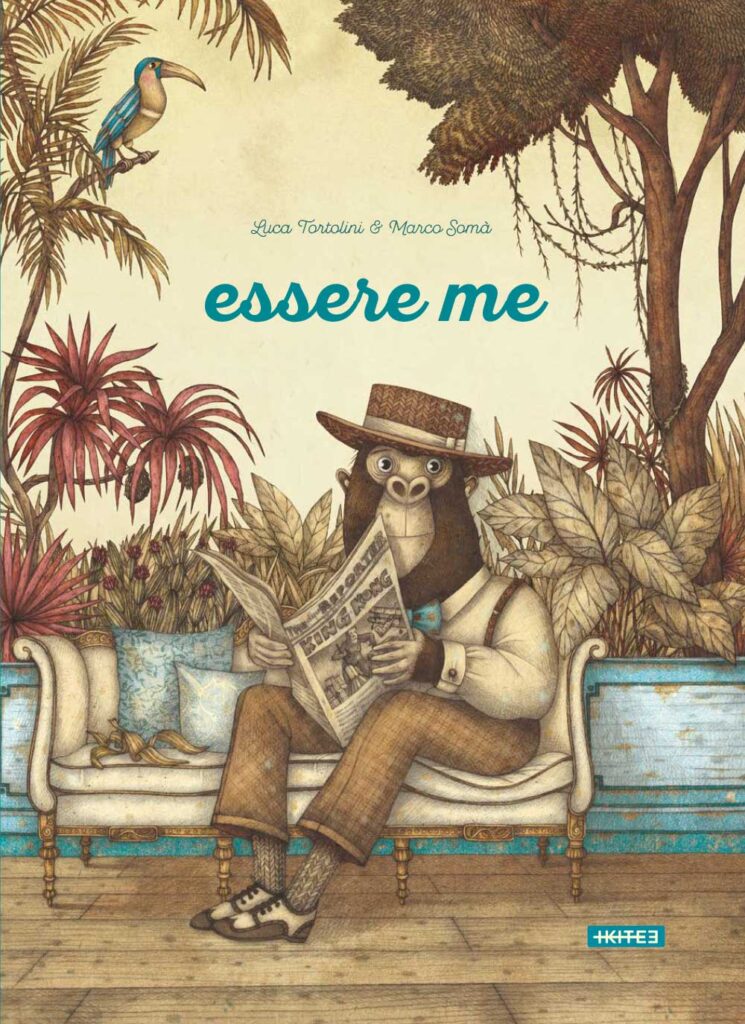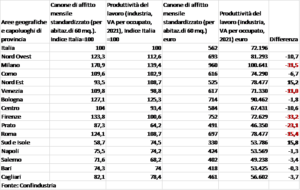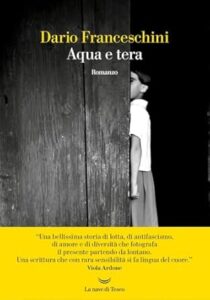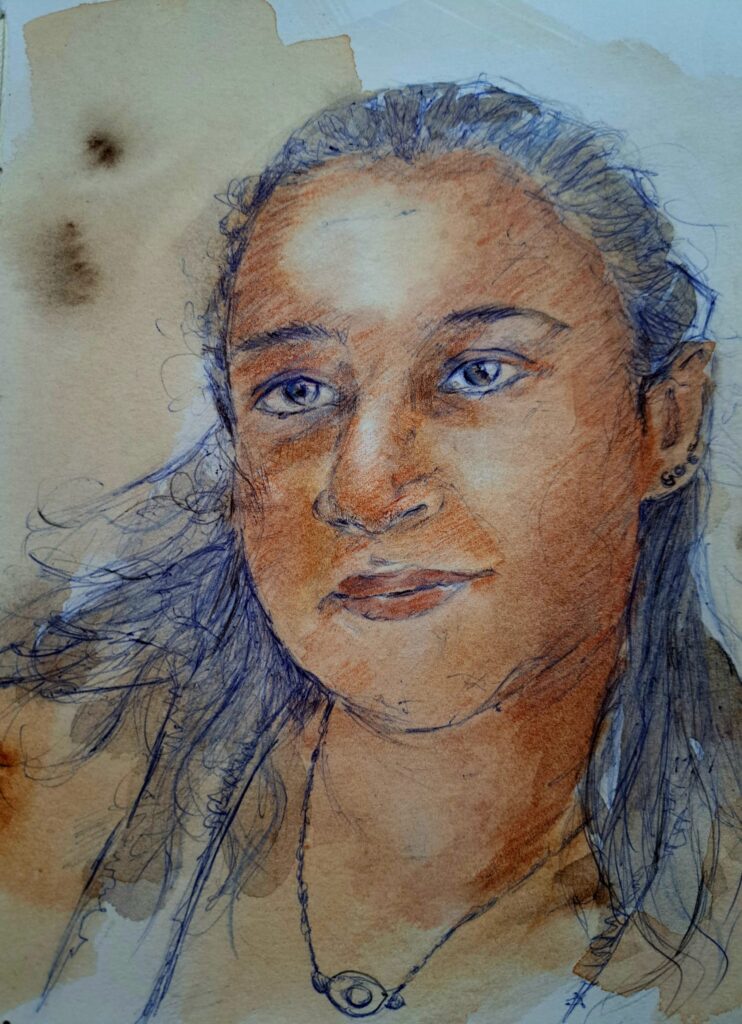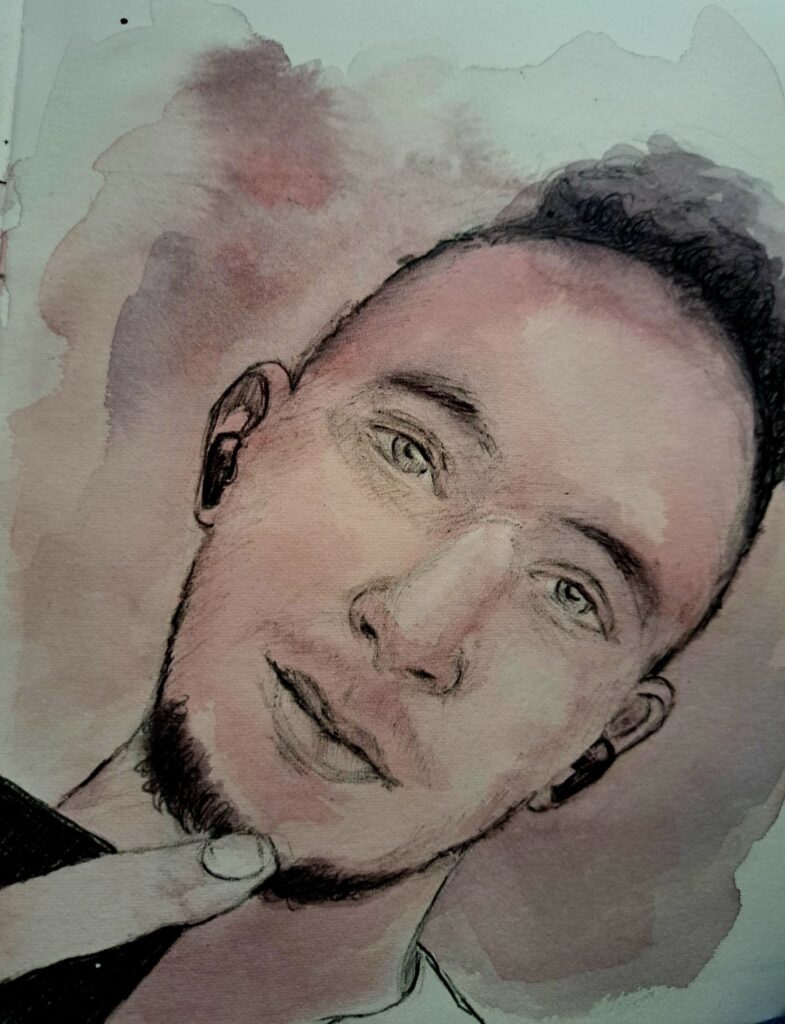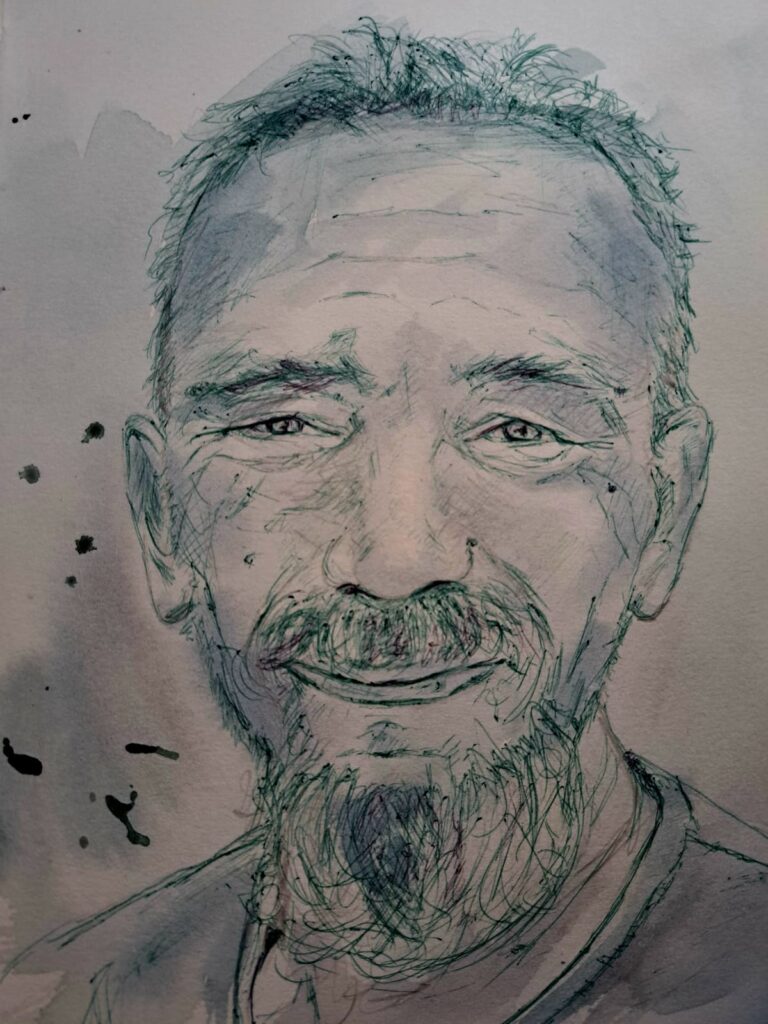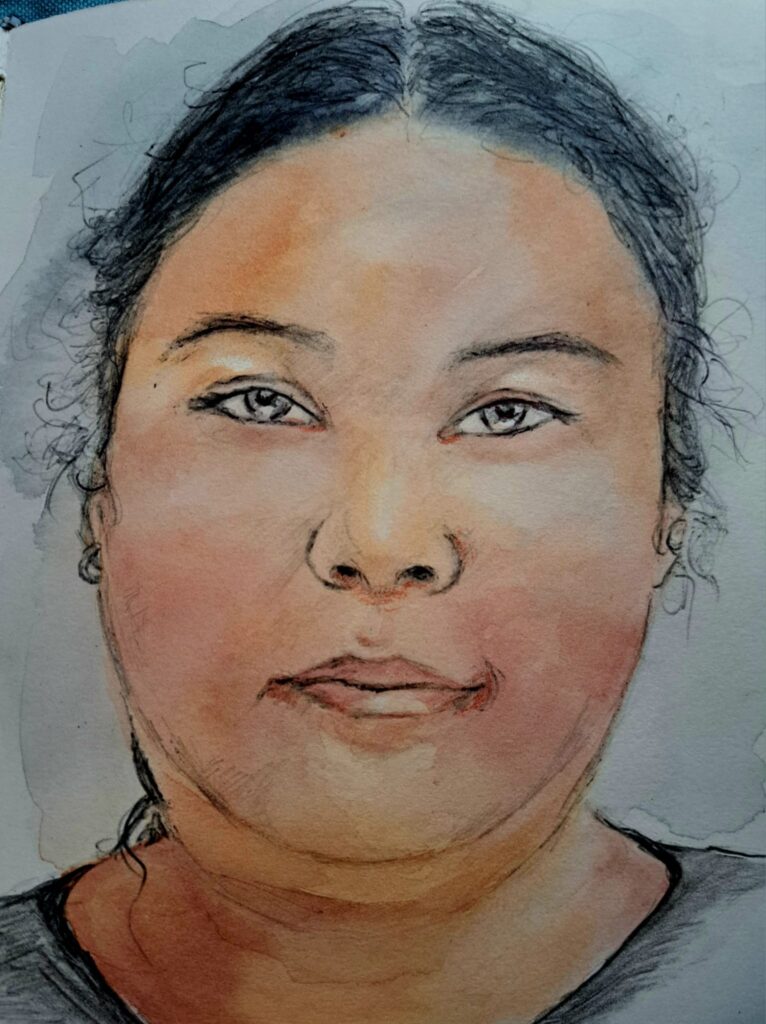La fine di una pandemia. Riflessioni sulla società del covid
Ansia, angoscia, senso di oppressione.
Morirò? Cosa potrebbe mai capitarmi se uscissi da quella porta?
Di certo quello che ci rimarrà della pandemia del covid è LA PAURA: la paura della morte, la paura della solitudine, e l’entità di tutto ciò, che già prima di ogni lockdown ci angosciava, sicuramente è triplicata, ad ogni dpcm, mentre li leggevamo al chiuso, bloccati, imprigionati nei nostri pensieri, nel silenzio raggelante della nostra più profonda angoscia.
Silenzio perché quelle paure, che dapprima erano solo vocine, piccoli titoli di giornali, hanno incominciato a crescere, progressivamente, fino a diventare onnipresenti, nella nostra mente, intorno a noi, diventando emozioni sempre più forti, spesso represse, forse perché timorosi di perdere l’autocontrollo, di esprimere un parere diverso da quello generale, o per semplice senso del pudore, pudore nel mostrarsi fragili, in preda al panico, più che giustificato dalla situazione, ma che ci mostrava per quello che siamo: costantemente soggetti al potere della morte.
Quelle paure si sono progressivamente ingigantite, fino a diventare una sorta di pane quotidiano, che però, al posto di nutrirci, ci stava consumando. Insieme alla quantità di titoli di giornali sempre più minacciosi, a telegiornali che non lasciavano ormai nessuno spazio a dubbi, a talk show che usavano tutt’altro che gentili vocine per diffondere la paura della morte, i nostri tentativi di mantenere la calma iniziavano a tracollare, e i nostri silenzi, immensi emblematici silenzi, iniziarono a tramutarsi in angoscia repressa, attacchi di panico senza voce, pianti misti al terrore di non farcela più a tenere dentro tutto quel peso.
Questa ovviamente potrebbe rispecchiare una situazione più che generale: il corona virus ha innestato nei nostri cervelli un senso di paura dilagante, che sicuramente ha messo a dura prova la serenità di chiunque.
La progressiva sensazione di sentirsi braccati come prede indifese di un animale mostruoso, che trucida le sue vittime senza alcuna pietà, è un’idea che senza alcuna remora è stata diffusa tra la popolazione mondiale, la quale, in un batter d’occhio, si è sentita attaccata e perseguitata da una nuova minaccia di morte.
La speranza a poco a poco ha iniziato giustamente a scemare: cadaveri in sacchi neri, morti in casa senza che nessuno accorresse, ospedali pieni, costi esorbitanti di mascherine, igienizzanti, dispositivi di protezione di ogni sorta hanno iniziato a lievitare, giusto per essere sicuri di dare il colpo di grazia. Un colpo di grazia che in realtà era ben lungi dall’arrivare, perché quello era solo l’incipit di una storia dell’orrore.
All’improvviso arrivano i vaccini, la salvezza assoluta… o almeno così era stato detto. Ci sono le cure! Non ci sono le cure! I vaccini ci salveranno! I vaccini non ci salveranno! E intanto spunta la tessera verde, un LASCIAPASSARE, il condono ufficiale per quello che fino a due anni prima erano normali diritti di un cittadino.
Il senso? Non si è capito bene ancora tutt’ora, e persino quelli che all’inizio sembravano aver preso bene l’inserimento quasi ossessivo di una sfilza di norme che si andavano ad aggiungere all’ansia, alla paura, all’isolamento che creava già di suo il covid, hanno iniziato progressivamente a stancarsi.
Questo articolo si limita ad un’analisi superficiale da un punto di vista psicologico di come tutto questo, tutta questa serie di sfortunati inspiegabili eventi abbiano avuto ripercussioni sulla salute psichica di tutta la popolazione.
Dapprima la pandemia, un virus sconosciuto che può in pratica soffocarci in pochi giorni, si diffonde in tutta fretta nel mondo, senza darci nemmeno il tempo di abituarci all’idea. I prezzi di ciò di cui avevamo più bisogno in quel momento si alzano in maniera sproporzionata, quasi sadicamente, i dispositivi di protezione acquistano il valore dell’oro, quasi come se si stesse cercando di far soldi sul dolore, la paura, la morte.
Stessa cosa avviene nei giornali: titoloni apocalittici, incentrati unicamente su una sola cosa, suggerimenti di articoli che gridano morte ci capitano persino mentre cerchiamo di acquistare in santa pace un nuovo frullatore online. La notizia ha puntato tutto sul dolore e la paura, tallone d’Achille di chiunque fin dall’alba dei tempi.
La pandemia c’è stata, un nuovo virus ha ucciso senza pietà milioni di persone nel mondo, ha obiettivamente aggiunto dolore ad altro dolore. Ma è come se il mondo, agenzie di media stampa, telegiornali, radio, talk show, tutto ciò che ha il potere al giorno d’oggi di comunicare, uniti come non mai in un’unica grande forza mediatica, avessero dato consapevolmente man forte a tutto questo dolore, un dolore che iniziava a colpire non solo il corpo, ma sembrava mirasse proprio alla mente.
Chiunque all’improvviso si è sentito circondato, da un lato, da un virus spregevole che attacca senza alcun preavviso, e dall’altro, da una società che non ha fatto altro che sottolineare la tragedia. Ora, la tragedia esisteva, ma perché fare in modo che la nostra psiche non si nutrisse di altro che di quella frustrante, logorante paura di smettere di respirare da un momento all’altro?
È come se il mondo non avesse fatto altro che rinfacciarci che saremmo potuti morire di lì a poco. Chiunque a un certo punto crollerebbe, e la fatica nell’aggrapparsi alla razionale consapevolezza che mantenere la calma e la lucidità, la serenità in casa e dentro di sé, sarebbe stata l’unica via d’uscita, è stata incommensurabile.
Un comune essere umano nel bel mezzo di una pandemia, non solo ha dovuto lottare contro la paura di contrarre la malattia, di fare tutto il possibile per evitare di toccare ogni tipo di superficie contaminata, di stare alla larga da tutti gli incontri non necessari, di aver portato con sé almeno 4 mascherine nel caso una si fosse rotta, di aver messo o meno il gel igienizzante, e l’alcool sui prodotti della spesa, e misurarsi la febbre, e di capire se la tosse ci avrebbe uccisi da un momento all’altro….
Non solo ha dovuto lottare ogni giorno per più di due anni contro la pressante tentazione di cedere al panico e alla perdita del controllo, ma in un certo senso ha dovuto lottare anche contro il totale condizionamento da parte dei media che non hanno fatto che sottolineare quanto fosse pericoloso mettere piede fuori di casa e disobbedire alle regole.
Regole così poi tanto necessarie? Rimanere chiusi in casa ha giovato a qualcuno alla fine? Costringere ad una vaccinazione sperimentale di massa ha salvato la popolazione? Per non parlare poi della consequenziale ansia che ne è scaturita per via degli eventuali effetti avversi che si sarebbero potuti verificare, che non ha fatto altro che aggiungere ulteriore angoscia alla già soffocante sensazione di perdere la propria libertà da un momento all’altro, oltre che la vita. Per carità, la vaccinazione era un mezzo, avrebbe dovuto essere uno dei tanti, non l’UNICO E SOLO.
A livello psicologico tutta questa esorbitante serie di costrizioni, tutte queste pressioni esasperanti di varia natura, non hanno fatto altro che incrementare la sensazione di oppressione e soprattutto di controllo esercitato su di noi, noi che amiamo proclamarci liberi (nel rispetto del prossimo), noi che abbiamo sempre agito rispettando noi stessi e la nostra individualità, la nostra vita e quella degli altri ( almeno teoricamente). … Tutto questo mentre la minaccia costante di perdere la vita, che puntualmente ci veniva ricordata quasi ogni ora, alitava sui nostri colli come una belva ansimante in cerca di altre vittime innocenti.
Il fatto che il vaccino ci sia stato imposto e che per molti non ci sia stata alcuna libertà di scelta sicuramente ha incentivato la nostra progressiva sensazione di essere prede perseguitate in balia di decisioni altrui, nel mirino di cacciatori, di un’entità soffocante che deliberava tutt’altro che democraticamente al posto nostro.
Che fosse stato il covid o qualcos’altro a decidere per noi, in qualche modo la nostra capacità decisionale è stata fortemente limitata, assorbita in un agglomerato informe di dpcm, isolamento, paure e il rischio di perdere una vita dignitosa.
Quello che si sta criticando qui ovviamente non sono i vaccini. Viva la scienza, viva i vaccini che ci salvano dalle malattie e viva il genio dell’uomo capace di congegnare tali scoperte. Quello che qui si sta palesemente criticando invece, sia ben chiaro, è la totale mancanza di possibilità di scelta in tutto questo, che non ha fatto altro che incrementare, anche e soprattutto tramite i già citati media quasi a reti unificate, una specie di caccia a chi la pensa diversamente, una persecuzione psicologica che si è scaraventata ingiustamente su chi non ha voluto identificarsi nel pensiero unico vigente in quel periodo.
È raccapricciante vedersi tutt’a un tratto tagliati di netto i propri diritti, un taglio sorretto da motivazioni illogiche, quelle della limitazione del contagio, che avrebbe potuto esserci anche semplicemente mantenendo i dovuti dispositivi di protezione e gli accorgimenti in merito a distanziamento e sanificazione di ambienti.
Eppure la maggior parte dei cittadini vi è stata costretta: prima, seconda, terza dose, quarta in forse, con tutti possibili effetti connessi, effetti che non ci sono mai stati nella maggior parte, è vero, ma in alcuni ci sono stati, irreversibili, gravi, come anche la morte.
E in chi fortunatamente quegli effetti non si sono mai verificati, la paura di averli, in qualunque momento, non li ha forse condotti a vivere in un clima di stress psicologico costante? La costrizione a nuove dosi, e la tessera del lasciapassare, la minaccia dell’esclusione dalla società, e la paura di nuove varianti, hanno sicuramente scatenato in tutti noi una pressione psicologica fuori dal comune.
La nostra mente può tollerare solo un certo carico di stress, poi scoppia. Soprattutto in una società come la nostra in cui di solito si tende a sottovalutare l’importanza del carico emotivo reprimendo le nostre emozioni, simulando tranquillità, quando invece tolleriamo a fatica tutto quello che ci sta capitando (per varie ragioni).
Molti si sono adattati quasi subito, altri hanno accettato malvolentieri, altri ancora hanno iniziato a soffrire. Vedersi braccati perché non ci si è voluti vaccinare, sentirsi considerati degli untori (senza alcuna motivazione scientifica), colpevolizzati perché ci si è avvalsi del diritto della libertà di scelta, è stato un ulteriore fardello gravoso per il nostro già esasperato carico emotivo.
Oltre a chi non si è voluto vaccinare per libera scelta, c’era chi non poteva per motivi di salute, chi si era stufato di inocularsi un possibile set di vaccini da 12, o chi semplicemente non ne poteva più del sempre più maniacale controllo del governo su ogni singola mossa del cittadino.
Green pass e super green pass, tamponi a prezzi esagerati per i non vaccinati, violenza immotivata in manifestazioni di protesta del tutto pacifiche, la stampa monotematica fondata su un pensiero totalmente unilaterale, lo screditamento spesso anche aggressivo nei confronti di chi gentilmente osava esporre un parere che andava anche di un minimo contro l’idea unica generale, hanno sottolineato aspetti della società del Covid a dir poco inquietanti.
Tutta questa situazione non ha fatto altro che appesantire il carico di un lavoratore medio italiano che, oltre al covid, oltre alle spese e alla cura della propria famiglia, oltre ai rincari in bolletta, oltre ad essere costretto ad un vaccino forzato pur di al mantenere il proprio lavoro, si è visto limitato in ogni sua “scelta”, vedendosi arrivare a tutta velocità un aut aut grande quanto un tir, che ha impattato inevitabilmente, e con tutta la violenza possibile, nella sua vita, in ogni suo aspetto.
La vaccinazione è importante per la prevenzione di molte malattie, ma il modo con cui, questa vaccinazione in particolare, è stata estorta, lo è altrettanto, in modo negativo, perché rileva aspetti della nostra società che credevo, ingenuamente, non esistessero. E vaccinarsi è fondamentale per combattere numerose malattie, ma che sia una scelta riflettuta, totalmente consapevole, è allo stesso tempo imprescindibile. L’imposizione coatta è pura violenza.
Il punto centrale di questo articolo non è la vaccinazione ovviamente, ma è l’insieme di provvedimenti, di modalità con cui è stata gestita la pandemia che ha fatto venire a galla una pressione sociale e di conseguenza psicologica che ha nociuto profondamente a tutti noi in maniera indistinta, lasciando strascichi che probabilmente continueranno a condizionarci ancora per anni.
Il ragazzo che si è dato fuoco il 31 gennaio 2022 potrebbe essere un esempio. Darsi fuoco. 33 anni. Nessun comportamento antisociale o sospetto rilevato precedentemente a questo terribile evento. Il culmine esasperato di una condizione psicologica portata allo stremo concretizzatosi nel peggior modo possibile? Darsi fuoco è la somatizzazione di una perdita di controllo incommensurabile.
Ma non solo perdita di controllo, anche di speranza, della capacità di attendere che tutta questa esasperante pressione sarebbe giunta al termine prima o poi. Un ragazzo giovanissimo che decide di mettere fine alla propria vita. Un desiderio macabro quanto rilevante di un possibile senso di oppressione e di frustrazione allarmanti.
Eppure è sembrato che tutto tacesse. Nessuno che si sia chiesto perché, nessuna testata giornalistica che si interessasse alle ragioni alla base di quell’atto estremo. Perché? Un’azione così grave, che a mio parere potrebbe essere considerata l’emblema metaforico di questa società del covid: il cittadino esasperato che vorrebbe darsi fuoco, ridotto al limite nelle sue capacità decisionali, di gestione della violenza psicologica subita, che ormai senza forze, si è arreso permettendo alla propria paura di divorarlo vivo.
Sembrava un incubo, eppure non lo era affatto: un mondo distopico, fatto solamente di virus assassini in cui la belva mediatica contava sistematicamente i morti, tipo caduti di guerra, ricordando sommessamente (ma nemmeno tanto) che il prossimo saresti potuto essere tu, un’economia che sembrava volerti succhiare fino all’ultima goccia di sangue, vaccini obbligatori, cittadini gli uni contro gli altri.
Come se tutto questo non fosse bastato è stato volutamente aizzato l’odio, il disprezzo, la discriminazione, basata su ingiustificati pregiudizi presentati sotto false spoglie scientifiche, e in sostanza prettamente politici, che hanno incentivato isolamento, crudeltà, ignoranza.
Ignoranza perché molti non ragionano, ma preferiscono lasciarsi trascinare dall’odio quando si ha paura. Molti prediligono la rabbia e l’aggressività alla calma e al rispetto per la libera individualità che spetta di diritto ad ogni singolo essere vivente. Ci si lascia trasportare dalla massa, che freme nel puntare furiosamente il dito contro qualcuno, piuttosto che fermarsi a riflettere, sul senso di tutto quello che sta accadendo.
Sono state aggressivamente, violentemente, negligentemente imposte delle norme che, proprio per il modo con cui sono state forzate, hanno lasciato ferite indiscusse in tutti noi, non solo da un punto di vista psicologico, ma anche fisico. Alla fine la nostra psiche governa tutto il resto, e se si fa qualcosa controvoglia questo non potrà mai portare a dei risultati positivi.
Sono stati calpestati gli individui, con la scusa di fare del bene… ma a chi esattamente? Si è dato per scontato che ciascuno di noi fosse così stupido da non conoscere cosa sia meglio per sé stesso? E anche se fosse stupido, perché hanno provato a negare persino la libertà di essere stupido? Perché qualcuno dovrebbe considerarsi degno di prendere decisioni al nostro posto, all’improvviso dichiarandoci incapaci di pensare a noi stessi?
E perché è stato usato l’odio come arma fondamentale per attaccare i pochi rimasti a pensarla diversamente?
Quante atrocità si compiono nel mondo, eppure non ho mai visto così tanto spropositato accanimento verso chi semplicemente non si è arreso nell’affermare il proprio diritto di decidere del proprio corpo… condannandolo ad essere considerato un criminale. Si è stati condannati a vergognarsi di non voler assecondare un pensiero generale, al disprezzo e alla colpevolizzazione costante di chi ha esercitato un proprio diritto, e tutto ciò è stato gradatamente normalizzato.
Normalizzare l’odio rimane terrificante, qualunque sia il contesto l’odio e l’aggressività non avranno MAI ragioni. Quasi come se esistessero ambiti e ambiti, come se l’odio fosse deprecabile in alcuni e non in altri, a volte semplicemente si giustifica, si normalizza. Tutto ciò è aberrante. Perché l’odio e la discriminazione, indipendentemente dall’ambito sono sbagliati, sempre. Privare un cittadino di libertà – una libertà sempre condizionata al rispetto degli altri, sia chiaro – è aberrante, oltretutto nascondendosi dietro bugie, inganni.
Questa è la società del covid, almeno in Italia.
L’ideale sarebbe non dimenticare, imparare che l’odio non è mai la soluzione, come anche lasciarsi andare alla paura, non dimenticare che la propria frustrazione non si risana di certo maltrattando (fisicamente o psicologicamente) un altro essere umano che palesemente non ha fatto nulla a nessuno.
Si dovrebbe imparare che la paura e l’irrazionalità vanno sempre a braccetto nella natura umana, ma che l’irrazionale rabbia che ne potrebbe scaturire in questi casi è sempre catalizzata verso mete sbagliate. La violenza non è MAI la soluzione a nulla, e se qualcuno la fomenta in qualche modo bisognerebbe prenderne immediatamente le distanze.
La società del covid non va dimenticata, perché non va dimenticata l’importanza della libertà individuale, e la libertà del prossimo, a prescindere da tutto noi siamo dalla nascita INDIVIDUI LIBERI, e se non nuociamo a nessuno, non dobbiamo sentirci in colpa solo perché facciamo quello che noi riteniamo più giusto per noi stessi. Il SENSO DI COLPA e la vergogna DEVONO ATTIVARSI quando realmente facciamo del male a qualcuno, NON RISPETTANDO LA SUA LIBERTÀ, i suoi diritti, la sua individualità.
È finita una pandemia, ma ne rimane un’altra: la pandemia dell’ipocrisia, della crudeltà umana, che si approfitta del dolore per fare soldi, la pandemia del pregiudizio, la pandemia di una politica, apartitica, che impone e non accoglie l’umanità del suo popolo. La verità è che continuiamo a navigare, in bilico tra il naufragio e l’affogamento imminente, in una società malata, impregnata di corruzione e malessere psicologico, una società limitata e indebolita dalla paura, resa inerme e incapace di riflettere, perché stordita da finte “verità” imbellettate, dai social, dai media, dal nostro stesso governo.
La verità però, prima o poi esce sempre fuori, e l’unica cosa che metterà fine a questa pandemia, reale, concreta, è il vaccino contro la chiusura mentale, la paura che non fa ragionare, il pregiudizio che condanna chi è diverso e prende di conseguenza scelte diverse dalle nostre, il vaccino che dovrebbe stimolare in nostro sistema immunitario alla produzione di solidarietà, comprensione, amorevole appoggio, gli uni con gli altri, in un sistema che ci vorrebbe unicamente divisi, impauriti, soli, confusi.
Per leggere gli articoli di Giusy De Nittis su Periscopio clicca sul nome dell’autrice