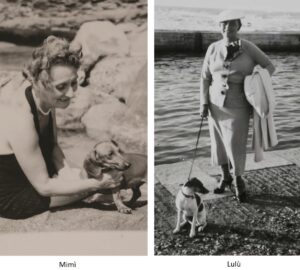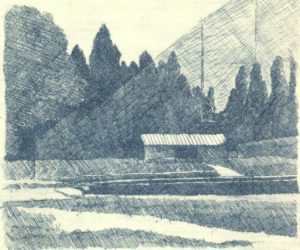Ho scoperto per caso questa lunga Lettera Aperta nella pagina Fb (data: 9 maggio) di Franco Ferioli, un amico che non vedevo e non sentivo da anni. Che stimo come un tipo di grande creatività, una persona (ed è questo che qui interessa) che coltiva con ostinazione l’esercizio del pensiero libero: esattamente quell’attitudine dello spirito che fa di lui, nel gergo sprezzante di certi politici di professione o vocazione, ‘un cane sciolto’.
Per la medesima ragione, e nonostante il suo articolo chiami fastidiosamente in causa anche il sottoscritto, ho chiesto a Franco se potevo pubblicare su Ferraraitalia le sue ‘considerazioni di un impolitico’. Che invece è un’analisi politica allo stato puro. Senza veli o giri di parole, prendendosi il rischio di giudizi ruvidi e col coraggio di mettere per iscritto nomi e cognomi. In fondo, la stessa idea balzana di quel ragazzaccio che al passaggio del sovrano si è messo a gridare “Il Re è NUDO”.
Non condivido tutte le cose che scrive Franco. Su molte la penso come lui. Ma questo è meno importante, ci sarà il tempo per discuterne. Quel che è sicuro è che Il Re (la Sinistra) è drammaticamente nudo/a. A Ferrara più che altrove. E che da oggi, da questo Anno Zero, non si uscirà, non si potrà mai uscire, non si potrà mai battere la Destra, con gli stessi programmi, le stesse alchimie, gli stessi balletti, le stesse mediazioni, le stesse facce di sempre.
Serviranno le “riflessioni indigeste” di Franco Ferioli? Non lo so, io me lo auguro. Mi danno l’idea di un sassone da macero (in ferrarese: ‘na masègna) che finisce con un gran tonfo in mezzo alla Fossa del Castello provocando un locale maremoto. Se così fosse, per una stagnante Sinistra sarebbe tutta salute.
Infine un invito, un caldo consiglio a chi (ai molti, ai tanti) che nelle righe seguenti si vedranno attaccati. Offendersi, peggio ancora arrabbiarsi, non solo non porta a nulla, ma è segno inconfondibile di poca intelligenza. Le provocazioni – anche così possono esser lette le parole di Franco Ferioli – a due cose possono servire. A riflettere. E a migliorarsi.
(Effe Emme)
di Franco Ferioli
Proposta di lettura di un manifesto contenente notizie e riflessioni di pubblico interesse ferrarese – che, avviso importante, potrebbero risultare indigeste – di un apneista del voto del meno peggio in assetto costante (occhi chiusi e naso tappato).
Invogliato da un articolo di Francesco Monini apparso su Ferraraitalia e riportato sulla sua pagina Facebook nel quale si invitava a proseguire pubblicamente l’analisi del voto regionale e i risultati raggiunti dalla Lista E.R. Coraggiosa Ecologista e Progressista, ho deciso di aderire partecipando al primo incontro e non mi sono per niente sentito rappresentato o rassicurato di aver fatto la scelta giusta nel votarla anch’io. Anzi, credo di essermene pentito.
Speravo che l’analisi del voto proseguisse collettivamente con la stessa apprezzabile lucidità con cui Francesco l’aveva iniziata e impostata, speravo che da quell’analisi ne potesse seguire una programmazione, insomma, per dirla in politichese, ho creduto che lo scopo dell’incontro fosse quello di compiere un’analisi programmatica del voto. Invece ho partecipato a una ‘festa di vincitori’ dove l’unico a sentirsi sconfitto sono stato io.
Che bello che sarebbe stato, per me, se qualcuno si fosse alzato e avesse detto non abbiamo vinto niente e continueremo a perdere fino a quando non ci renderemo conto di quali sono i motivi, al di là dei meriti organizzativi e degli impegni profusi, che hanno portato 2.227 persone a votare in questa direzione. Come avrei voluto sentir dire: abbiamo perso e continueremo a perdere fino a quando non capiremo da parte di chi siano arrivati i voti e cosa abbia spinto a votare un’alta percentuale in più di elettori che in precedenza ha fatto vincere la Lega quando la stessa percentuale era in meno…Che bello che sarebbe stato se qualcuno avesse detto: si potrà vincere solo se riusciremo a mettere in campo filosofie e pratiche politiche che siano non solo alternative ma completamente differenti e opposte alle altre.
A dominare la scena e a strappare gli applausi per primi, sono stati gli esponenti degli ex Verdi: erano forse seduti lì per dare nuove esemplari risposte ai ferraresi e utili consigli agli emiliani dopo che per decenni hanno non solo ignorato, ma anche impedito ogni domanda degli altri ambientalisti imponendo la scelta della centrale a turbogas e degli inceneritori come la migliore delle soluzioni per produrre energia sul nostro territorio dal momento che loro, più alcuni consulenti esterni presenti in sala, erano gli unici entro le Mura autorizzati scientificamente a sapere cosa fossero davvero le emissioni di micropolveri sottili e i soli in grado di giudicarle inoffensive e tollerabili per la salute pubblica?
Per parlare oggi e domani di ambiente e inquinamento e per porre mano all’ambizioso Patto per il Clima che prevede zero emissioni di Co2 entro il 2050 e 100% di energie rinnovabili entro il 2035, bisognerà pertanto continuare a fare scienza con coscienza in quel modo e divenire scienziati come hanno dimostrato di essere stati loro? [leggere Qui] [e Qui] [e anche Qui]
Quanti saranno stati i giovani ambientalisti che hanno espresso la loro preferenza elettorale per la Lista Emilia Romagna Coraggiosa, Ecologista e Progressista che pone i problemi legati al cambiamento climatico in testa alle priorità e in seconda linea sul proprio stemma? Tra la gente intervenuta e presente in sala, non era presente nessun giovane al di sotto dei 35-40 anni. Nessun giovane, nessun neo-votante, nessun neo-cittadino italiano di origine straniera.
L’unico accento straniero di matrice anglosassone, è stato quello di Robert Elliot referente dell’Associazione Cittadini del Mondo, che strappa l’applauso dopo essere brevemente intervenuto per richiedere tempestività nell’affrontare il post elezioni con volontà, determinazione e idee chiare.
Nessuno straniero, nessuno zingaro, nessun Rom, nessun Sinti, nessun emigrato, immigrato, migrante, profugo, rifugiato, richiedente asilo, clandestino, presente in una riunione tenutasi in pieno Quartiere Giardino, Zona GAD, tra una ronda e l’altra della camionetta dell’Esercito Operazione Strade Pulite.Nessuna donna africana, nessuna donna araba, orientale, esteuropea, nessuna badante, nessuna infermiera, nessuna studentessa, ma, per fortuna, molte donne ferraresi intervenute per chiedere operatività, programmi, contenuti e dimostrando che la matrice della lista è indubbiamente autoreferenziale ma, evviva, sicuramente femminista.
Il terzo applauso, forse il più meritato, se non altro per la simpatia espressa da un signore anziano, esponente e sostenitore del PD di cui non ho afferrato il nome, che si appella all’unità della sinistra. In maniera piacevolmente spontanea e apparentemente ingenua informa l’assemblea che lui si riconosce nella Lista Coraggiosa e che tra forze di sinistra la cosa più importante dovrebbe essere quella di mantenere l’unità.
Ma il problema rimane lo stesso e semmai i termini sarebbero da capovolgere: per me e forse per molti altri (?), la difficoltà consiste esattamente nel sentirsi di sinistra e di riconoscersi nel PD e probabilmente, oltre a me, sono stati molti altri (?) a votare questa lista pur di non votare direttamente proprio il PD. E probabilmente sono stati in molti anche a votare PD solo come voto di sbarramento, per mancanza di offerte politiche migliori, per antifascismo e solo per non far vincere la Lega.
Ho battuto anche io le mani, per gratitudine: questo simpatico compagno mi ha fatto alleviare il pesante ricordo di essermi persino trovato in passato costretto a votare Dario Franceschini pur di non votare Berlusconi e di rimuovere il vero e proprio incubo di essermi presentato in una lista civica che ha appoggiato Gaetano Sateriale fino a sette giorni dopo la sua avvenuta elezione a sindaco. Nel primo caso si trattava di questioni tecniche legate al sistema rappresentativo, nella seconda all’appartenenza di una nuova forma di pratica pollitica in città: sissì, proprio con due elle, come la pollitica-becchime da destinare a poveri polli d’allevamento destinati al girarrosto dopo averli imbottiti di antibiotici e luci artificiali.[leggi Qui]
I record no limits di profondità abissale da me raggiunti come apneista del voto del meno peggio in assetto costante (occhi chiusi e naso tappato) avrebbero dovuto insegnarmi qualcosa: sono doppiamente grato a quel vecchio compagno perché mi rendo conto di quanto io continui ad essere molto più sprovveduto e ingenuo di lui. Avrei dovuto insospettirmi: in una sala popolata da numerosi trionfanti fantasmi di sé stessi non avrei dovuto stupirmi nel vedere entrare vittoriosa anche la vecchia padrona di casa perché la strategia politica della signora Roberta Fusari a capo della Lista Azione Civica e della mini pletora di altre listarelle collegate per sostenere uno spacciato e dato per disperso Aldo Modonesi come sindaco, per me è una storia che oltre che inutile trovo allarmante come il suono di una sirena della croce rossa che si ferma sotto casa.
Mi sono alzato e sono uscito: mai nessuno, tantomeno io, se la sentirebbe di sparare sulle crocerossine impegnate ad assistere i soldati nelle guerre perse in partenza o colpiti da fuoco amico.
Me ne sono andato ma con la coscienza a posto: più o meno per gli stessi motivi di sempre non ho votato lei ma il candidato della sua lista Federico Varese quando per me ha rappresentato l’unica possibilità di non votare Lega e neanche, perlomeno direttamente, il PD.
Ho votato Federico come avrei potuto votare uno dei tanti altri aspiranti martiri, come Maria Ziosi o Simone Diegoli, chiamati in ritardo a individuare ed esprimere quel qualcosa di sinistra che ha reso muti ciechi e sordi i becchini in carica mentre scavavano con le proprie mani le fosse comuni della sinistra ferrarese e quelle comunali dei propri incarichi.
Se la componente ferrarese della lista Emilia Romagna Coraggiosa è uscita per partenogenesi dalla scapola sinistra della Lista Azione Civica, ha davvero un gran coraggio nel proporsi e propinarsi come vincente, festante e innovativa e ha anche un gran coraggio nel pensare di essere in grado di rispondere alle aspettative di sinistra, ecologiste e progressiste riposte nel voto senza trovare urgentemente una nuova linea e identificare nuovi programmi e nuovi candidati.
Non che il mio giudizio conti qualcosa di più della provocazione di una lettera, ma a mio modo di vedere e di capire c’è solo un modo di porsi per combattere sia la violenza espressa dalla forma di autoritarismo e di ricatto assunta dall’attuale amministrazione di destra, sia l’arroganza, la distanza e la presupponenza espressa da quelle precedenti di sinistra.
Con questi tipi di violenza c’è solo un modo per combattere: non una violenza pari e contraria, ma una non-violenza, che disciplini prima di tutto una filosofia politica basilare, fondante e permeante. Per questo dico e chiedo Daniele Lugli Sindaco Subito e Marco Bianchi Vice.
Oppure chiedo: Ma tu chi vorresti Sindaco?
E’ così difficile partire da zero, iniziare dal basso e chiederselo, anche solo per gioco o per provocazione? E non è così che si potrebbe fare per capire qualcosa di utile e urgente per molti, se non per moltissimi?
E a voi Francesco Monini, David Cambioli, Federico Varese, che potreste contribuire a garantire e consolidare un programma veramente innovativo mi vien da chiedere: state in disparte per libera scelta, perché non ne avete tempo e voglia, perché nessuno ve lo ha ancora chiesto, o perché la Lista Civica e la Lista Coraggiosa sono contenitori colmi solo di personalità politiche e ideologie riciclate destinate all’autodistruzione contro il muro di gomma shackespeariano dell’”essere o non essere PD?
Nel mio specifico caso il mio voto riflette un atteggiamento di rifiuto, rifiuto della Lega, rifiuto del PD, non di adesione o appartenenza politica a una lista fiancheggiatrice di quest’ultimo e non credo di essere stato l’unico a votare questa lista usando la matita con la tecnica surrealista della scrittura automatica e ad avere quella come unica scelta per non votare destra, non votare Pd e sperare di votare per qualcosa appartenente alla sinistra che rimane tra le righe della scheda o schiacciato sotto il peso dei risultati dell’urna.
Del programma, dei candidati, della campagna elettorale, della lista che ho votato non sapevo praticamente nulla. Un voto alla meno peggio, un voto senza vuoto a rendere, come una cambiale firmata in bianco pur di contrastare qualcuno e qualcosa che è divenuto a pari merito inaccettabile e insopportabile come le due facce della stessa medaglia politica attuale.
Secondo me a vincere le elezioni sono state le elezioni e le loro eccezioni: i veri vincitori sono stati quel + 30% di votanti rispetto alle precedenti. La Lista E.R. Coraggiosa ha vinto un giro gratis in giostra dopo essere riuscita a strappare la coda alla scimmietta e a tirare la corda del dissenso dei senza patria e identità di una sinistra desaparecida, fatta a pezzi e gettata in pasto ai pescecani e ora nel pugno chiuso ha solo la catenella dello sciacquone.
Gli stessi motivi che hanno portato ieri molte delle 22.000 persone a votare la jolly Elly Schlein, saranno gli stessi che potrebbero portare 22.000 persone a votare tra cinque anni per una nuova lista analoga che svolga le stesse funzioni o che le reindurranno a rimanersene chiuse in casa col televisore e il telefonino spento lasciando di nuovo vincere i partiti della peggiore destra di ogni tempo.
La Lista Civica ha invece vinto l’ultimo giro di walzer degli ideali di sinistra sulla scena politica ferrarese prima che venisse chiusa la balera, licenziata l’orchestra e buttata fuori la finestra dalla finestra.
Se non verranno immediatamente individuate nuove filosofie e nuove pratiche politiche che raccolgano i valori sociali, socializzanti e socialisti della sinistra, cancellati da coloro che sono corsi fuori dal palazzo a cercarli e a reclamarli dagli altri solo quando sapevano che erano già stati da loro stessi irrimediabilmente ignorati, mistificati e buttati nell’indifferenziata… se l’unica funzione politica ammissibile continuerà ad essere quella di continuare a soccorrere questa tipologia di oppositori del regime e di continuare a confortare e rifocillare di voti collegati e paralleli questa armata brancaleone di consiglieri doverosamente divenuti di minoranza… inutile sarà tirare la catena di un wc autopulente.
O dovrei lasciarmi convincere che a vincere sono stati tutti? E anch’io?
La Lega ha vinto continuando a vincere nella nostra provincia e in Calabria; il PD ha vinto perché non ha perso la roccaforte Emiliano-Romagnola: Berlusconi, la Meloni e Sgarbi non perderanno mai per diritto divino acquisito alla vittoria: nemmeno una sentenza della commissione antimafia è riuscita a far perdere qualcosa in città a qualcuno come Mauro Malaguti.
Quindi a vincere sono stati tutti? Paradossalmente anche chi non si è presentato affatto, come il Movimento delle Sardine che anche tutti gli altri partiti, oltre al PD, dovrebbero ringraziare di non averlo fatto?
Che nessuno trovi poi il coraggio di dire che a perdere è stato solo il M5S, dal momento che è ancora al governo ed è sempre e solo stato un movimento perlopiù virtuale, digitale e avanguardista che quindi non ha mai avuto niente da perdere come partito politico tradizionale.
Nel frattempo noi Ferraresi Civici ed Emiliani Coraggiosi vincitori continueremo a brindare, con le mascherine, al Bar Korowa davanti agli insuccessi televisivi di Fabbri, Lodi e Solaroli su La Sette, mentre la setta Cavallini-Sgarbi si è impadronita delle sale espositive del Castello Estense come proprio scantinato, salotto e galleria d’arte… stapperemo champagne al chiosco di via Poledrelli conosciuto dai più come ‘da Hitler’ quando Vittorio Sgarbi inaugurerà due mostre per oltraggiare il significato dell’arte di Banksy e il significato del lavoro di Franco Farina al Palazzo dei Diamanti e per riabilitare la grande figura morale di Italo Balbo magari al MEIS… e punteremo i colli di bottiglia contro i suicide bombers della sinistra all’opposizione in Consiglio Comunale che, anziché minacciare di nuovo di abbandonare fisicamente e inutilmente l’aula per qualche minuto e di qualche metro, avrebbero dovuto abbandonarla eticamente per sempre il giorno dopo i risultati delle elezioni con le quali hanno regalato la città nelle ruvide mani e forti braccia tese della ‘peggiore destra ferrarese di utti i tempi’, come l’ha definita Aldo Modonesi in campagna elettorale.
Peggiore di quella composta da squadre di picchiatori fascisti in camicia nera che ammazzavano di botte, di deportazioni e fucilate sacerdoti, ebrei e comunisti un attimo prima di partire per compiere eroiche trasvolate atlantiche o pericolosissime e audaci missioni di bombardamenti aerei in Libia?
I fascisti ferraresi di oggi contro cui combattere sono profeti in patria e profeti di loro stessi, legittimati dai governanti precedenti e dai non votanti di sinistra: giusti o sbagliati che siano, sono loro stessi a insegnarci che per eliminarli in futuro servirà buona mira.
Quelli di ieri sono stati profeti all’estero e profeti di sventura, per eliminarli ci è stato detto dalla storia che è bastata la mira giusta e un colpo di artiglieria antiaerea partito (guardacaso, solo per tragico errore). Quelli di oggi si limiteranno a imbucare e ad autospedirsi un pacco con dentro il proiettile che nessun ferrarese è disposto a sprecare per loro o saranno costretti a farsi autorecapitare lo stesso micidiale cannone della seconda guerra mondiale in dotazione al mitragliere ferrarese impegnato in Cirenaica ad abbattere l’aereo di Italo Balbo con il suo entourage di giornalisti padani?
La Ferrara dell’altro ieri, la Ferrara di ieri e la Ferrara di oggi: è già troppo tardi per chiedersi che forma prenderà la politica di sinistra per diffondersi nel coprifuoco imposto anche dalle azioni mirate a limitare il diffondersi del corona virus Covid-19?
Inchiostro su carta? Email? Post sulle pagine Fb degli amici degli amici mai visti ne’ incontrati? Piccioni viaggiatori?
Cover: foto di Beniamino Marino (maggio 2020)