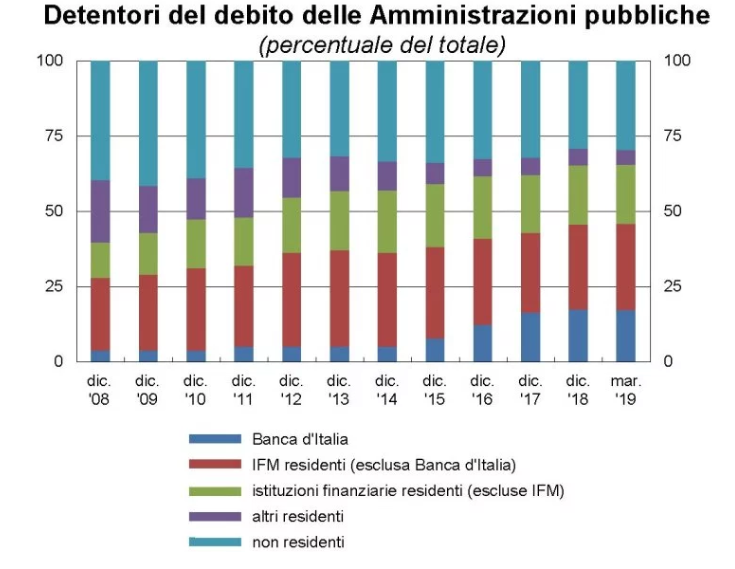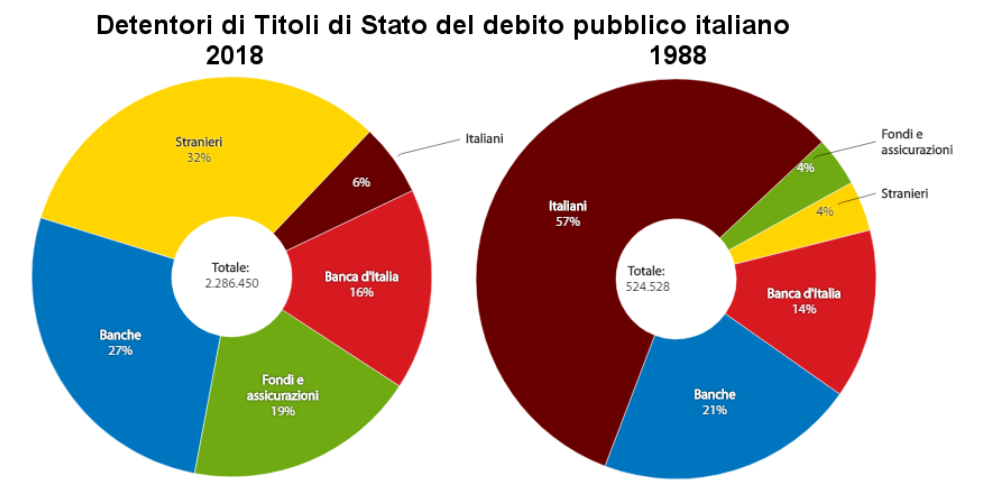Ferrara Film Festival: presentazione della 5° edizione
Da: Ufficio Stampa Ferrara Film Festival
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara è stata presentata, la quinta edizione del Ferrara Film Festival che inizierà il prossimo 17 settembre e si concluderà domenica 20, in forma ridotta e in totale sicurezza per via delle restrizioni da Covid-19. Il benvenuto lo dà l’assessore al Turismo di Ferrara Matteo Fornasini che parla di coraggio degli organizzatori “in quanto realizzare eventi nel corso delle restrizioni sanitarie comporta ancora più impegno. Malgrado questo a Ferrara, oltre a veder confermati appuntamenti in calendario gli anni scorsi, si aggiungono anche nuovi eventi. Per quanto riguarda il Ferrara Film Festival rivolgo i complimenti dell’Amministrazione perchè si inquadra all’interno di appuntamenti di spessore che creano indotto, dando modo alle attività commerciali di lavorare richiamando turismo in città”. Maximilian Law, nella veste di direttore del Festival, ha poi specificato i temi di rilievo, a cominciare dai grandi ospiti. “Consegneremo 3 premi alla carriera, tra cui due internazionali. Parlo di Nastassja Kinski, che non ha bisogno di presentazioni, Bille August, regista pluripremiato con film eccellenti, quali la Casa degli spiriti, Les Miserables, Il senso di Smilla per la neve, oltre ad Alessandro Haber che conosciamo tutti. Una delle novità di quest’anno – ha precisato il direttore – sta nella formula più ridotta, sulla base del weekend, con la proiezione dei 13 film premiati dalla giuria, sui 38 che avevano scelto di candidarsi. A questi si aggiunge la premier italiana del film “The poison rose”, un film uscito negli USA, con John Travolta e Morgan Freeman. Noi presenteremo l’anteprima nazionale nella versione director’s cut, con 20 minuti di scene totalmente inedite, con la partecipazione del regista e del cast italiano del film. Ricordo anche la partnership con RDS con cui abbiamo avviato un progetto interessantissimo teso all’organizzazione di un grande concerto in programma a Ferrara per il prossimo anno in occasione del giorno della Terra 2021. Se ne parlerà più approfonditamente insieme al direttore di RDS che sarà nostro ospite nel corso del Festival. Intanto possiamo anticipare che, grazie a delle partnership con UNICEF e Italo Treno siamo arrivati all’ideazione di due premi speciali per nuove categorie di film incentrati su argomenti di rilievo (“Young UNICEF”, sul tema umanitario, e “FFF Earth”, sul tema dell’Ambiente). Il Ferrara Film Festival non è solo cinema ma anche beneficienza, così come precisato dal vicedirettore Giorgio Ferroni: “Non lavoriamo solo per questo weekend lungo di cinema: il nostro è un impegno che si sviluppa durante tutto l’anno per creare appuntamenti anche in ottica di beneficienza e solidarietà. Il 17 abbiamo in programma una cena il cui ricavato verrà devoluto all’associazione A-Rose impegnata nella ricerca sul cancro”. Infine l’arte, con Palazzo della Racchetta (via Vaspergolo 6 a Ferrara) storica e confermata sede del FFF, diretta da Enrico Ravegnani, che ospiterà sia la mostra artistica di Alberto Andreis che la proiezione del docufilm “Art Backstage – la passione e lo sguardo” di Manuela Teatini in programma il 16 settembre alle 21.