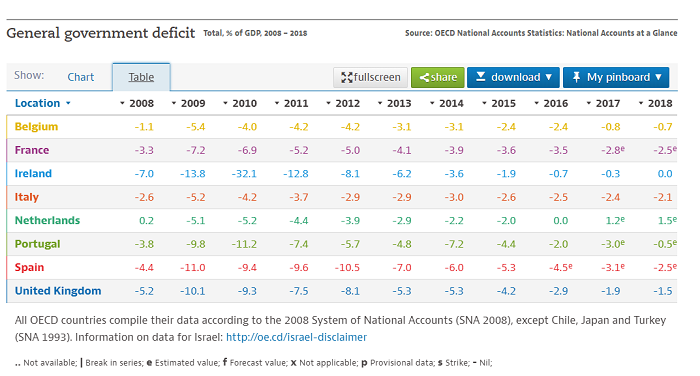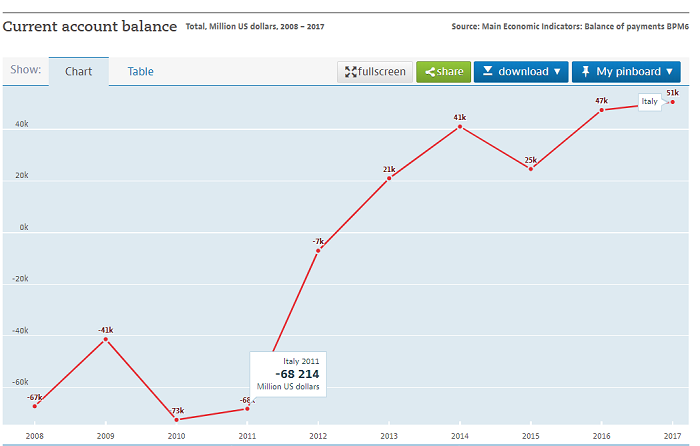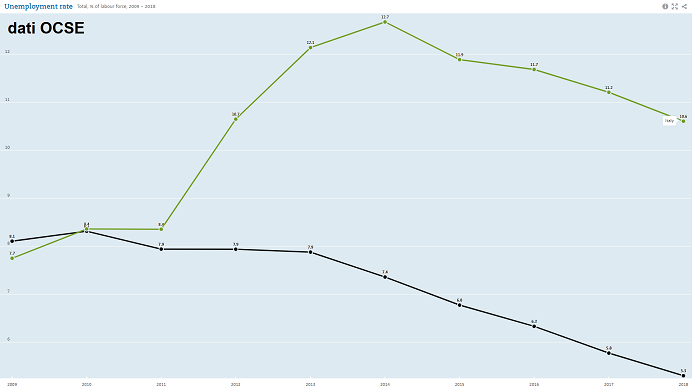Da: MediaMente
Festival filosofia 2019: Persona, maneggiare con cura. Dal 13 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
Da venerdì 13 a domenica 15 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo quasi 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli, tutti dedicati al tema “persona”. Tra i protagonisti 54 relatori, di cui ben 24 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Augé, Bodei, Bianchi, Cacciari, Crouch, Ehrenberg, Galimberti, Giovannini, Marzano, Massini, Nancy, Quante, Recalcati, Rosen, Roy, Severino, Vegetti Finzi. In programma anche otto “menu filosofici” per ricordare Tullio Gregory
Dedicato al tema persona, il festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana. La diciannovesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.
Piazze e cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il pubblico sul tema “persona”, che indica una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico (come per esempio nel caso del lavoro), sia nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.
L’edizione 2019, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta ventiquattro voci nuove, su un totale di 53 relatori. Tra gli autori stranieri, due terzi sono al loro debutto al festival.
Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri, Marc Augé, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano (Lectio “Rotary Club Gruppo Ghirlandina”), Stefano Massini (Lectio “Coop Alleanza 3.0”), Jean Luc-Nancy, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Emanuele Severino, Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio.
Tra i “debuttanti”, Michel Agier, Leonardo Caffo, Colin Crouch (Lectio “Gruppo Hera”), Alain Ehrenberg, Paolo Flores d’Arcais, Enrico Giovannini (Lectio “Confindustria Emilia Area Centro”), Danilo Martuccelli, Michael Rosen (Lectio “BPER Banca”), Olivier Roy, Michael Quante.
Il programma filosofico del festival propone anche la sezione “la lezione dei classici”: esperti eminenti commenteranno i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della persona.
Se le lezioni magistrali sono il cuore della manifestazione, un vasto programma creativo (ancora in corso di definizione) coinvolgerà performance, musica e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti: David Riondino (con un concerto bandistico), Pamela Villoresi (con un recital sul tema del lavoro), Telmo Pievani e i Deproducers (con uno spettacolo sull’evoluzione di Homo sapiens), Lino Guanciale (in una conversazione con Roberto Escobar su Canetti), Chiara Valerio (in un reading da un suo testo inedito), Michele Dalai (con uno spettacolo su Gino Bartali giusto tra le nazioni), Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua (in un dialogo-spettacolo sulla chiusura degli ospedali psichiatrici), Lella Costa (in un recital su Edith Stein). Non mancheranno i mercati di libri e le iniziative per bambini e ragazzi.
Oltre trenta le mostre proposte in occasione del festival, tra cui le personali di Vittorio Guida e Luisa Menazzi Moretti prodotte da Fondazione Modena Arti Visive. A Carpi una mostra ai Musei di Palazzo dei Pio presenta incisioni di Picasso, Kirchner e Chagall sul tema della maschera, mentre a Sassuolo una personale di Mustafa Sabbagh è dedicata alla condizione dell’umano.
Prima edizione dopo la scomparsa di Tullio Gregory, il festival omaggerà la figura del grande maestro, tra l’altro, riproponendo alcuni dei più significativi tra i suoi “menu filosofici” per quasi ottanta ristoranti ed enoteche delle tre città.
Il festival è promosso dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Infoline: Consorzio per il festivalfilosofia, tel. 059/2033382 e http://www.festivalfilosofia.it
Festivalfilosofia 2019: Divenire persone
Festivalfilosofia 2019: Divenire personeNelle piazze e nei cortili del festival si discuterà di autonomia e diritti delle persone, di maschere e peculiarità del volto, di costituzione del Sé in tutte le fasi della vita e dei generi d’identità, sempre oscillanti tra io e noi
L’edizione 2019 sarà imperniata sulla parola chiave persona. In oltre 50 lezioni magistrali saranno affrontate le varie declinazioni di questo tema, una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico, sia nelle questioni della vita individuale. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.
Strutturato per gruppi di questioni, il programma filosofico porterà pertanto in primo piano un lessico concettuale a più voci dove si confronteranno prospettive filosofiche plurali e anche divergenti.
1. Genealogie della persona
La prima pista affronta alcuni degli assi concettuali e storici ancora operativi nell’uso contemporaneo di questa categoria. Tra le tracce di lunga durata significativa è quella religiosa, che risale fino alla questione della natura umana e divina, come mostrerà Enzo Bianchi. Una seconda traccia, di cui parlerà Emanuele Stolfi, rinvia al diritto romano, nel quale la summa divisio tra persone (liberi e servi) e cose costituisce uno dei perimetri originari in cui si è svolto il discorso istituzionale e morale intorno alla persona. Questo dispositivo è stato successivamente recuperato su un piano filosofico e morale, ma sempre ispirato al primato del classico, nella visione umanistica di un antropocentrismo fondato sulla «dignità dell’uomo», su cui interverrà Massimo Cacciari in una lezione dedicata alla memoria di Tullio Gregory. Più a ridosso della contemporaneità, ulteriori svolte hanno segnato la riflessione sulla persona. In ambito fenomenologico, come mostrerà Roberta de Monticelli, è emersa la questione del rapporto tra l’evidenza della soggettività, che è corporea e relazionale, e l’«individualità essenziale» in cui è racchiuso il segreto dell’irripetibile unicità di ogni persona, capace di portare la propria novità nel mondo. Sul terreno della biopolitica, per converso, la critica alla persona ha mostrato la necessità di pensarla sempre in relazione all’impersonale, ovvero al collettivo, o in altro senso all’organico, per mostrare come la consistenza del vivente (umano, ma non solo) sfugga all’astrazione giuridica e istituzionale che pare inevitabile, data la struttura della persona: ne discuterà Roberto Esposito.
Un’ulteriore soglia problematizza la questione chiamandoci a discutere lo statuto delle persone non-umane e la soggettività animale: Leonardo Caffo farà il punto sulle sfide poste alla filosofia dalla questione delle specie, mentre Luisella Battaglia indicherà come il riconoscimento dei diritti degli animali implichi una vera e propria estensione della nostra comunità. Emanuele Coccia spingerà la riflessione fino a domandarsi se non esista un “io vegetale” che accomuna i viventi.
2. Maschere e volti
Il secondo terreno di analisi riguarda il significato etimologico e, come si vedrà, iconologico, della persona, che in latino indica la maschera (in greco la parola si affermerà in epoca bizantina per indicare la persona morale del sapere giuridico e verrà tradotta con prosopon, ossia con un termine che anch’esso rinvia al significato arcaico avente a che fare col volto e l’immagine). Marc Augé, membro del Comitato scientifico del festival, ne ricostruirà la dimensione antropologica e rituale, mentre Remo Bodei, Presidente del Comitato, si soffermerà sul rapporto tra maschera e volto che emerge anche nella disciplina del ritratto. Uno speciale tipo di maschera, con le sue implicazioni culturali ed etiche, è il tema della lezione di Maria Bettetini, che discuterà il significato iconologico del velo in varie pratiche culturali e religiose. Carlo Sini, discutendo lo statuto del corpo tra soggettività e automatismo, mostrerà come il corpo che siamo possa essere la nostra prima maschera. Jean-Luc Nancy farà vedere come siano la pelle e la sua fragilità, esponendo il corpo al mondo, a costituire il nostro primo legame con esso.
3. Lessico dell’individuo
Nella terza pista tematica si farà il punto sui diversi lessici dell’individualità, della soggettività e della singolarità, per cogliere i contesti e le caratteristiche peculiari dell’idea filosofica di persona. Mentre la questione dell’individuo si pone sul piano ontologico in relazione alla totalità, facendo emergere anche il carattere illusorio delle parti rispetto al tutto dell’Essere (è la proposta di Emanuele Severino), è possibile anche rintracciare ampia evidenza di una trasformazione che l’individualità ha subito in epoca contemporanea. Come indicherà Danilo Martuccelli, gli individui contemporanei ambiscono a essere uguali solo a se stessi e incomparabili con chiunque altro. In questo processo di singolarizzazione, il cui esito paradossale è spesso il conformismo assoluto, Mauro Magatti intravede l’opportunità di ripensare un individuo che, dalla propria crisi, riscopra il valore fondante e generativo della reciprocità. La soggettività, del resto, non è un dato ma una costruzione, un complesso processo di edificazione di sé e del proprio carattere, come mostrerà Salvatore Natoli.
Ogni esistenza è d’altronde essenziale e intangibile. Ai gesti di violenza biblica che attaccano la singolarità della vita, facendone per contrasto brillare il valore, è dedicata la lezione di Massimo Recalcati.
In un contesto completamente differente, la singolarità è una caratteristica cosmologica, come nel caso dei buchi neri, dove i sistemi fisici perdono la capacità predittiva. Questo affascinante tema, che ha a che fare con le più avanzate teorie sull’origine dell’universo, verrà discusso da Mariafelicia De Laurentis e Massimo Pietroni (in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dibattito condotto da Marco Cattaneo).
A come sopravvivere nel mondo conservando la scintilla dell’umanità e con l’ausilio del racconto sarà dedicato l’intervento di Stefano Massini (Lectio Coop Alleanza 3.0).
4. Io e noi
Il tema dell’identità, che non si sovrappone a quello dell’individuo, indica una questione che dal piano individuale (non solo cognitivo, e nella nostra epoca neanche esclusivamente corporeo, ma anche digitale), si carica tuttavia anche di valenze politiche. Funzionale e costruttiva, l’identità rinvia sempre all’appartenenza, a una cultura o alla comune umanità: tutti concetti porosi e non essenzialistici, di cui provare a sondare limiti e potenzialità. Nathalie Heinich indicherà il contesto individuale di formazione dell’identità, decostruendo tutto quello che nel discorso pubblico passa per “identitario”, senza a rigore esserlo, mentre Donatella Di Cesare farà vedere come, in un mondo che non sa più pensare il fuori, l’identità valga soprattutto come cancellazione dell’alterità. Su un diverso piano, Silvia Vegetti Finzi mostrerà viceversa che essere se stessi è un’arte che si impara nel lungo passaggio tra infanzia e vita adulta.
Il transito dell’identità e della personalità dal piano individuale a quello collettivo comincia con Carlo Galli, il quale discuterà le istituzioni pubbliche per evidenziare come la politica si fondi su figure che implicano una soggettività generale, mentre Colin Crouch (nella Lectio Gruppo Hera) affronterà il tema dell’appartenenza e dell’identità collettiva tra globalizzazione e rinascita delle nazioni. Al tema dell’identità culturale – e in particolare alla questione dei valori europei nel loro rapporto con le radici religiose del cristianesimo – sarà invece dedicata la lezione di Olivier Roy.
C’è un campo tutto nuovo nel quale il crinale tra privato e pubblico, identità individuale e immersione nella “community”, viene articolato in forme spesso senza precedenti: è quello del web e dell’identità digitale cui non sfugge ormai gran parte delle persone. Paolo Ercolani ne misurerà limiti e potenzialità – tra soggettività social e perdita di realtà – mentre Davide Sisto mapperà un fenomeno di grande portata antropologica, ossia quello della sopravvivenza digitale (negli account social delle persone decedute e nelle tracce dei propri dati), per cui si profila un vero e proprio nuovo rapporto tra i vivi e i morti.
5. Sé come altro
La quinta pista ruota attorno alla costituzione psichica del Sé e alle prove cui è sottoposto. Umberto Galimberti si chiederà se ciascuno, preso come persona, sia uno o molti, mentre Alain Ehrenberg farà il punto sull’individuo contemporaneo interrogandosi sul rapporto tra la meccanica delle passioni oggetto delle neuroscienze e le patologie da cui è affetto il soggetto in una società ad elevato livello di prestazione. Focalizzandosi sul caso dell’autismo, Marco Francesconi ne prenderà spunto per segnalare che la “mente pieghevole” è caratteristica di ogni persona, mentre Massimo De Carolis, indicando come ogni identità riposi sull’imperfezione, mostrerà come la personalità sia sempre una costruzione politica.
L’essere se stessi si dipana tra la vita e la morte, ponendo questioni “bioetiche” che si possono filosoficamente racchiudere nella formula della “memoria del Sé”, come quando si pone la domanda su cosa resti di noi di fronte a malattie che sembrano cancellare memorie e personalità (ne parlerà Michela Marzano nella Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina): è in gioco, lo sosterrà Michael Quante, l’idea fondamentale dell’autonomia personale. Delicato e dilemmatico è il momento del fine vita, in cui traspaiono le esigenze di restare sovrani della propria vita (ne parlerà Paolo Flores D’Arcais) e di salvaguardare la vita con la cura fino all’estremo (su cui interverrà Vincenzo Paglia).
6. Diritti delle persone
Si giunge infine nella sesta pista all’idea della persona come fondamento di autonomia morale e dei diritti. Mediatrice tra uomo/donna e cittadino/cittadina, la categoria di persona è il perno dell’idea contemporanea dei diritti umani, ossia del set di tutele giuridiche che spetta a chiunque, indipendentemente dalla sovranità degli Stati e dall’idea di cittadinanza. Frutto, come si è visto, di una lunga genealogia, questo tema ha anch’esso una premessa classica: mentre Ivano Dionigi mostrerà le politiche di inclusione romane e la loro attualità, Maurizio Bettini ricostruirà il significato classico dell’idea di “ius humanum”, con le analogie e le differenze rispetto al concetto di diritti umani.
Una delle virtù essenziali che si attribuiscono alla persona è quella della dignità, sul cui principio interverrà Michael Rosen nella Lectio BPER Banca. Gustavo Zagrebelsky, in prospettiva analoga, indicherà che la prima forma di riconoscimento, nonché la prima tutela giuridica, sta nel “diritto di avere diritti”.
Uguaglianza di fronte alla legge e differenza delle culture saranno il tema della lezione di Michel Agier, che ci ricorderà come tutti siamo sottoposti all’essere stranieri, mentre Roberto Mancini si soffermerà sull’importanza di riconoscere dignità e solidarietà alle persone nei processi economici. Sempre in chiave economica e sociale, Enrico Giovannini si interrogherà sul ruolo delle persone e sul destino dei posti di lavoro nella quarta rivoluzione industriale (Lectio Confindustria Emilia Area Centro), mentre Chiara Saraceno affronterà la doppia e intrecciata disuguaglianza che riguarda disparità di genere e mercato del lavoro, con i costi umani e sociali che essa comporta. Sempre muovendosi entro una questione di genere, Elena Pulcini indicherà come la vulnerabilità, presa come condizione esemplare dell’epoca contemporanea, possa divenire una risorsa per chi voglia praticare la responsabilità e la cura del mondo.
7. La lezione dei Classici
Completerà come di consueto il programma filosofico la sezione “Lezione dei classici”: grandi interpreti del pensiero filosofico presentano le opere che hanno maggiormente segnato la riflessione sul tema “persona”.
Giuseppe Cambiano presenterà la “Politica” di Aristotele per risalire, nella discussione della polis e del ruolo degli schiavi, a una delle prime dicotomie tra persone e cose. Fabrizio Amerini si dedicherà alla “Summa teologica” di Tommaso d’Aquino per commentare un’influente teoria della persona, tra teologia trinitaria e antropologia.
Venendo alla prima età moderna, Nicola Panichi commenterà i “Saggi” di Montaigne, vero e proprio spartiacque nella visione della soggettività e dell’autobiografia. Discutendo “Per la pace perpetua” di Kant, Massimo Mori mostrerà i dilemmi del diritto cosmopolitico tra diritto di migrazione e politiche di ospitalità, mentre Angelo Panebianco, con una lezione su “La democrazia in America” di Tocqueville, analizzerà la prima compiuta versione dell’individualismo.
Più a ridosso del contemporaneo, Remo Bodei si focalizzerà sull’idea multipla di persona che emerge in “Uno, nessuno e centomila” e più in generale nell’intera opera di Pirandello.
Con una lezione su “Totalità e infinito” di Lévinas, Silvano Petrosino ricostruirà una delle proposte filosofiche più cruciali nell’attuale dibattito su empatia, riconoscimento, centralità del volto per la morale e il rapporto all’altro, mentre Laura Boella guiderà il pubblico alla scoperta di “La persona e il sacro” di Simone Weil, un testo nel quale cura per gli altri e aspirazione alla trascendenza si gemellano.
Con una lezione su “Sé come altro” di Paul Ricoeur, infine, Francesca Brezzi ripercorrerà alcuni concetti chiave di uno dei più significativi autori della filosofia dopo il personalismo.
Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e personaggi
Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e
personaggiUn nutrito programma di eventi, tutti gratuiti, affiancherà le lezioni magistrali del festivalfilosofia dal 13 al 15 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo
1. Genealogie della persona
Modelli e soglie dell’umano raccontano ed esibiscono la storia della civiltà e le frontiere della persona
Alla radice della nostra civiltà sta il dilemma se adottare le leggi del cosmo o le leggi dell’io. Nel dialogo immaginario tra Lucrezio e Seneca “Quando la vita ti viene a trovare”, venerdì 13 alle ore 22 presso il Teatro Storchi a Modena, il latinista Ivano Dionigi fa incontrare due personaggi con visioni rivali del mondo, icone della bigamia del nostro pensiero e della nostra anima (produzione: Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con: Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival). La mostra di Vittorio Guida “Where Are We Now? Volumi I e II”, presso la Palazzina dei Giardini a Modena, racconta viceversa un futuro già fattosi presente, in una efficace sintesi di primitivo e digitale, interrogandosi su ciò che siamo oggi o, meglio, su “dove” siamo oggi (produzione: Fondazione Modena Arti Visive). A Sassuolo, i maestri ceramisti Bertozzi & Casoni, nel Museo loro dedicato, celebrano e rivisitano, con la mostra “Ritratto”, l’ambiguità di un’opera canonica come il volto di Mademoiselle Rivière di Ingres (1805) con una inedita versione scultorea, dove il volto femminile risulta sostituito da quello di una giovane gorilla (produzione: Museo Bertozzi & Casoni, presentazione: venerdì 13 alle ore 17 con un intervento di David Riondino).
Seguendo lo statuto del corpo e il suo rapporto con l’identità personale, la mostra “Prosopon” ripercorre lavori di Hermann Nitsch sulle forme e gli organi: il Teatro Anatomico di Modena che la ospita si riappropria così della sua natura celebrativa sull’indagine del corpo (curatori: Elena Corradini, Francesco Silvestri, Tiberio Cattelani, produzione: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, con: Archivio Cattelani, Ago Modena Fabbriche Culturali, presentazione: venerdì 13 ore 19.30). Presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, la mostra “Leggere il corpo. Illustrazioni anatomiche tra Cinquecento e Seicento” segue l’evoluzione scientifica e iconografica della rappresentazione del corpo umano dalle tavole anatomiche di Berengario da Carpi ai trattati e alle tavole xilografiche e calcografiche di incisori dei secoli XV-XVII (curatrice: Milena Ricci, a cura di: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena).
Grazie a brani musicali inediti, a immagini suggestive e a una scenografia costruita ad hoc, una conferenza scientifica diventa un’esperienza immersiva alla portata di tutti. Con Telmo Pievani e Deproducers in “DNA” il pubblico avrà l’occasione di ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo Sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica, attraverso uno spettacolo appassionante che sottolinea il valore della ricerca scientifica sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di se stessi attraverso la conoscenza (Carpi, Piazza Martiri, venerdì 13 ore 22).
Corpo non è solo quello degli animali umani ma anche quello dei non umani, con le relative differenziazioni: “L’attrazione fatale degli animali” consentirà di evidenziare come molti animali sviluppino differenze per attrarre l’altro sesso (Modena, Museo di Zoologia, curatori: Elena Corradini, Ivano Ansaloni, Andrea Gambarelli, a cura di: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, presentazione: venerdì 13 ore 17.30). Nei dipinti di Riccardo Sghedoni, veri e propri ritratti di specie, si mostrerà viceversa che razza di razza siamo: “Umani e altri animali” (Modena, Riccardo Sghedoni Art Factory).
Sulla soglia tra umano e artificiale, lo spettacolo “Creature” vedrà protagonisti giovani attori e studenti delle scuole di Modena e Sassuolo, già impegnati nel Progetto Clip del festivalfilosofia, con la messa in scena di un viaggio nel capolavoro di Mary Shelley “Frankenstein” (Complesso San Filippo Neri di Modena, a cura di: STED, con il coordinamento di Tony Contartese, Marco Marzaioli, Marina Meinero, produzione: festivalfilosofia, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 16).
La fabbricazione dell’umano è al cuore anche della mostra di Metronom a Modena, “Antropotecniche”, che presenta il lavoro di cinque artisti, Bundurakis, Christto & Andrew, Desaubliaux, Kard, Schiesari, i quali si confrontano con la rappresentazione e la costruzione di corpo e figura, tra umano e postumano, per mezzo di fotografia, sculture digitali, stampa 3D (curatrice: Marcella Manni, produzione: Metronom).
Venerdì 13 alle ore 22, sulla falsariga del noto autore di fantascienza Isaac Asimov, Sandra Tassi propone nel reading de Il Leggio il divenire persona di un automa “difettoso”, fino alla accettazione libera e volontaria della propria morte, condizione ultima e necessaria per una vita autentica: “Il sogno di una vita. Legittimi desideri di un robot” (Modena, Palazzo Santa Margherita – Chiostro, a cura di: Associazione culturale “Il Leggio”).
Nuove soglie dell’umano, dall’Homo Sapiens all’Intelligenza Artificiale, sono misurate nel gioco a quiz “Anthropos o Androide? Sfida te stesso e scopri quanta Intelligenza Artificiale è in te!”, che misura il livello di “evoluzione digitale” (a cura di: Ufficio Comunicazione del Comune di Modena e Palestra digitale – MakeitModena, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, Piazza Grande – Ufficio Relazioni con il Pubblico, venerdì 13 ore 17-21, sabato 14 ore 17-21). L’Intelligenza Artificiale non esiste. A partire da questa provocazione, Energy Way cura e propone un percorso laboratoriale attraverso i differenti stadi di programmazione di una rete neurale, per mostrare quanto l’Intelligenza Artificiale sia, in realtà, profondamente umana: “Educare a pensare” (Modena, Via Sant’Orsola, 33; sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-13; 15-18). Andrea Lazzarini e Andrea Zanni propongono in “Umani e digitali” una conversazione tra studiosi, esperti di informatica umanistica e il pubblico stesso sull’opera “Della pubblica felicità” di L.A. Muratori, svolgendo una sessione interattiva sull’annotazione collaborativa degli archivi digitali grazie all’uso delle tecnologie digital humanities (Ago Modena Fabbriche Culturali – Future Education Modena, a cura di: Gallerie Estensi con Ago, Centro DHMORE e Ati Extense, max. 25 partecipanti, sabato 14 ore 15; 16.30).
Collegata alla conversazione “Umani e digitali”, la mostra “Gigapixels!!” permette di scoprire l’affascinante processo che dall’oggetto fisico porta alla creazione di surrogati digitali ad altissima definizione, a partire dalla celebre collezione di mappe della Biblioteca Estense (Modena, Palazzo dei Musei – Biblioteca Estense, curatore: Luca Panini, a cura di: Gallerie Estensi, Franco Cosimo Panini).
I benefici della tecnologia sulle persone, con la lunga storia di innovazione di Olivetti, sono invece presentati nella mostra “Una storia di innovazione” (AGO Modena Fabbriche Culturali, a cura di: Olivetti S.p.A., in collaborazione con: Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Area Centro).
Al Crogiolo Marazzi di Sassuolo, la selezione di “Non è l’Ennesimo festivalfilosofia” (a cura di: Tilt Associazione Giovanile – Ennesimo Film Festival, sabato 14 alle ore 21) indaga la persona immersa nella contemporaneità sotto diversi aspetti: nel campo sociale, lavorativo, nell’affermazione del sé all’interno della società o della propria comunità, nel bisogno di emergere e in quelle che sono le più comuni azioni dell’essere umano.
2. Maschere e volti
Nel volto e nel ritratto è inciso il carattere delle persone, in un continuo gioco di finzione e rappresentazione
Lo statuto rituale e iconografico della maschera, con l’influenza che i manufatti provenienti dal mondo africano e australe hanno esercitato sull’arte contemporanea, è ricostruito nella mostra “Personae”, nell’ambito della XIX Biennale di Xilografia contemporanea di Carpi, in cui si propongono una cinquantina di incisioni realizzate da Picasso, Kirchner, Chagall (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio, curatori: Manuela Rossi, Enzo Di Martino, produzione: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dei curatori). Farà da cornice alla mostra lo spettacolo itinerante e installativo “Volti di polvere”, sul tema del doppio della persona e sulla maschera quale oggetto in relazione simbolica con l’aldilà (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio e Archivio Storico Comunale, a cura di: Musei di Palazzo dei Pio, Teatro Comunale di Carpi, Archivio Storico Comunale; venerdì 13 ore 20, 21, 22; sabato 14 ore 21, 22; domenica 15 ore 18, 19). Sempre presso Palazzo dei Pio, l’esposizione “Personalità della materia” raccoglie capi, art book e trend book realizzati dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano, provenienti da diverse realtà geografiche, allo scopo di tradurre la materia in espressione della personalità, servendosi del vestiario come interfaccia tra singole individualità e collettività (a cura di: Scuola Postgraduate di IED Milano, con: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza degli organizzatori).
A Modena, invece, la mostra di Tommaso Mori “R-Nord”, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, presenta ritratti fotografici di oltre 200 abitanti di un quartiere della città di Modena, con articoli, documenti, progetti architettonici e urbanistici originali (AGO Modena Fabbriche Culturali – Chiesa di San Nicolò, curatore: Matteo Balduzzi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Con “Cantiere permanente. La messa in scena del sé” Fondazione Modena Arti Visive avvia un progetto a lungo termine volto a valorizzare le collezioni di fotografia, grafica e disegno di Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a cui verranno in futuro dedicate alcune sale in modo permanente. Il tema “Persona” è il primo episodio in questa direzione: un’indagine su come gli artisti abbiano affrontato la soggettività e la messa in scena del sé, in un allestimento sperimentale in continuo divenire (Palazzo Santa Margherita – Galleria Civica, curatori: Chiara Dall’Olio, Daniele De Luigi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Al MATA – Ex Manifattura Tabacchi, Luisa Menazzi Moretti, con “Solo”, a produzione Fondazione Modena Arti Visive, propone scatti su volti e persone smarrite, ignare sul da farsi. Sempre a produzione Fondazione Modena Arti Visive, il laboratorio “I Wanna Dance with Somebody. Set fotografico aperto a tutti” crea un’atmosfera di musica e colori, un fondale e tanti accessori per ideare il proprio personalissimo look e portarsi a casa un ritratto fotografico in stile anni Ottanta (sabato 14 ore 20-23, domenica 15 ore 15-19). I fili comuni del progetti proposti da Fondazione Modena Arti Visive sono discussi nella conversazione “In sé fuori di sé”: Vittorio Guida, Luisa Menazzi Moretti, Tommaso Mori affrontano i concetti di identità e alterità, di individuo e gruppo, di essere e apparire, attraverso le loro opere più significative (Palazzo Santa Margherita – Chiostro, conduce: Daniele Pittèri, a cura di: Fondazione Modena Arti Visive, sabato 14 ore 22.30).
Presso i Musei Civici di Palazzo dei Musei a Modena, sono allestite due esposizioni. La prima, “Faccia a faccia con la mummia”, con le avanzate tecnologie digitali del designer 3D Cicero Moraes, è dedicata a un’ipotesi di ricostruzione del volto della mummia di bambino esposta nella mostra “Storie d’Egitto. La riscoperta della raccolta egiziana del Museo Civico di Modena” (curatrice Cristiana Zanasi, a cura di: Musei Civici, presentazione: venerdì 13 ore 17.30). La seconda testimonia il percorso artistico di Oscar Sorgato, pittore di origini modenesi e protagonista del movimento del Chiarismo; in “Tenera è la luce”, i suoi paesaggi e i suoi ritratti ci restituiscono uno spaccato sociale della Milano degli anni Trenta, con una particolare attenzione alla condizione femminile. Alcune delle figure ritratte saranno animate dai racconti sonori composti per l’occasione dagli scrittori Andrea Vitali e Roberto Barbolini (curatori: Stefano Sbarbaro, Cristina Stefani, a cura di: Musei Civici, Collezione Koelliker di Milano, presentazione: venerdì 13 ore 18). A trarre ispirazione dalla mostra è anche il laboratorio “Così ti dipingo”, che permetterà a bambini e famiglie di servirsi di un’autentica sala di posa (Palazzo dei Musei, a cura di: Dida – laboratorio didattico, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-19). Sempre a cura del Dida, in collaborazione con il Teatro dell’Orsa, lo spettacolo “L’acciarino magico sono io”, con Bernardino Bonzani, porterà in scena una delle più belle fiabe di Andersen, in cui l’autore si è immedesimato nel protagonista (Palazzo dei Musei – Dida – laboratorio didattico, venerdì 13 ore 21).
Presso la Galleria Estense, con “Personart. Alla ricerca del tuo sosia in Galleria!”, tramite un software elaborato dal Dipartimento di Ingegneria di Modena allestito nella sala 21 della Galleria, si propone ai visitatori di partecipare ed interagire con l’installazione, per poi addentrarsi nel percorso museale alla ricerca dei “personaggi” che il software avrà identificato come più simili al loro volto (curatrice: Martina Bagnoli, a cura di: Gallerie Estensi, AlmageLab – Unimore, presentazione: venerdì 13 ore 11 alla presenza di Martina Bagnoli e Rita Cucchiara).
Sempre attorno al ritratto ruota l’esposizione che propone opere della Collezione e Archivio storico di BPER Banca, in un percorso che ne mostra la caratteristica di immagine parlante sospesa tra verità e illusione, tra somiglianza e idealizzazione, tra mimesi e introspezione: “Protagonisti in posa. Il ritratto tra Rinascimento e Barocco” (Modena, produzione: La Galleria. Collezione e Archivio Storico BPER Banca, curatrice: Lucia Peruzzi, Presentazione: venerdì 13 settembre ore 16:00 alla presenza della curatrice).
La visita “Un ritratto collettivo. Storie e volti da Collegio dei Nobili a Fondazione San Carlo” illustrerà uno dei luoghi più suggestivi della Modena Barocca e presenterà i giovani nobili che furono allievi dell’antico Collegio San Carlo, futura classe dirigente tra il XVII e il XIX secolo (Fondazione Collegio San Carlo, conduce: Patrizia Curti, a cura di: Fondazione Collegio San Carlo, 45’, max. 30 partecipanti, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ore 19.30).
Sabato 14 alle ore 21 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti si mette in scena la realizzazione di una celebre scena lirica, tratta dal Don Giovanni di Mozart, in cui il tema dello scambio di persona apre le porte ad una riflessione su quello dell’ambiguità della “maschera”: “Lo scambio di persona”, a cura di Modena Città del Belcanto. Tra maschere ed enigmi, le persone del Carnaval di Schumann sono invece oggetto dello spettacolo-concerto “Ritratti fantastici”, con video coreografie dei personaggi che attraversano la partitura, proiettate presso il Teatro San Carlo domenica 15 alle ore 20.30 (a cura di: Fondazione Gioventù Musicale d’Italia – Sede di Modena).
Altri ritratti, dell’umanità più varia – commesse, negozianti, studenti, medici, viaggiatori, operai e anziani – sono quelli dei quadri di Clara Malavasi in “Anime per strada” (Modena, Redecocca Art Gallery, curatori: Giuliano Della Casa, Teresa, Mariangela, Stefano e Giovanna Righi Riva, presentazione: venerdì 13 ore 17 alla presenza dei curatori).
Le opere di Flavio Pellegrini, in “Diario degli umori”, sono volti, aperti al confronto, di persone pronte ad indossare la maschera che la situazione richiama attingendo dal “personale” sedimento di esperienza (Modena, Studio d’Arte La Darsena, curatori: Angela Balestri e Siro Leonelli, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Infrangendo la barriera tra finzione e realtà, lo spettacolo “Da persona a persona” conduce il pubblico a reagire fisicamente e mentalmente a episodi della vita reale, con il teatro Forum che mette in scena dei quadri in cui ciascuno è chiamato a interpretare le forme e i rituali dell’interazione quotidiana (Modena, Palazzina Quartiere 1; con Margherita Salati, a cura di: Coordinamento delle Banche del Tempo della provincia di Modena e Reggio Emilia, con DES Modena, sabato 14 ore 15.30-18.30, domenica 15 ore 9.30-12.30).
“Ritratto scomposto” è una performance fotografica in cui l’artista Ivana Galli dedica a ogni singolo soggetto una sessione individuale di 15 minuti, penetrando l’identità degli individui che ritrae per svelarla a loro stessi (Modena, Bottega Consorzio Creativo, a cura di: Consorzio Creativo, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza dell’artista).
Nell’operare pittorico di Silvia Paci, in “Senza maschera levare”, i suoi lavori si presentano attraverso personificazioni ibride, modello vivente delle diverse personalità che vivono nell’essere (Modena, ArtEkyp Open Studio, produzione: ArtEkyp Open Studio, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza dell’artista e dei curatori).
Le opere di Marco Lombardo ed Ersilia Sarrecchia, in “Effetti personali”, hanno come matrice comune il ritratto fotografico, raccontando i personaggi attraverso l’immagine scaturita dal rapporto e dall’incontro tra artista e soggetto (Modena, Rana Rossa 3.0, curatrice: Silvia Petronici, a cura di: Rana Rossa 3.0, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza degli artisti).
La rassegna cinematografica “Portraits”, curata da Alberto Morsiani al Filmstudio 7B di Modena, presenta storie di ordinaria anormalità, con ritratti filmati di esseri umani considerati in sé o nelle loro funzioni sociali, alle prese con differenze di etnia, sesso, età, cultura. Ritratti di persone comuni però eccezionali, come il Memmo, garzone di bottega poi testimone di personaggi ed epoche irripetibili, in “Il venditore di colori” di Daniele Costantini (Ita/Svi 2019, 62′), venerdì 13 ore 19.30, o come i due adolescenti perduti del tremendo Rione Traiano di Napoli, che grazie a uno smartphone escono per qualche tempo da una “normalità” di morti e droga in “Selfie” di Agostino Ferrente (Fra/Ita 2019, 78′), venerdì 13 ore 17,50. O come gli abitanti neri di New Orleans, che cercano, anch’essi, di sfangarla col mestiere duro del vivere, in “Che fare quando il mondo è in fiamme?” di Roberto Minervini (Ita/Usa/Fra 2018, 123′, v.o. con sottotitoli), sabato 14 ore 17.10, o come un transessuale filippino ramingo per il mondo in cerca di accoglienza, in “Shelter – Addio all’Eden” di Enrico Masi (Ita/Fra 2019, 81′), domenica 15 ore 16.20, o come, infine, gli italiani qualunque di “Normal” di Adele Tulli (Ita/Sve 2018, 70′), impietosa radiografia di una esistenza conformista, domenica 15 ore 18. Ritratti, però, anche di persone eccezionali, come un tetro monaco buddista birmano, che purtroppo diventano normali quando riescono, con la loro influenza, a rendere “normale” l’intolleranza e la violenza sugli altri: “Il venerabile W.” di Barbet Schroeder (Fra/Svi 2018, 100′, v.o. con sottotitoli), sabato 14 ore 19.30.
Tutti i filosofi protagonisti della 19° edizione di festivalfilosofia sono ritratti a penna su carta da Giuliano Guatta in “Fisiognomica del pensiero” (Modena, D406 presso Studio fotografico Rolando Paolo Guerzoni, a cura di: Galleria D406, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza dell’artista). Contrapposta a questa parte di “ritrattistica ufficiale”, l’autore ha inoltre realizzato dei ritratti/autoritratti, dedicati ai maggiori pensatori del secolo scorso.
Domenica 15 alle ore 19.30 il Teatro dei Venti organizza “Malaparata”, una sfilata itinerante per le vie del centro di Modena, un’allegoria dei vizi dell’uomo che utilizza la musica, le maschere, i trampoli e gli strumenti del teatro di strada, affrontando il tema del diverso, incarnato da un Pulcinella in gabbia senza maschera.
3. Lessico dell’individuo
Messe in scena, racconti e mostre ruotano attorno a nomi propri e discendenze familiari, identità e riti di riconoscimento
Dormono, dormono sulla collina… I protagonisti degli epitaffi tombali dell’Antologia di Spoon River tornano a nuova vita con David Riondino in “Non al denaro, non all’amore né al cielo di Fabrizio De André”, omaggio d’autore all’album omonimo (1971) del cantautore ligure (Modena, Piazza Roma, a cura di: Biblioteca civica Antonio Delfini, venerdì 13 ore 21).
Sulle tracce dei nomi propri che nei secoli hanno caratterizzato gli abitanti della comunità modenese, la mostra “Nomen omen. Le carte delle identità” propone un suggestivo percorso attraverso carte e documenti conservati all’Archivio Storico del Comune di Modena, alla ricerca della nostra identità, solida ma talvolta fragile, di persone e di cittadini (Palazzo dei Musei – Archivio Storico, curatori: Gabriella Roganti, Giuseppe Bertoni, a cura di: Archivio Storico del Comune di Modena, presentazione: venerdì 13 ore 18.30). Punteggiano la mostra i racconti dal vivo, il serio e l’ironico, dello scrittore modenese Ugo Cornia: in “Scutmai. Nomi, nomignoli e altre umanità” ispirandosi ai documenti d’archivio presentati nella mostra, intreccia elementi autobiografici ad esilaranti aneddoti su nomi e soprannomi di famigliari, antiche origini e improbabili discendenze (Palazzo dei Musei – Archivio Storico, a cura di: Archivio Storico del Comune di Modena, sabato 14 ore 18; 18.45; 19.30). Sui registri canonici, traccia dei movimenti migratori, e in particolare sui registri dei battezzati di diverse epoche e di diverse località, si incentra la mostra “Battesimo” (Archivio storico diocesano di Modena – Nonantola, curatrici: Federica Collorafi, Laura Farina, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Cosa accade quando sulla terra irrompe una persona che traccia una scia indelebile, quasi fosse una meteora? “Polvere di stelle” racconta, con le performance di quattro attori, le vite di David Bowie, Margherita Hack, Amy Winehouse e Domenico Troili (Museo Universitario GEMMA, a cura di: Pensieri Acrobati, in collaborazione con: Museo Universitario GEMMA).
Il percorso guidato e breve laboratorio “Chiamami col mio nome” conduce 20 persone per ogni turno (prenotazione consigliata) a conoscere “personalmente” e dare nome alla flora urbica presente nelle strade del centro storico di Modena (Palazzo Universitario – piano terra, a cura e conduzione di: G. Bosi, G. Barbieri, F. Buldrini, P. Torri, produzione: Orto Botanico, Università di Modena e Reggio Emilia, venerdì 13 ore 15.30; 17; sabato 14 ore 10; 11.30; 15.30; 17; domenica 15 ore 10; 11.30; 15.30; 17).
Sempre dedicato all’importanza dei nomi è il dialogo tra pittura e narrazione, per grandi e piccini, “Tarantolin rabbioso. Una storia per filo e per segno”: bambini da 3 anni in su sono coinvolti nella ricerca di un nome, attraverso la nota fiaba dei fratelli Grimm (Modena, Palazzo Santa Margherita – Biblioteca Delfini, a cura di: Biblioteca Civica Antonio Delfini, con: Sassolini Tracce di Fiaba, domenica 15 ore 17, 45′). Sabato 14 alle ore 17, il laboratorio di pittura e collage “Il mio nome, il nome mio…” si ispira alla stessa fiaba per creare sperimentazioni con la pittura e le lettere del nome di bambini tra i 6 e i 9 anni (Palazzo Santa Margherita – Biblioteca Delfini, a cura di: Biblioteca Civica Antonio Delfini, con: Sassolini Tracce di Fiaba, 25 posti dal 2 settembre, previa iscrizione).
Le sculture fatte esplodere dall’artista Matteo Mezzadri nel suo studio e ritratte nel preciso momento della loro distruzione, in “L’opera e la polvere”, rievocano i tragici episodi della cronaca recente, tuttavia quelle stesse opere non scompaiono nel nulla, ma al contrario riaffermano la loro presenza, la loro stessa essenza (Modena, ROPE Contemporary Art Gallery, curatrice: Federica Petricca, produzione: ROPE Contemporary Art Gallery, presentazione: sabato 14 ore 17 alla presenza dell’artista e della curatrice).
Seguendo un processo chimico, Tommaso Mori, in “Aeterna (2019)”, genera luce a partire da una goccia del proprio sangue, del proprio io, unico e irripetibile, creando un’installazione site-specific evocativa e immersiva a testimonianza della potenzialità generativa di ogni essere umano (Modena, GATE 26A, a cura di: GATE 26A, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza dell’artista). In un gioco didattico sulla conoscenza della storia, i partecipanti del laboratorio “Memorie dei nomi” dovranno scoprire un particolare importante – un fatto, una data, un’identità – a partire da una “pietra della memoria”, una delle stele o monumento commemorativo di eventi del 900 (Modena, Casa del Mutilato, a cura di: Ass. Naz. Mutilati ed Invalidi di Guerra – sezione di Modena, presentazione: sabato 14 ore 18.30 con letture di Andrea Ferrari, venerdì 13 ore 17-20, sabato 14 ore 10-13; 17-20; domenica 15 ore 10-13).
Tra fotografia, scultura e video, facce malate, ferite identitarie e reliquiari post-umani rappresentano il Grado Zero che “Mustafa Sabbagh” in “MKUltra: personal data” rintraccia e cataloga per la cultura (Sassuolo, Galleria Paggeriarte, produzione: Comune di Sassuolo e festivalfilosofia, in collaborazione con: Galleria Marcolini, presentazione: sabato 14 ore 18.30 alla presenza dell’artista).
4. Io e noi
Singolare e collettivo, privato e pubblico, orizzontale e verticale vengono attraversati da prospettive creative
Una sorprendente accoppiata, quella tra il filosofo e critico cinematografico Roberto Escobar e l’attore Lino Guanciale, introdotti da Claudio Longhi, conversa attorno a Massa e potere di Elias Canetti per discutere le implicazioni di un pensiero che ha fatto del confine tra io e noi uno sterminato campo d’indagine: “Massa e individuo. Canetti oggi tra filosofia e teatro” (Modena, Piazza Roma, a cura di: Emilia Romagna Teatro Fondazione, sabato 14 ore 22.30).
Al rapporto tra individui e comunità è dedicata anche “VIXI. Persone e personaggi al trapasso dalla vita alla morte”, che valorizza il patrimonio dell’Archivio storico di Carpi mostrando come cerimoniali e tradizioni della ritualità funebre pubblica vengano interiorizzati e vissuti nella dimensione privata delle persone comuni, poste di fronte all’evento ultimo che caratterizza la fragilità umana (Carpi, Archivio Storico Comunale, a cura di: Archivio Storico Comunale e Centro Etnografico di Carpi, presentazione: venerdì 13 ore 18).
Un diverso slittamento tra privato e pubblico è quello della “mostra-esperienza” “L’importanza di chiamarsi Francesco” condurrà i visitatori del Palazzo Ducale di Sassuolo in un viaggio attraverso le personalità di tre duchi, Francesco I, Francesco II e Francesco III d’Este (1698-1780), ricorrendo a un sussidio immersivo tramite la proiezione di una rappresentazione simil-ologramma che metterà in scena un dialogo immaginario e impossibile fra i tre (curatori: Angela Fiore, Federico Fischetti, Simone Sirocchi, produzione: Gallerie Estensi, Unimore, presentazione: venerdì ore 18.30 alla presenza della Direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli e dei curatori).
Analogamente, con la mostra “Illustrissimo Principe et Excellentissimo Signore” si ripercorrono, attraverso i documenti conservati dall’Archivio di Stato di Modena, le diverse fasi di costruzione, legittimazione e celebrazione del potere ducale estense, dalla “persona ficta” o persona pubblica, all’individuo (a cura di: Maria Carfì, Lorenza Iannacci, Miles Nerini, Riccardo Pallotti e Annalisa Sabattini, con il coordinamento di: Patrizia Cremonini, produzione: MIBAC – Archivio di Stato di Modena, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza dei curatori, con visita guidata a cura di Paolo Cova). Correda la mostra il laboratorio “Di proprio pugno. Scrittura e personalità della firma” (con: Giorgia Filossi, a cura di: MIBAC – Archivio di Stato di Modena, domenica 15 ore 16-18).
“Nella mente di chi guarda. Memoria, dignità e identità del quotidiano” è un’esposizione collettiva che riunisce artisti di rilevanza internazionale e artisti emergenti, che attraverso linguaggi diversi raccontano l’umano e il corpo, tra storie religiose e quotidiane, valorizzando l’arte come simbolo della responsabilità verso il prossimo, della tensione all’altro e dell’educazione alla diversità, forza motrice nel dialogo tra le persone (Modena, Chiesa di San Giovanni Battista, curatori: Marco M. Coltellacci, Laura Solieri, Alessandro Mescoli, coordinamento: Federica Sala, Andrea Barillaro, Massimiliano Piccinini, Sergio Bianchi, contributi critici di: Ilaria Dall’Olio ed Enrico Turchi, produzione: Arcidiocesi di Modena – Nonantola, presentazione: venerdì 13 ore 18.30 alla presenza degli artisti e dei curatori, con performance di Karin Dolin alle ore 18.30 e dei Multispilla alle 19.30). Nella mostra dei Musei del Duomo di Modena “Corpi celesti. Reliquiari antichi e preziosi tra cielo e terra” sono esposti circa 40 reliquiari che conservano i resti mortali di persone considerate sante in virtù dei loro meriti (curatrici: Giovanna Caselgrandi, Francesca Fontana e Diana Marchi, a cura di: Musei del Duomo, presentazione: venerdì 13 ore 16.30 alla presenza delle curatrici).
L’angelo che si fa uomo è la figura centrale e iconica di intercessione celeste, presente in tutte le religioni, ed è il soggetto dell’artista Fabrizio Loschi, in “Aladiterra. L’alba di un contratto”, presso Mazzini 43 a Sassuolo (curatori: Elena Bernardi, Francesco Raffaele Mutti, a cura di: Whiteside, Discromie, Amoof Consulting, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza dell’artista). Sempre a Sassuolo, i laboratori “Sono perché siamo” mettono a disposizione spazi a misura di famiglie dove grandi e piccoli (0-14 anni), attraverso giochi e attività pratiche, sperimentano l’essere persona, nella relazione con sé, l’altro, la memoria (Villa Giacobazzi – Parco Vistarino, a cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo, sabato 14 ore 9.30-12.30; 15-19; domenica 15 ore 9.30-12.30; 15-19).
Se tra io e noi vi è connessione, è anche perché i singoli raccontano la propria identità e l’appartenenza culturale sulla propria pelle. Cinque progetti fotografici, di Castelli, De Filippo, Federzoni, Rossi, Ravera, raccontano i “Segni distintivi” che concorrono alla personalizzazione del Sé, presso il Centro Culturale G. Alberione di Modena (curatore: Gianni Rossi, a cura di: Fotoclub Colibrì BFI, presentazione: venerdì 13 ore 17.30 alla presenza degli artisti).
5. Sé come altro
La differenza che siamo, il nuovo che vogliamo diventare, la scoperta di emozioni che non conoscevamo
Sabato 14 alle ore 22, Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua raccontano in “Tra parentesi” la vera storia di un’impensabile liberazione, con la chiusura degli ospedali psichiatrici frutto dell’opera di un ampio movimento sociale, il cui leader fu Franco Basaglia. Attraverso le tante storie minime di uomini e di donne che l’internamento lo hanno vissuto sulla propria pelle si delinea una storia che non è finita e che non potrà mai finire (Sassuolo, Piazza Garibaldi).
Siamo esseri le cui funzioni vitali sono concentrate in organi involontari, viviamo se il cuore batte. Ma a cosa serve il cuore e che rapporto c’è tra cuore, persona e memoria? Chiara Valerio, in “A questo serve il cuore”, mette in scena un racconto che, dalla mitologia greca, dalla letteratura e dai cartoni animati arriva al diritto (Modena, Piazza Roma, sabato 14 ore 21).
Sulle musiche di “Schubert”, con Marco Sgarbi, Federico Nicoletta, Diana Hobel, voce recitante, testo e pianoforte si alternano e si accompagnano per raccontarci la sua vita doppiamente outsider: omosessuale e artista non (ancora) affermato, Schubert vive in un limbo, quale “non persona” costretta dietro a una maschera, una narrazione, un’identità che non gli corrisponde appieno (Modena, Teatro San Carlo, produzione: Amici della Musica Modena, venerdì 13 ore 21).
Nel percorso “Expand yourself”, otto installazioni interattive, basate su evidenze pedagogiche e supportate da tecnologie aumentative e intelligenza artificiale, porteranno il pubblico di ogni età a sperimentare tre dimensioni fondamentali del rapporto tra apprendimento e persona: immedesimazione, introspezione, informazione (Ago Modena Fabbriche Culturali – Future Education Modena, a cura di: Future Education Modena, venerdì 13 ore 17- 22, sabato 14 ore 17-22, domenica 15 ore 9-13).
Il laboratorio “Scelte di fine vita” permette di sperimentare un breve momento di Death Education, simulando, in un ambiente protetto, la compilazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento: l’esperienza intende aiutare ad affrontare le difficoltà psicologiche e culturali relative alla rimozione di malattie e perdite, attraverso l’esercizio del proprio diritto all’autodeterminazione e alla condivisione delle scelte rispetto ai propri percorsi di cura (Modena, Palazzo Universitario – Aula Magna, a cura di: Fondazione ANT Italia Onlus, in collaborazione con: Polo Museale Unimore, venerdì 13 ore 15-19, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 15.00-18.00).
La rassegna cinematografica a cura della Biblioteca Loria di Carpi si concentra sul tema de “Il doppio”, del sosia, della dissociazione. Si inizia con l’uomo duplicato in “Enemy” di Denis Villeneuve (Canada/Spagna 2013, 90′), inedito nelle sale italiane, venerdì 13 alle 21, proseguendo alle ore 22.30 con il cult “Strade perdute” di David Lynch (USA/Francia 1997, 135′), thriller allucinato come un incubo che tratta dell’incapacità di un uomo di mantenere il controllo sulla propria vita. Sabato 14 alle ore 21, si proietta il grande classico di Akira Kurosawa “Kagemusha – L’ombra del guerriero” (Giappone 1980, 153′), in cui, nel medioevo giapponese, un sosia arriva all’immedesimazione totale con l’interpretato, il valoroso principe Takeda, fino ad assumerne il valore e il coraggio di fronte alla morte; chiude alle ore 23.35 “Inseparabili” di David Cronenberg (Canada/USA 1988, 115′), con i gemelli Elliot e Beverly e un delirante triangolo.
Protagonista della sonorizzazione live di “Soundtracks – Musica da Film” è “Lo Sconosciuto” di Tod Browning, con la doppia identità di Alonzo (Modena, Palazzo Santa Margherita – Chiostro, a cura di: Centro Musica Comune di Modena – Progetto Sonda azione Residenze Artistiche, Associazione culturale MUSE – progetto Arts & Jam, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Regione Emilia-Romagna, con la Direzione di Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò, sabato 14 ore 21). Il laboratorio esperienziale di scoperta del diverso oltre la pietra, “Metope empatiche e sguardi curiosi”, pienamente fruibile dalle persone con disabilità visiva, consente di interrogarsi su cosa è persona e cosa non lo è, attraverso le creature scolpite (Modena, Museo Lapidario del Duomo, conduzione: Nadia Luppi, Cristina Mori, a cura di: Musei Civici di Modena, Coordinamento Sito UNESCO, in collaborazione con: Musei del Duomo di Modena, sabato 14 ore 19; 20; 21; 45′).
Il ricordo e l’oblio, a differenza della memoria che attribuiamo anche alle macchine, sono cifra identitaria della persona insieme con le lacrime e il sorriso: la mostra “La persona che resta” si compone di un’istallazione video-scultorea di Armida Gandini (Gustose e dolcissime), di un video e di 6 scatti fotografici di Cinzia Naticchioni Rojas, e di 5 opere pittoriche di Stella (Modena, Galleria ArteSì, curatrice: Cristina Muccioli, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza delle artiste e della curatrice).
“Sospira” è una performance site-specific, con teche installative, ideata e interpretata da Elisabetta Di Terlizzi e Laura Gibertini, il cui oggetto è la definizione dell’identità attraverso l’espressione del corpo e la narrazione dell’identità biologica precedente e successiva alla coscienza (Modena, OM Studio, a cura di: OM Studio, venerdì 13 ore 18-19, sabato 14 ore 16.30- 17.30, domenica 15 ore 16.30-17.30, 20′).
Un’installazione scultorea con le identità multiple di Teseo e Pirandello è l’opera di Laura Tarugi in “Uno: centomila, centomila: uno”, accompagnata da interventi performativi in sede di mostra venerdì 13 ore 19.30, 20.30 e 21.30 e sabato 14 ore 15.30, 16.30, 19.30, 20.30 e 21.30 (Studio Torti 10, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dell’artista).
Venerdì 13 ore 21 lo spettacolo “Persona in dialogo” ricostruirà vita e pensiero di Carlo Maria Martini, con proiezioni, letture sceniche, intermezzi musicali e testimonianze eminenti (Modena, Chiesa di San Bartolomeo; a cura di: Associazione di Volontariato “Ho Avuto Sete”, in collaborazione con: Centro culturale F.L. Ferrari, Fondazione Culturale Ambrosianeum, Istituto Luce-Cinecittà, Fondazione Carlo Maria Martini).
Nutrito è il programma del Castello dei ragazzi di Carpi. Il percorso espositivo ispirato ai libri di Clotilde Perrin “Le Emozioni siamo Noi” propone sagome tridimensionali ad altezza di bambino, che riproducono i personaggi delle storie, presentando i tratti emotivi più caratteristici e permettendo ai visitatori di giocare attraverso particolari interattivi (Palazzo dei Pio – Torre dell’Uccelliera, a cura di: Castello dei ragazzi, Franco Cosimo Panini Editore, presentazione: sabato 14 ore 19 con intervista all’artista).
La narrazione di Monica Morini, Bernardino Bonzani, “Batticuori in valigia. Paura, amore e barattoli di felicità” racconta le emozioni in storie che sono ponti e domande, formule, mantelli, ripari potenti contro ogni paura (Biblioteca ragazzi Il falco magico, a cura di: Castello dei ragazzi, con: Teatro dell’Orsa, sabato 14 ore 17, domenica 15 ore 17; 18.30). Il laboratorio creativo “Barattoli di felicità” porta i bambini dai 6 anni in su a dare forme e colori alle memorie felici (Biblioteca ragazzi Il falco magico, a cura di: Castello dei ragazzi, con: Teatro dell’Orsa, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 18, con iscrizione dal 2 settembre). Il workshop con Clotilde Perrin “Dentro di te, dentro di me. Parole e emozioni di tutti i colori” prende spunto dall’albo “Le emozioni siamo noi” e vuole stimolare i partecipanti, dai 6 agli 8 anni, a riflettere sulle emozioni, utilizzando grandi fogli bianchi e assemblandoli in piccoli pop-up (a cura di: Castello dei ragazzi, Franco Cosimo Panini Editore, sabato 14 ore 16.30, domenica 15 ore 16.30, con iscrizione dal 2 settembre).
Il laboratorio creativo “Dacci un taglio!”, dai 4 anni in su, invita a creare nuovi e originali meccanismi animati per svelare e nascondere i segreti di rabbia, tristezza, gioia, disgusto e paura (a cura di: Castello dei ragazzi, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 18).
6. Diritti della persona
Laboratori, racconti e mostre mettono a tema esclusione e inclusione, tra riconoscimento e diritti
Forse abbiamo dato per scontati, anche con i nostri figli, tanti diritti, conquistati: salari adeguati, orari umani, diritto di sciopero, all’assistenza, alla sicurezza. È doveroso ricordare, allora, le condizioni di vita, le fatiche e le lotte, delle donne e degli uomini che ci hanno preceduto: lo si farà con Pamela Villoresi in “100 anni di lavoro” attraverso racconti, musica e poesie in un affresco lungo un intero secolo (Modena, Piazza Grande, venerdì 13 ore 22).
Una donna, che si impegna per i diritti delle donne, e una vita sempre in prima linea: Edith Stein è un luminosissimo enigma, che in qualche modo riassume il Novecento e parla di noi, al punto da essere divenuta patrona di tutta l’Europa come Santa Teresa dalla Croce. Lella Costa ne ripercorre la parabola umana e si misura con il suo pensiero nello spettacolo “Ciò che possiamo fare”, domenica 15 alle ore 21 (Sassuolo, Piazzale della Rosa). Altre voci di vittime della persecuzione nazista provengono dai volti e dalle storie passate per Fossoli: volti di donne che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale e che con le loro storie raccontano una prospettiva femminile, ricostruendo la storia come tessuto di eventi umani, in “Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: Fossoli” (Ex Sinagoga, curatori: Elisabetta Ruffini, Dario Carta, produzione: Fondazione Fossoli, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza dei curatori e degli autori, interviene Roberto Rugiadi, figlio di Frida Misul). 7 donne ci vengono incontro nell’itinerario teatrale “Frida e le altre. Accogli il mio abbraccio”, offrendo un contatto diretto, tra attrice e spettatore, e un modo inusuale, intimo di visitare il Museo Monumento al deportato, attraverso le lettere delle condannate a morte delle Resistenza (a cura di: Fondazione Fossoli, con: Teatro dell’Argine, venerdì 13 ore 20-22).
Nessuno lo sapeva, ma tra il 1943 e il 1944, l’eroe dello sport Gino Bartali, a rischio della vita, ha salvato centinaia di persone dalle persecuzioni nazi-fasciste. Nel suo racconto “Il vecchio e il Tour”, Michele Dalai, con l’ausilio dell’archivio sonoro per la regia di Guido Bertolotti, ricostruisce la storia di un uomo giusto, campione di sport e sacrificio (Carpi, Piazza Martiri, sabato 14 ore 22.30).
A Modena, la mostra “Keine Papiere” di Collettivo FX denuncia la condizione di chi non ha documenti, l’apolide, esponendo biglietti e “fotografie viaggiate”, un dipinto a tappe che diverrà libro d’artista (Palazzo dei Musei – Biblioteca Poletti, curatrice: Carla Barbieri, a cura di: Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dell’artista).
Dove sono le nostre radici in quanto Persone? È sufficiente nascere umani per essere umani? Il percorso sensoriale, di circa 10′, proposto da “Considerate che questo è un uomo” accosta il passato al presente, invitandoci a ribaltare lo sguardo per riflettere e puntare a un futuro più umano (Modena, Centro di accoglienza “Papa Francesco” – chiostro, a cura di: Bambini nel deserto ONLUS, Caritas diocesana modenese, Centro missionario diocesano-animazione e formazione, venerdì 13 ore 16-21; sabato 14 ore 10-13.30; 16-21; domenica 15 ore 10-13.30; 16-21).
Presso il Complesso San Filippo Neri di Modena, “Riti d’accoglienza” presenta alcuni dei “contesti de-umanizzanti” accaduti nella storia fino ai giorni nostri, attraverso video, testimonianze, foto, articoli di giornale, portando singoli o gruppi a conversare con chi – nella propria vita e nella propria professione – ha compiuto un “percorso di ri-umanizzazione” (a cura di: Fondazione San Filippo Neri, 30′, sabato 14 e domenica 15 ore 11-13; 16-19).
Nei laboratori “In prima persona. Esercizi di riconoscimento” i temi della solidarietà e del volontariato saranno presentati in maniera giocosa, interattiva e divertente, per tutte le età (Modena, Piazza Matteotti, a cura di: Centro Servizi per il Volontariato di Modena, sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 15-19).
La donna in musica si rivela di volta in volta in una veste simbolica, vincente, sofferente, assoggettata: “Donne senza maschera” presenta la musica al femminile nel Seicento presso la Chiesa di San Bartolomeo di Modena (a cura di: Grandezze & Meraviglie Festival Musicale Estense, sabato 14 ore 21).
Presso il Teatro San Carlo di Modena, invece, “Ogni mare ha un’altra riva” mette in scena la storia di due fratelli, che si perdono e si ritrovano lungo la rotta dalle acque del Mediterraneo al canale Saint Martin di Parigi, sottratti all’indifferenza statistica e restituiti alla loro dignità di individui (produzione: Associazione Artisti Drama, sabato 14 ore 21).
Il tema scelto per la mostra fotografica “Invisibile” è l’invisibilità della persona, che in molti casi corrisponde alla “non-persona”, figura spogliata di personalità, essere a cui non è riconosciuto lo statuto di individuo responsabile e la titolarità di diritti e doveri, umani e civili (Modena, Complesso culturale San Paolo – Cortile del Leccio, curatrice: Maura Pozzati, a cura di: Associazione Donne Fotografe – ITALIA, presentazione: sabato 14 ore 17 alla presenza della curatrice e delle artiste).
Tre giorni per ampliare la propria conoscenza del Pilastro europeo dei diritti sociali, con “WelFARE? Benfatto!”, che presenta il progetto su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione (Modena, Palazzo Comunale – Galleria Europa, a cura di: Comune di Modena – Centro Europe Direct, con il sostegno di: Rappresentanza a Milano della Commissione europea).
Quasi sempre invisibili, le vittime della guerra reclamano il riconoscimento del loro diritto di umanità: “L’Ospedale di tutte le guerre – The Hospital of all the Wars” di Alessio Mamo, Marta Bellingreri è una mostra fotografica che, attraverso undici storie, racconta l’inizio di un nuovo capitolo per altrettante vittime dei conflitti (Modena, Complesso San Paolo, produzione: Medici Senza Frontiere, presentazione: sabato 14 ore 18 alla presenza degli autori).
Il percorso teatrale “Attraver-siamo” porta gli ospiti dagli 8 anni in su in viaggio sulle orme di Enea, facendo emergere i temi dell’accoglienza, del diverso, del nuovo. Il pubblico si ritroverà a vivere diversi ruoli, ad essere straniero e – all’opposto – ad essere colui che accoglie lo straniero (Sassuolo, Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine, a cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete, venerdì 13 ore 16.30; 17.30, sabato 14 ore 10.30; 11.30; 16.30; 17.30, domenica 15 ore 10.30; 11.30; 16.30; 17.30).
Il gioco di ruolo educativo online “Hold The Line – Scelte di confine. Nei panni di una persona migrante” stimola i partecipanti a vivere, come sulla propria pelle, le possibili vicissitudini e le difficoltà delle loro scelte che caratterizzano, sin dal momento di approdo nel nuovo Paese, il percorso delle persone migranti richiedenti Protezione Internazionale (Sassuolo, Via Cesare Battisti, a cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo, venerdì 13 ore 16-19, sabato 14 ore 10-13; 14-19; domenica 15 ore 10-13; 14-19; ci si iscrive sul posto oppure su Eventbrite, 40′).
Con “Scarti? La dignità non si butta”, un’installazione in più “stanze” esplora il tema della “dignità” e del ridare valore a ciò che viene considerato “scarto” (oggetti e persone), concludendosi con un percorso iconografico e fotografico che mostrerà casi eloquenti del passaggio da scarto a valore (Sassuolo, Villa Giacobazzi – Parco Vistarino, a cura di: il Melograno e Nuovamente, in collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo, sabato 14 ore 10-12; 16-18; domenica 15 ore 10-12; 16-18).
Francesco Cannadoro in “#cucitialcuore. Oltre gli ostacoli” documenta con immagini e filmati la difficoltà di integrazione delle esigenze connesse alla disabilità (in particolare quella infantile) in una società, quella italiana, che non è ancora “a misura” di disabile (Modena, Salotto Culturale Aggazzotti, curatori: Maja Argenziano, Renzo Pavignani, Lorenzo De Vinco, Elisa Perri, a cura di: Ideas4u, presentazione: venerdì 13 ore 18 alla presenza dei curatori e dei protagonisti, con letture di Daniele Sirotti).
La mostra “Lo avete fatto a me” viene raccontata da Luigi Ottani con otto volti incorniciati, mentre Roberta Biagiarelli, autrice teatrale e curatrice della mostra, realizza un’ambiente vocale-musicale che accompagna il visitatore nel percorso (Modena, Complesso San Paolo, a cura di: Babelia & C. Progetti Culturali, performance: sabato 14 ore 19.30 alla presenza dell’artista e della curatrice).
Il concerto di Ologramma “…anche fragile”, attraverso un percorso nella musica d’autore, presenta la forza del suono e del riconoscimento reciproco attraverso le vibrazioni, i toni, le storie che aiutano a non sentirsi soli, condividendo la propria fragilità con gli altri (Modena, Piazza Roma; produzione: Istituto MEME Modena, CEMU Centro Europeo Musicoterapia, UPGB Università Popolare “Gregory Bateson” Modena, sabato 14 ore 18).
Due spettacoli a cura del Comune di Sassuolo si inseriscono nella serie di produzioni “teatro in casa”, per un numero limitato di spettatori e obbligo di prenotazione, con la regia di Ennio Trinelli e in collaborazione con GaiaitaliapuntocomEdizioni, festival Urla dal Silenzio, Cooperativa Sociale Svoltare ed Europa Teatri: in “Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese. Racconto di una fuga” il giovane attore Pierre Panival Bangouri ci racconta un emozionante spaccato della cultura del suo paese tra tradizioni, danze, cultura e devastazione morale, politica, sociale (venerdì 13 ore 19, sabato 14 ore 19, domenica 15 ore 19), mentre in “Jeux du Sable. Una traversata del deserto” Guainou Ibrahim testimonia il dramma di un’intera generazione di esseri umani in pochi metri quadrati, partendo da un gioco di bambini con la sabbia che scivola dalle mani ed alcuni bastoncini (venerdì 13 ore 21, sabato 14 ore 21, domenica 15 ore 21).
I Cortili di Ago propongono a Modena due serate speciali per il festivalfilosofia dedicate al rap, genere in cui si esprime la soggettività e la voglia di riscatto, a partire dalle esperienze della marginalità urbana: venerdì 13 alle 21.30 gli Assalti frontali in concerto in “Periferie della città, centro dell’anima”, mentre sabato 14 alla stessa ora Murubutu, in una serata di parole e musica, presenta “La cura del rap” (Modena, Ago Modena Fabbriche Culturali, a cura di: Ago e Laika Mvmnt).