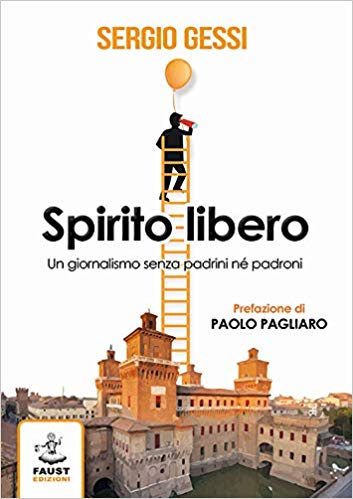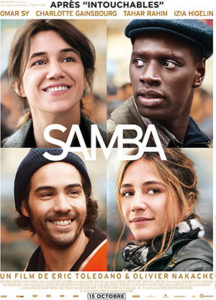Il nostro sistema di sviluppo, improntato alla (e sulla) crescita finanziaria, è profondamente sbagliato, crea disuguaglianze, funziona solo per pochi, non considera la condivisione, ignora la cooperazione e si basa su confusioni macroeconomiche e sul monopolio assoluto del sistema di informazione che ha il compito di oscurare qualsiasi notizia possa tendere a chiarire le dinamiche della creazione delle scelte politiche.
Fatta questa premessa, e considerato che siamo prossimi alle elezioni (europee e comunali), cosa si può pretendere da coloro che vogliano rappresentarci? Semplicemente che portino avanti delle proposte radicali, un cambio di prospettiva dal punto di vista antropologico, sociologico e culturale. Niente di particolarmente complicato, in fondo. L’importante è che non ci parlino del colore delle tende da attaccare alle finestre dell’edificio che sta crollando.
La gente comune si sta accorgendo che qualcosa non va nel rapporto che dovrebbe esistere tra promesse e realizzazione delle stesse. Nota che il sistema si sta avvitando su se stesso, che la crisi non passa, ma anzi si scorre da una recessione grave a una recessione meno grave, attraverso una recessione così così. La gente comincia a chiedersi se non ci sia qualcosa di sbagliato nelle ricette politiche ed economiche, e anche a interrogarsi sull’integrità di chi le ha portate avanti fino ad adesso. Addirittura (!) sta imparando a controllare su google se chi oggi promette sia già stato Presidente del Consiglio, Ministro o Sindaco, almeno dal 2008 a oggi.
Anche a Ferrara, certo. Il Pd non ha funzionato sulle grandi questioni, non ha rottamato, non ha diminuito la disoccupazione, non ha frenato la chiusura delle aziende, non ha difeso il risparmio, ma durante il suo interregno gli amministratori delegati sono rimasti al loro posto, la ricchezza non ha smesso di crescere, ma si è accentrata sempre di più, le banche esistono ancora, mentre i risparmi si sono volatilizzati e ci si sente meno sicuri nel proprio Paese, nella propria città e persino nella propria casa.
E la gente se ne sta accorgendo, anche a Ferrara. Si accorge che qualcosa non sta funzionando e si traveste da leghista perché chi vuole mantenere il potere sulle scelte sta fingendo ancora, ma in maniera diversa e, se possibile, più articolata.
Per certe persone, dal 2008 ad oggi, non è mai venuto il momento di prendersi qualche responsabilità, di uscire dallo schema “ce lo chiede l’Europa”, “lo impongono i mercati”, “non ci sono soldi” e via discorrendo. E non c’è tempo di farlo perché, come al solito, il tempo sta finendo e il cielo sta crollando sotto i colpi giornalieri dei carri armati fascisti e della destra oscura che ha osato persino elargire un reddito di cittadinanza agli italiani fannulloni, come mettono in guardia Forza Italia e la Confindustria.
Il tempo è di nuovo finito, e allora chi può spinge sulla solita nuova vecchia strada. Si grida “al lupo al lupo”, che oggi è Salvini mentre nel 2008 era lo spread e domani chissà, magari il rivoluzionario cubano Di Battista. Bisogna allora affrettarsi a firmare l’appello di Calenda che invita a stringere il legame con l’Unione Europea (premio Nobel per la pace nonostante le bombe e gli interventi armati nel mondo, nonostante la Grecia e la Bce), in maniera tale che tutto rimanga uguale senza rischiare di cambiare qualche principio di base alla struttura dell’inganno.
E Calenda, addirittura, si presenta come il nuovo che avanza, un nuovo che sarà sicuramente in grado di tirare dentro i refrattari della ‘verace’ sinistra di Leu, amica del popolo e dei diritti (purché non siano diritti sociali ovviamente), e, quindi, se vogliamo continuare a tenere la testa ben conficcata nella sabbia, dobbiamo firmare il suo appello ovviamente sostenuto dal Pd sempre attento a non smentirsi (LEGGI QUI), ignorando quello di Malvezzi per una economia umanista (LEGGI QUI).
Ma mentre aspettiamo un appello a nome dei cittadini e il sistema si avvita su stesso, qualcosa comincia a scricchiolare e a seguire il sentimento popolare. IlSole24ore titola “Recessione alle porte, il modello ‘solo export’ non funziona più” e sapete cosa vuol dire? Che possiamo cominciare a segnare qualche punto sulla strada della chiarezza e delle scelte fatte da qualche governo del recente passato. La soluzione non era quella che Monti ci aveva propinato, ma l’esatto contrario, ovvero non doveva essere “distrutta la domanda interna” (https://www.youtube.com/watch?v=LyAcSGuC5zc), come aveva dichiarato, ma andava sostenuta. Perché la ricchezza per un Paese è quello che riesci a creare e a trattenere nel tuo circuito interno. Viene prima l’economia del territorio, della regione, del Paese e poi la tua capacità di esportare l’eccesso. Perché quando un Paese si sviluppa attraverso l’esportazione, necessariamente qualcun altro è costretto ad importare e a svilupparsi di meno.
Esportiamo più formaggi a spese di chi produce formaggi in un’altra parte del mondo, ma il progresso reale sarebbe produrre gli stessi formaggi preoccupandosi che il Paese che li produce li possa acquistare altrimenti sarebbe (anzi lo è) come dire che i paesi africani sono ricchi e felici perché si ammazzano nelle miniere per estrarre diamanti che non potranno mai regalare alle mogli.
Un cambio di prospettiva, appunto. Cooperazione e sostenibilità umana e ambientale, invece che concorrenza sfrenata e legge del più forte che, come sa chi ha studiato un po’ di storia, rende il popolo semplice ragioniere del benessere altrui.
Il sistema scricchiola e Monti, Visco, Radio24 con Giannino provano a riposizionarsi (poco poco, giusto per dire che loro sanno e sono bravi anche se non fanno) ed ecco che in fondo la spesa pubblica, in periodi di recessione, si può fare. Quindi lo Stato potrebbe intervenire adesso, compromettendo la divina neutralità dello stesso, e spendere. Probabilmente lo dicono perché se il sistema si avvita troppo, allora banche, finanza e industriali ci rimettono qualcosa, mentre ieri, quando bisognava aiutare i piccoli imprenditori e i risparmiatori, non si poteva fare.
Dunque sbagliato affidarsi alla crescita attraverso le esportazioni e sbagliato vietare allo stato l’intervento in economia, ma questo non cambia il fatto che abbiamo dovuto sopportare, per politiche sbagliate, consolidamento fiscale (aumento delle tasse) e diminuzione dei salari e delle pensioni (oops… aumento della produttività). L’unica cosa che ci resta è il ricordo, per non cadere negli stessi errori davanti ad una scheda elettorale.
Ma la gente (sempre la stessa) se n’è accorta. Sta capendo che questo sistema non funziona, e qui sta il fatto nuovo (dispiace per il compagno Fratoianni, ma era meglio Che Guevara). La gente sta capendo e ha poche persone a cui affidarsi per portare avanti le proprie istanze, e allora si affida a Di Maio e Salvini che rispondono alla testa delle persone parlando con la pancia. Rispondono ad un sistema di sviluppo sbagliato, certo con mille contraddizioni e con la strategia del gambero, ma la gente si aggrappa a loro perché le cassiere sanno che la domenica è meglio stare con la famiglia, piuttosto che tenere aperta la coop. Ma il Pd, il partito del popolo, risponde che tenendo aperta la coop di domenica si assicurano più posti di lavoro, perché meglio lavorare di più, fare i turni di domenica, accettare limature a salari e diritti che stare in mezzo alla strada.
Ed è qui che la sinistra si perde e perde, perché dimostra ancora una volta che non vuole capire ciò che altri, invece, stanno capendo, si stanno risvegliando dal torpore e pretendono una reale attenzione che tanti, in particolare al Sud, faticano a credere stia venendo dalla Lega (Nord).
Qualcosa non va nella narrazione e ce ne stiamo accorgendo. La gente si è accorta che anche cedendo su salari e diritti come gli è stato chiesto dai partiti della sinistra in sintonia con Confindustria e il guru della finanza Serra (l’amico e consigliere di Renzi), anche aggrappandosi all’Europa della Germania, la disoccupazione è all’11% (mentre lì tende al 3%), le scuole ci cadono in testa, i libri lo Stato non li passa nemmeno per lo studio dell’obbligo, la sanità peggiora e i servizi diventano una chimera… Ma come? Confindustria e Pd e Forza Italia e Più Europa parlano di “industria 4.0” e dell’Europa che assicura i diritti, ma la tecnologia toglie lavoro ed esistono ancora gli straordinari?
Ma dove sono i diritti che il sistema finanziario-capitalista ci doveva assicurare, insieme al benessere e alla crescita esponenziale? Abbiamo meno tempo libero, meno servizi e nemmeno sappiamo più cosa aspettarci dal futuro, in questo disastro contemporaneo dove ognuno grida, etichetta e confonde senza freni. Non è più un diritto il lavoro e nemmeno la famiglia. La ricerca della produttività ci impone di lavorare facendo gli straordinari per comprare l’iphone ai figli che però ci sfuggono comunque e nonostante il registro elettronico. In questo pluridecennale disastro, il problema sarebbe il governo M5s-Lega?
La gente ha capito che non c’è niente da capire e stanno firmando una cambiale in bianco a chi sta dimostrando almeno un po’ di empatia nei loro confronti. E questo per colpa di chi ha venduto fumo per decenni, conformandosi e consolidando un sistema ineguale e a sviluppo verticistico, addirittura considerando quasi una sciocchezza la richiesta di più attenzione alla realtà di tutti i giorni, alla fatica di vivere la quotidianità, preferendo sbracciarsi per affari più “mediatici” come la barca in mezzo al mare che non trova un porto sicuro.
Ed allora, quando parla Salvini si riempiono le piazze semplicemente perché dà l’idea di voler andare, insieme a Di Maio, verso la riaffermazione della presenza dello Stato, di voler ridare centralità alla spesa pubblica, alla direzione politica della cosa pubblica, difendere la democrazia e lo spazio democratico attraverso la sovranità politica ed economica. E la gente apprezza perché comprende che non esiste il pericolo di una destra estrema al governo, fiuta l’inganno dell’esagerazione di gridare ad un pericolo razzismo nel Paese, sa che in Veneto e in Lombardia non è stato ripristinato il sabato fascista ma che, anzi e purtroppo, anche lì è ancora imperante il sistema di sviluppo neoliberista. E che si potrebbe fare meglio, certo la luce è altrove e non siamo ingenui, ma che Monti, Cottarelli, Visco, Giannino e Ilsole24ore hanno fatto e detto molto peggio di così.
Archivio: dichiarazioni di Mario Monti alla Cnn
in copertina illustrazione di Carlo Tassi