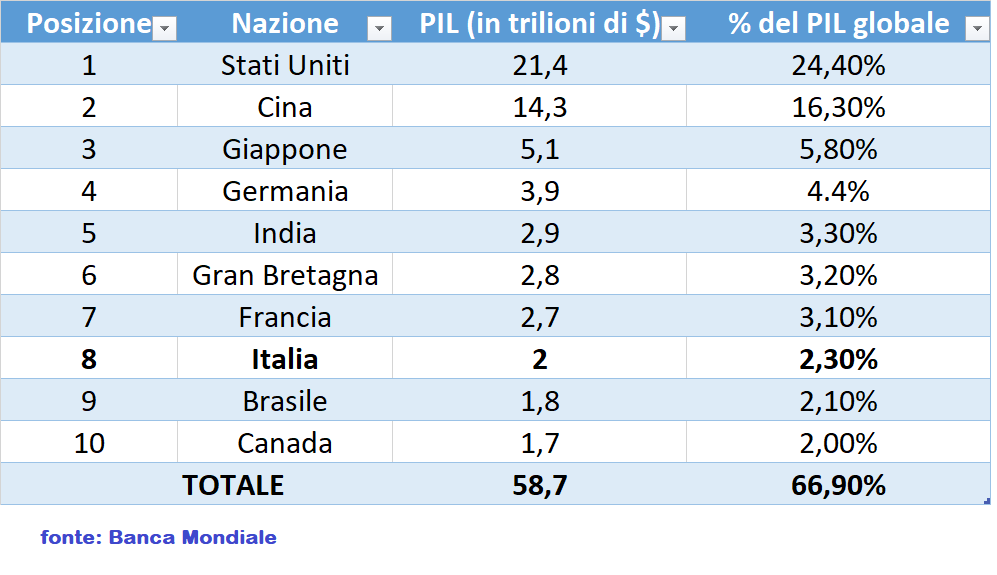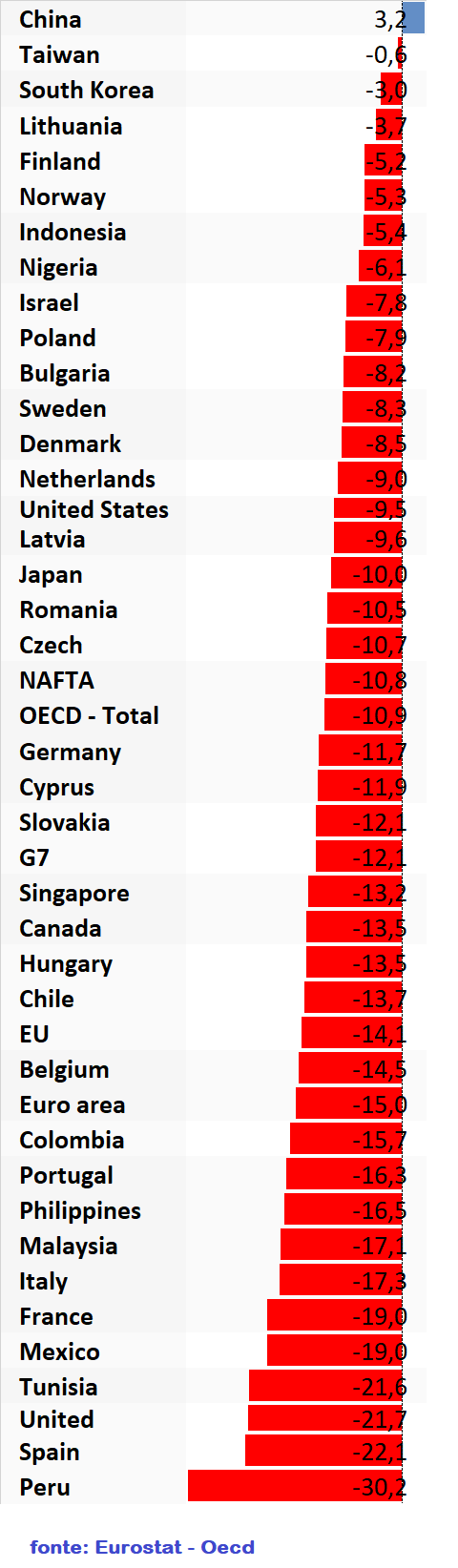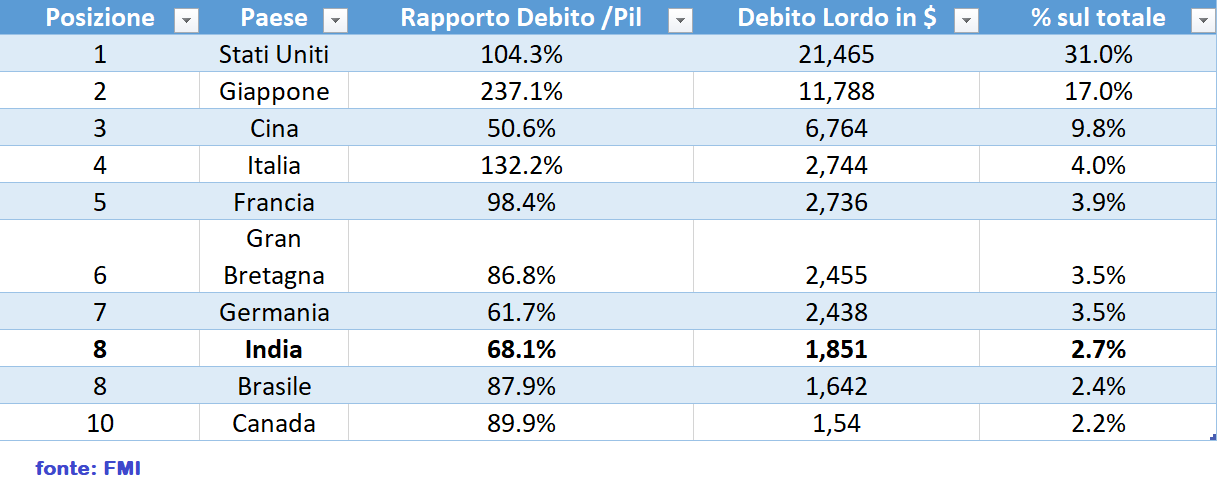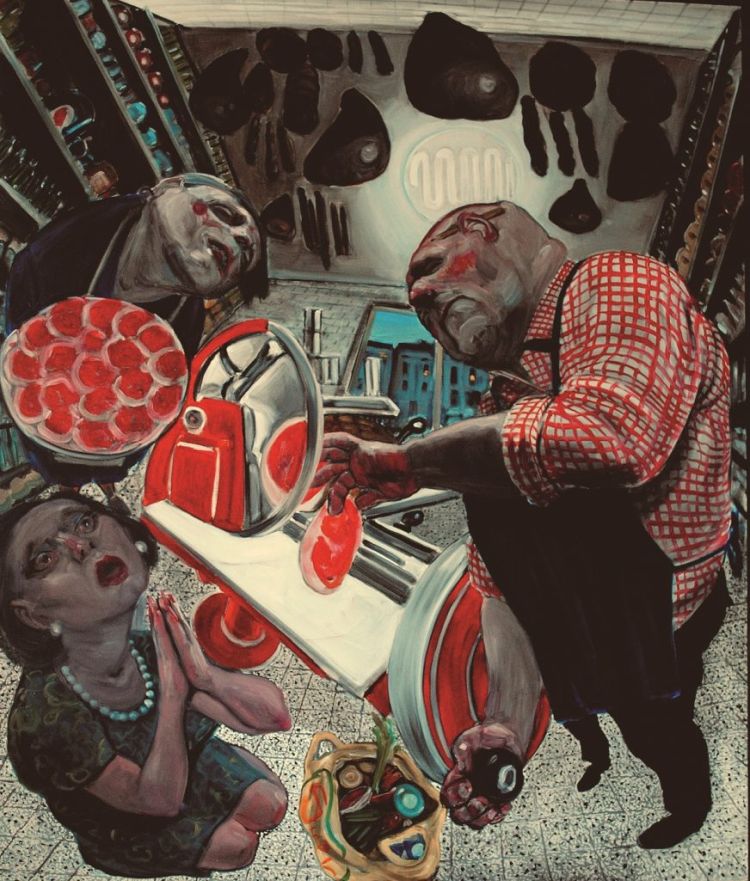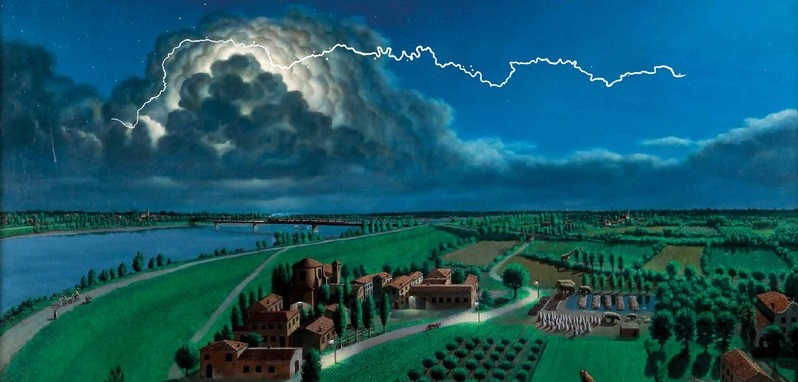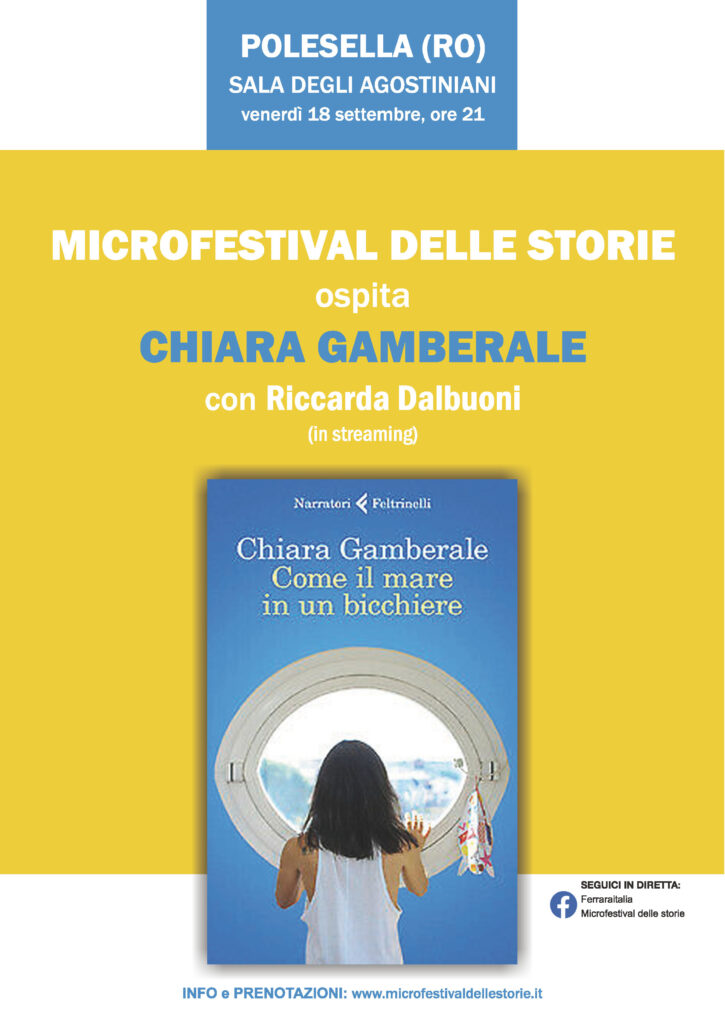Il segreto del tempo l’ho imparato in montagna, soprattutto al Passo della Passo della Mendola dove ci recavamo quand’ero in seminario. Ogni giovedì c’era l’appuntamento con la gita lunga; si dormiva anche in rifugio. Civetta, Catinaccio, Brenta, il Sentiero Orsi e la Ferrata Tridentina e le sue sorelle sul Sella, la Grande Fermeda nel gruppo delle Odle. Ma un’analoga esperienza l’ho sperimentata anche con i campi estivi della parrocchia; percorsi meno impegnativi, ma pur sempre su sentieri impervi, ripidissimi, a Dobbiaco e nella zona del Ortles.
Salire per incontri, mi dicevo ogni volta alla partenza. Si va a scuola dalle montagne a imparare il segreto del tempo. Un momento ti libera, e poco dopo ti imprigiona, ti rallegra e ti impaura, t’avvicina e t’allontana; sei legato e sciolto, sotto sopra, come in una lotta. Come Giacobbe ferito, rimani nello scontro e impari così la pazienza, il segreto del tempo: una ferita d’anca, ma più ancora il dono di una presenza, uno scambio: nel volto dell’altro il tuo, dalla sua libertà la tua.
Salire per incontri che non si dànno mai che per un istante lunghissimo. Che fanno la coscienza profonda di una profondità finissima, sigillo messo sul cuore, sigillo di un abbraccio (Ct 8, 6).
Salire per incontri, e subito non sai che entrando in ogni passo crei la distanza, misura del tempo con l’altro. Come attraversando il Polo, l’ago nella bussola si volge indietro e tu invece di seguirlo ti allontani. Eppure, salendo più in alto, il vento tra le rocce ti sussurra piano: è il tempo del disgelo degli affetti, del dono di un incontro che trasforma. E una volta giunto, è il tempo di sottomettergli il cuore, perché il tempo, non diversamente dall’amore, dischiude in modo promettente le potenzialità della libertà. «Dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie» (Pr 23,26); si dice ancora nel Cantico: «Un ricordo è l’inverno e, caduti i piovaschi, torna la terra coi fiori a sorridere. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è piacevole, e il tuo viso è leggiadro» (2, 11; 14).
Ecco: il segreto del tempo va riconosciuto come il ‘poter essere dello scambio’, come poter essere ‘della relazione e della stessa libertà’. Lo coglie con icastica efficacia il monaco Ghislain Lafont secondo cui «Il tempo fa emergere la simbolica dello scambio e quella dell’altro». In ogni tempo infatti ci è data la possibilità di far nascere e avviare relazioni in cui la libertà si rischia nell’incontro, come dono di sé, come amore appunto. È il darsi del tempo ‘qualificato’, ‘di qualità’, che riscatta il ‘tempo qualunque’. Kronos è salvato dalle acque dell’oblio, dell’inutile e dell’evanescente, da Kairos, il tempo opportuno, propizio per un evento: «sorpresa dopo tanto di un amore»; incontro che trasforma; passaggio di soglia, dimora provvisoria, ma necessaria per realizzare passi di comunione.
Questa economia del tempo, dell’avanzare e del ritrarsi, segnata dalla discontinuità e dalla ripresa, ci rassicura che anche nei momenti di rottura, nelle fasi di perdita, che rendono la vita stanca, insignificante e vuota si nasconde novità, l’apparire di qualcosa simile ad un nuovo inizio, una «rottura instauratrice» ‒ direbbe Michel de Certeau ‒ che mette di nuovo tutto in movimento.
E come non pensare, parlando di “rotture instauratrici”, al Concilio Vaticano II: una “discontinuità nella continuità” per l’officina bolognese della Storia del concilio in cinque volumi; per Benedetto XVI una continuità nella riforma. Che Papa Francesco ha voluto riprendere con l’Evangelii gaudium, esortando le comunità cristiane ad essere chiese in uscita, con stile sinodale per una riforma missionaria. Egli ci invita a «prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare….Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (n. 27).
Per realizzare questa conversione Francesco indica quattro principi generativi di prassi pastorali, in contesti di tensioni bipolari proprie di ogni realtà ecclesiale e sociale (EG 221). Tra di essi, vi è l’affermazione, sulle prime oscura ma in realtà pregna di implicazioni, secondo cui il tempo è superiore allo spazio. «Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La pienezza provoca la volontà di possedere tutto e il limite è la parete che ci si pone davanti. Il ‘tempo’, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi e il momento è espressione del limite che si vive in uno spazio circoscritto. … Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo».
Se anche nella Chiesa si privilegiano gli spazi di potere, invece che la pazienza dei tempi necessari al divenire dei processi, si cade nella corsa all’autoaffermazione, si dimentica il bene comune in favore di quello individuale. Quando è lo spazio a prevalere sul tempo, si finisce per arraffare il più possibile, rincorrendo l’attimo fuggente per escludere ogni concorrenza. In questo modo, tutto si congela, dalle riforme ai processi di trasformazione, scadendo nel tradizionalismo del ‘si è sempre fatto così’, che mortifica sul nascere ogni spinta innovatrice. Così ci si ripiega sull’assistenzialismo che genera dipendenza spirituale, liturgica, sacramentale, invece di attivare processi di lungo periodo, di favorire una conversione dello sguardo: dalle strutture alle relazioni e ai volti delle persone e alle loro storie. «Dare priorità al tempo – dice Francesco ‒ significa occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzioni chiare e tenaci».
C’è un passaggio nel documento della Congregazione del Clero uscito un mese fa sulla “conversione pastorale della comunità parrocchiale”, che si riferisce a un territorio esistenziale in cui devono ripensarsi e ricollocarsi le parrocchie, anche quelle riunite in “unità pastorale”. Ciò mi ha richiamato alla mente il pensiero di Padre Yves Congar, uno dei padri dell’ecclesiologia conciliare, il quale parlava, oltre che del vangelo della gioia, di una “Chiesa della soglia“, dai confini più fluidi, abitata anche da persone con una fede in ricerca di speranza.
Un’immagine, quella di una Chiesa in uscita e in ascolto, che ben ritrovo in due haiku giapponesi, che suscitarono il benevolo sorriso dei miei confratelli quando glieli riportai durante un incontro: «La campana del tempio tace,/ ma il suono continua/ad uscire dai fiori». Matsuo Basho (1644 – 1694); «Spuntano i germogli/ al tronco di un grande albero/ Poggio l’orecchio». Ozaki Hosai (1885-1926). Con queste immagini, allora come adesso, vorrei sottolineare l’importanza di ripartire dalle relazioni, sia a breve come ad ampio raggio, e la necessità dello stare insieme, di perdere tempo con le persone, creando narrazioni vitali e reti di comunicazione sensibili ad un territorio divenuto prevalentemente esistenziale.
«Nelle trasformazioni in atto ‒ così l’istruzione della Congregazione ‒ nonostante il generoso impegno, la parrocchia talora non riesce a corrispondere adeguatamente alle tante aspettative dei fedeli, specialmente considerando le molteplici tipologie di comunità. È vero che una caratteristica della parrocchia è il suo radicarsi là dove ognuno vive quotidianamente. Però, specialmente oggi, il territorio non è più solo uno spazio geografico delimitato, ma il contesto dove ognuno esprime la propria vita fatta di relazioni, di servizio reciproco e di tradizioni antiche. È in questo “territorio esistenziale” che si gioca tutta la sfida della Chiesa in mezzo alla comunità. Sembra superata quindi una pastorale che mantiene il campo d’azione esclusivamente all’interno dei limiti territoriali della parrocchia, [pastorale] che appare segnata dalla nostalgia del passato, più che ispirata dall’audacia per il futuro».