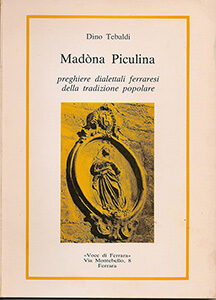Bologna – La Regione Emilia-Romagna estende la propria azione di prevenzione e controllo contro il virus. A partire da test sierologici rapidi in farmacia – con esito in soli 15 minuti – per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, destinati a una nuova, ampia, fascia di popolazione, che potrà arrivare fino a due milioni di cittadini, quasi un residente su due in Emilia-Romagna. Chi risulterà positivo, farà il tampone nasofaringeo per la conferma o meno dell’eventuale contagio da Covid.
Operazione possibile grazie all’accordo siglato oggi stesso con le associazioni di categoria territoriali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
Una campagna senza precedenti rivolta al mondo della scuola, dopo quella iniziale su docenti e operatori. L’invito a partecipare è per alunni e studenti degli istituti di ogni ordine e grado, genitori, fratelli e sorelle e altri familiari conviventi, ma anche gli universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna. Una platea potenziale di circa 2 milioni di persone che a partire dal 19 ottobre, e fino al 30 giugno 2021, potranno gratuitamente, e su base volontaria, prenotare ed effettuare il test nelle farmacie convenzionate aderenti all’accordo. L’auspicio è che già nei mesi di avvio, almeno il 20% di loro aderisca a questa misura di contrasto alla diffusione del Coronavirus: 400mila persone.
Nella fase iniziale il nuovo provvedimento voluto dalla Giunta regionale riguarderà dunque un target ben preciso, e cioè tutta quella parte del mondo scolastico non ancora sottoposta a screening; in un secondo tempo, anche in base all’andamento dell’epidemia e all’esito dei test, lo screening potrà rivolgersi ad altre fasce di popolazione, sempre in modo gratuito.
Ai nuovi test sierologici rapidi, si aggiunge una seconda leva: i tamponi rapidi – 2 milioni acquistati dalla Regione e anche qui esito in 15-20 minuti – da utilizzare dal 26 ottobre nella scuola e negli ambiti lavorativi pubblici e privati a maggior rischio. Sia per aumentare ancora la capacità di screening sia per poter svolgere velocemente verifiche estese (per esempio a un’intera classe) in presenza di positività e quindi ridurre al minimo possibili quarantene o i tempi di avvio di qualsiasi misura di tutela.
Infine, lunedì 12 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con molte più dosi rispetto all’anno scorso e in anticipo rispetto sempre al 2019, vista l’utilità che potrà avere nella gestione delle diagnosi Covid, essendo simili i sintomi a quelli dell’influenza.
Novità importanti per l’intera regione, da Piacenza a Rimini, illustrate oggi in videoconferenza stampa dal presidente Stefano Bonaccini, dall’assessore alle Politiche per la salute, Raffale Donini, e dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate.
“Un altro strumento di grande utilità, veloce e ancora una volta gratuito per i nostri cittadini, con cui rafforziamo ulteriormente quella ‘caccia’ al virus che ormai da mesi ci vede impegnati senza sosta- ha sottolineato il presidente Bonaccini-. Le farmacie convenzionate sono parte integrante del nostro servizio sanitario e costituiscono veri e propri presidi sul territorio; in un’ottica di prossimità e di vigilanza sulle esigenze di salute della popolazione, possono proporre al cittadino di aderire a servizi di assistenza che puntano anche alla prevenzione. Di qui, l’idea di stringere questo accordo con le associazioni di categoria, che ringrazio davvero per la collaborazione, per allargare ulteriormente la platea delle persone su cui effettuare la ricerca anticorpale. Nuovi test sierologici, più vaccini antinfluenzali e due milioni di tamponi rapidi: vogliamo essere pronti a contrastare il virus, al quale non dobbiamo dare tregua, anche in questa fase che vede numeri in risalita, per non disperdere i risultati del grande lavoro fatto dal Paese nella fase più dura dell’emergenza e continuare a garantire una ripresa in sicurezza. Ma la cosa più importante- chiude il presidente- è continuare a rispettare rigorosamente le regole già esistenti: distanziamento, uso delle mascherine e cura dell’igiene, lavandosi spesso le mani”.
“Rafforziamo la nostra capacità di intercettare il virus di fronte all’attuale curva epidemica, che impone una nuova, ulteriore attenzione, sia nella capacità di testare la popolazione che nell’azione di tracciamento, scovando quindi quanti più asintomatici possibile- ribadisce l’assessore Donini-. Vogliamo dare la possibilità di sottoporsi gratuitamente allo screening a un’ampia fascia di popolazione, ripeto, asintomatica: quella che viene quotidianamente a contatto, direttamente o indirettamente, con il mondo della scuola. Il nostro augurio è che in tanti decidano di aderire, sfruttando quest’opportunità. Con i tamponi rapidi, inoltre, avremo la possibilità di andare a uno screening esteso della popolazione, consolidando in maniera determinante la nostra capacità di individuare, circoscrive e spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai”.
Test sierologico rapido in farmacia: per chi, come, in quanto tempo
Il target preciso per questo screening sono dunque i genitori dei bambini e degli alunni/studenti (fascia d’età 0-18 anni e maggiorenni se frequentano la scuola secondaria superiore), gli alunni/studenti stessi, i loro fratelli e sorelle, e altri familiari conviventi. L’offerta dell’accertamento della risposta anticorpale attraverso il test diagnostico sierologico rapido può riguardare dunque anche i minori, a condizione naturalmente che ci sia il consenso dei genitori/tutori/affidatari (uno dei quali deve presenziare all’accertamento). Rientrano nel target anche gli studenti che frequentano corsi universitari e che hanno il medico di base in Emilia-Romagna.
Da Piacenza a Rimini, sono 1.366 le farmacie convenzionate, pubbliche e private, operative in Emilia-Romagna. Quelle che, in base all’accordo, hanno deciso di aderire alla richiesta della Regione di effettuare i test dovranno attuare idonee misure idonee di sicurezza (uso obbligatorio e corretto della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso, controllo della temperatura corporea, distanziamento). L’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato a breve sul sito della Regione; chi vorrà sottoporsi al test dovrà prendere appuntamento con il farmacista. Per il Servizio sanitario, il test in farmacia avrà un costo unitario pari a 16.76 euro (IVA inclusa).
Il farmacista registrerà sulla piattaforma SOLE i dati della persona che si sottopone al test, il cui esito sarà disponibile già dopo 15 minuti dall’esecuzione. In caso di positività, il cittadino eseguirà presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica aziendali il tampone nasofaringeo che potrà rilevare l’eventuale presenza del virus SARS-CoV-2.
Altri 2 milioni di tamponi rapidi in arrivo per l’Emilia-Romagna
La gara per mettere a disposizione, in Emilia-Romagna, 2 milioni di tamponi antigenici rapidi per la diagnosi di positività a SARS-CoV-2 è stata bandita dalla Regione Veneto, che stavolta ha agito da committente unico a nome anche di altre Regioni, così come era avvenuto con altre gare in passato gestite da altre Regioni, con l’aggiudicazione che avverrà nel corso della settimana. Dopo i passaggi formali necessari, l’Emilia-Romagna disporrà dei test rapidi già entro la fine del mese. Questi test, che prevedono l’esecuzione di un tampone, possono essere eseguiti in diversi contesti e forniscono il risultato nel giro di massimo 20 minuti.
La Regione Emilia-Romagna intende utilizzarli per le attività di screening destinate al mondo della scuola; questo per indirizzare nel migliore dei modi, in tempi brevi, gli interventi in quell’ambito. Ma non solo la scuola: verranno interessati anche gli ambiti lavorativi pubblici e privati a maggior rischio e, più in generale, quelle situazioni che risulteranno critiche dall’osservazione degli andamenti epidemiologici. Sull’utilizzo dei test si è avviata un’interlocuzione positiva con la principale rappresentanza dei medici di medicina generale: ciò consentirà di rendere più fruibile questa tipologia di test da parte dei cittadini.
Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021
E proprio in un’ottica di prevenzione, e per favorire la diagnosi differenziale, quest’anno la Regione ha deciso di anticipare a lunedì 12 ottobre l’avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale; non solo, perché viene spostato in avanti, oltre il 31 dicembre, il termine per vaccinarsi. Acquistate anche più dosi di vaccino: 1.200.000, circa il 30% in più rispetto alle vaccinazioni somministrate nella passata stagione; inoltre, nei contratti di fornitura viene prevista l’opzione di acquisto da parte della Regione di ulteriori 230.000 dosi, circa il 20% in più. Proprio in questi giorni le Aziende sanitarie stanno ricevendo i vaccini da distribuire ai medici di medicina generale.
Nel frattempo, ha già preso il via la campagna di comunicazione del servizio sanitario regionale (organizzata tra social, spot radio, video, locandine), all’insegna dello slogan “È tempo di influenza, è ora del vaccino. Vaccinati, proteggi subito te stesso e gli altri”.
Il vaccino, infatti, è utile nel ridurre le complicanze gravi e gli accessi ospedalieri soprattutto per le persone con patologie croniche e può semplificare la diagnosi differenziale, nonché migliorare la gestione nei casi sospetti di Covid-19. Nella passata stagione si stima che ci siano stati circa 580.000 casi di influenza in Emilia-Romagna.
Hanno diritto alla vaccinazione gratuita persone di età uguale o superiore a 60 anni con o senza patologie; donne in gravidanza o nel post partum; adulti e bambini (a partire dai 6 mesi di età) con patologie croniche; medici e personale sanitario e sociosanitari; addetti ai servizi pubblici essenziali (per esempio, forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari che operano nel settore sanitario); donatori di sangue; personale degli allevamenti e dei macelli. Tutte queste persone possono richiede la vaccinazione al proprio medico di medicina generale o ai servizi vaccinali regionali (Pediatria di Comunità e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica), essendo appunto competenza del sistema sanitario pubblico, quindi di quello regionale, garantire la copertura vaccinale alle categorie a rischio.
Cessione al libero mercato delle farmacie territoriali
Per trovare una soluzione alla carenza di vaccino che si è creata a livello nazionale, anche in Emilia-Romagna, dopo la decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni, vengono cedute al libero mercato, a disposizione delle farmacie territoriali per le persone non appartenenti alle categorie a rischio, 36.000 dosi (pari al 3% dell’acquistato). Le farmacie del territorio riceveranno i vaccini dopo le consegne al Servizio sanitario regionale.
Le persone sane possono infatti comprare in farmacia il vaccino e farselo somministrare dal medico di fiducia (costi variabili a proprio carico); oppure richiedere la vaccinazione antinfluenzale ai servizi vaccinali regionali (costo 22 euro) che la somministreranno però solo dopo aver garantito le vaccinazioni alle categorie che ne hanno diritto. /CV