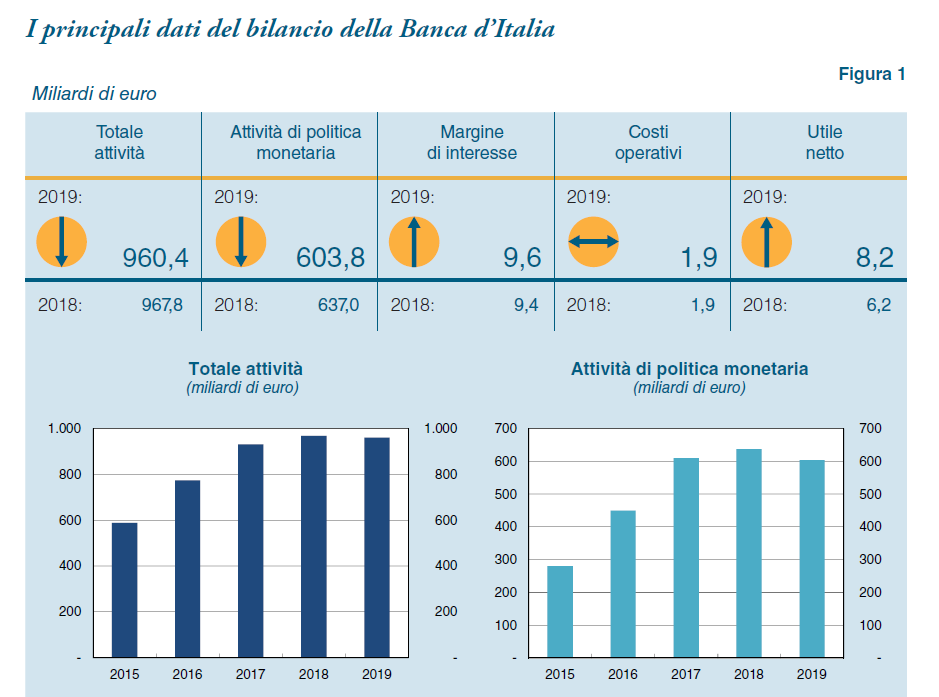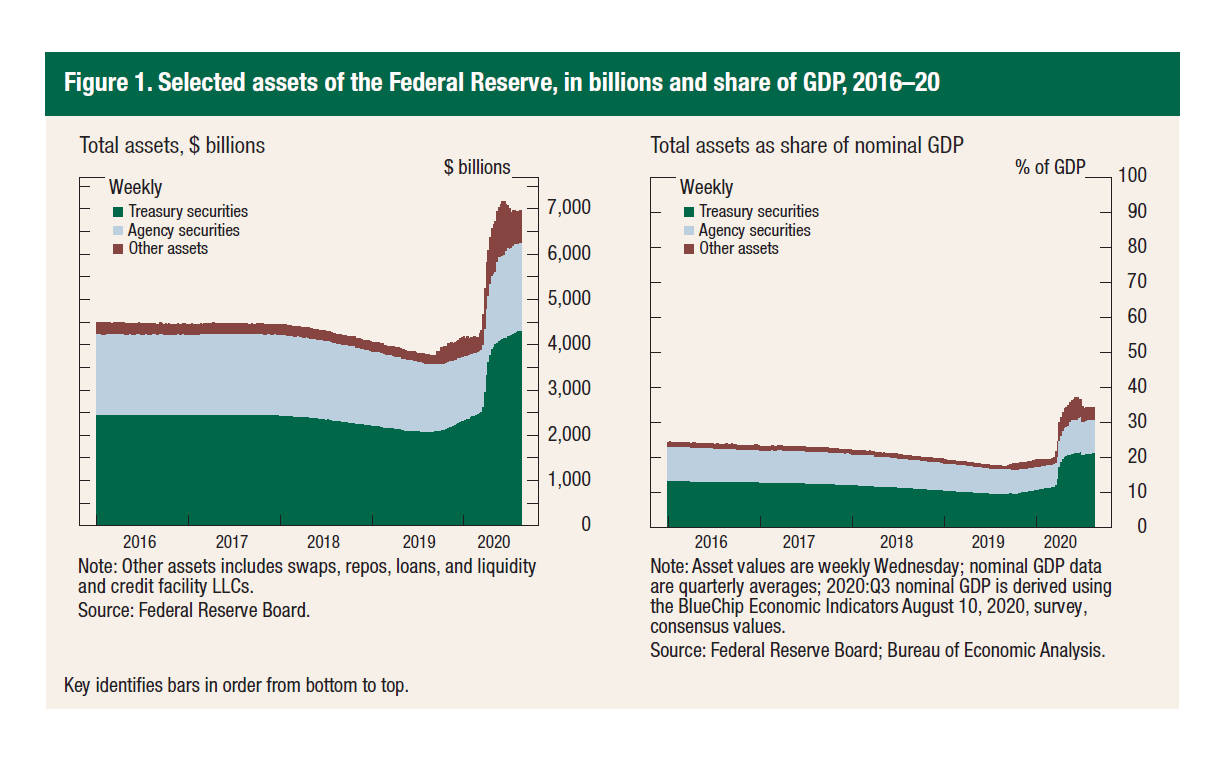UN ILLUMINISTA IN SICILIA
Attualità di Leonardo Sciascia a 100 anni dalla nascita
Non so se in questo 2021, in occasione del centenario della nascita (8 gennaio 1921), Leonardo Sciascia, le sue opere e il suo pensiero libero, verranno celebrati come meriterebbero. Del resto, se Sciascia non è diventato un evergreen, un classico come Italo Calvino, la ‘colpa’ è in buona parte dello stesso Sciascia: protagonista della scena letteraria e politica dell’Italia degli anni Settanta e Ottanta, ma sempre all’opposizione, inorganico a qualsiasi parte o partito. Un personaggio che non si accomodava a nulla, seguendo solo due stelle interiori: l’acutezza del suo pensiero e della sua lingua, e insieme, il suo grande e sconsolato amore per la sua terra. Per queste ragioni Ferraraitalia ospita con piacere – confidando sia solo il primo di altri contributi – l’intervento di Sergio Reyes, einaudiano e siciliano come Leonardo Sciascia.
(Francesco Monini)
“La Rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa”. Questo aforisma di Stanislav Jerzy Lec descrive in modo sintetico una delle differenze che distinguono la nostra cultura da quella francese.
La ghigliottina, a parte la sua spietatezza, propone una irreversibile cesura fra il ‘prima’ e il ‘dopo’: è infatti problematico rimettere al suo posto la testa del condannato dopo che la lama del boia l’ha staccata dal resto del corpo. Nel nostro cattolicissimo paese, fra gli altri, esiste un sacramento che viene elargito con grande generosità: la confessione. Il successivo pentimento e il perdono conseguente tornano a rendere immacolato il peccatore.
Come dice la Lucia manzoniana “Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia!”.
Questo percorso un po’ tortuoso ha permesso a tanti politici, sia della Prima che della Seconda Repubblica, ma anche a tanti mafiosi o delinquenti comuni di ritornare vergini nelle braccia amorevoli della Chiesa cattolica. Forse anche per questo, e non solo per la loro inattendibilità, Leonardo Sciascia ha sempre guardato con diffidenza e forte pregiudizio al fenomeno dei pentiti.
Lo scrittore siciliano ha sempre avuto un rapporto molto intenso con la letteratura francese e in particolare con Parigi e non ha mai fatto mistero della sua discendenza culturale dall’Illuminismo.
Io non sono né un critico letterario né un esperto di politica o di sociologia, ma da privato cittadino sento il bisogno di manifestare una mia inquietudine.
Oggi, basta ascoltare un telegiornale, vedere un qualunque talk-show o aprire le pagine di un giornale e perfino sentire parlare le persone per strada o al bar per rendersi conto che viviamo in un mondo di verità preconfezionate e date per scontate e come queste vengano scandite quasi sempre sotto forma di slogan.
In particolare il linguaggio della politica, e soprattutto dei politici di professione, utilizza un vocabolario di poche centinaia di parole e queste, combinandosi fra loro in poche unità, vanno a costituire un puzzle che potrebbe avere come titolo “il non pensiero”.
Una voce come quella di Sciascia sarebbe oggi preziosa non solamente per la sua dirittura morale, ma anche per il suo approccio laico alla ricerca della verità, in quanto non viziato da pregiudizi di qualunque natura. Ha ragione Vittorio Alberti quando, nel suo recente libro Non è un paese per laici, afferma che Sciascia è sempre stato all’opposizione.
Lo è stato nel senso che si è sempre posto di fronte a qualunque enunciato indagando sul suo contrario e cercando una verità terza. Questo è stato un suo metodo di lavoro e, prima ancora, un suo modo di pensare. Lo si riscontra nelle sue opere di narrativa e, ancor più, in quelle di saggistica.
In questa prospettiva il suo libro più rappresentativo è forse L’affaire Moro. La sua indagine, svolta con la puntigliosità dello storico che esamina le fonti, si arricchisce di una pietas e di una passione che sono proprie del letterato e il suo approccio, oltre che laico, è prima di tutto ricco di umanità.
A margine del suo libro Sciascia diceva che la peggiore condanna che Moro avrebbe potuto avere dopo la sua morte sarebbe stata quella del silenzio. Pensiero questo già espresso qualche anno prima da Pier Paolo Pasolini, che vedeva nella ‘indifferenza’ uno dei mali peggiori della nostra società.
A questo proposito Sciascia sottolineava che questo allarme egli lo aveva già dato, “più sommessamente”, mentre Pasolini era in vita ed ora sentiva il bisogno di esprimerlo ad alta voce.
Dal punto di vista del lettore è importante quanto uno scrittore riesce a dire anche dopo la sua morte e quali interrogativi riesce a sollecitare.
Forse non è un caso che nel 1964 Jean Paul Sartre non abbia accettato il premio Nobel motivando il rifiuto col fatto che solo a posteriori, dopo la morte, fosse possibile esprimere un giudizio sull’effettivo valore di un letterato.
Le indagini svolte da Sciascia nei suoi romanzi polizieschi, sono sempre svolte all’insegna del dubbio e, non raramente, al contrario di quanto di solito avviene nei gialli, il dubbio rimane non risolto fino alla fine del racconto.
Rivelatore a questo proposito quanto Sciascia scrive di se stesso a proposito del Consiglio d’Egitto: “volevo, insomma, assumere quel fatto del senno di poi; conferirgli – con sufficiente ambiguità e leggerezza – una forza allusiva, ma un significato sull’attualità, sul presente: sul nostro presente. È un modo per non pacificare il lettore, per lasciarlo con una sorta di inquietudine.
Esemplare in questo senso il finale di Todo Modo. Già l’ambientazione della storia è emblematica, tipica del “detto e del non detto”. La vicenda si svolge all’interno dell’eremo di Zafer, ma sembra di poter riconoscere in esso l’Hotel Emmaus, il mostro edilizio costruito dalla Chiesa e che, dopo avere deturpato irrimediabilmente il lato nord dell’Etna, è visibile da decine di chilometri.
Durante gli Esercizi spirituali che si svolgono al suo interno accadono una serie di omicidi e per gli investigatori la matassa della vicenda pare insolubile; in chiusura non viene rivelato chi ha commesso i vari omicidi e l’eremo-albergo viene sgomberato. Lo stesso narratore fra l’altro, paradossalmente, si “dichiara colpevole” del delitto.
La verità è sotto gli occhi di tutti, ma proprio per questo nessuno la vede. Un’attenta lettura delle ultime pagine permette al lettore di avanzare ipotesi sulla soluzione dell’enigma.
La cultura popolare è una delle strade maestre percorse da Sciascia nella costruzione dei suoi romanzi e soprattutto dei suoi saggi. Ad essa lo scrittore guarda non solo con l’interesse dello studioso del folklore e del demologo, ma anche con umorismo e ironia. Una ironia sempre sotto traccia, mai esposta, affinché il sorriso non sconfini mai in aperta e scomposta risata.
Nel suo breve elzeviro L’ordine delle somiglianze scrive: “… C’è in proposito, in ogni paese siciliano, una ricca tradizione: e quasi sempre riferisce del Cristo che, padre della ragazza che fa la Madonna o la Maddalena, vede dall’alto della croce l’apostolo Giovanni stringersi un po’ troppo a confortare la dolente; e dapprima ammonisce, poi si stacca dalla croce e scende bestemmiando alle cosiddette vie di fatto.”

In questo sguardo semiserio Sciascia si serve anche della penna di altri.
In Feste religiose in Sicilia scrive “Tra il Cinquecento e il Settecento … le popolazioni andavano per le spicce nei riguardi dei patroni. Scrive il Pitrèé: “codesti patroni non sono stati sempre gli stessi. Una occasione qualunque, un infortunio, una pubblica calamità, bastarono per soppiantare con un nuovo il vecchio patrono; e devoti, con armi e bagagli, passarono sotto la protezione di esso. Così vediamo come in un caleidoscopio Santa Rosalia sostituire Santa Cristina, e alla sua volta essere sostituita in Vittoria da San Giovanni Battista… messo da parte in Gioiosa per San Nicolò di Bari e in Butera per San Rocco, che in Pietraperzia viene dimenticato per la Madonna della Cava. San Nicolò vince in Nicosia, però perde in Noto… Santa Caterina, nel Comune omonimo in provincia di Caltanissetta, scalza San Giulio, ma cede alla Madonna delle Grazie …”. A me par di vedere Leonardo Sciascia che, attraverso le pagine di Giuseppe Pitré, ascolta divertito, ma anche molto interessato, la radiocronaca dell’arrivo di una tappa del giro d’Italia.
E per dare maggior credito ad una affermazione a lui cara cita un altro scrittore “allora di una città correvo a vedere i musei; ora credo avesse ragione Gide , che bisogna cominciare dai mercati, dai giardini pubblici, dai cimiteri e dai palazzi di giustizia”.
La sua costante ricerca della verità si percepisce anche dallo stile della sua scrittura. In essa ogni aggettivo, avverbio o parola appaiono come un distillato di pensiero. Praticamente tutta l’opera di Leonardo Sciascia è stata scritta prima della pubblicazione delle Lezioni americane di Italo Calvino, ma è come se ne avesse subito l’influenza, in particolare di quella intitolata Esattezza.
La sua sobrietà, la sua riservatezza e discrezione fanno sì che egli appaia come un uomo vagamente “misterioso”, come misteriosa appare la sua sconfinata conoscenza delle letterature e il modo in cui al loro interno egli si muove con naturalezza, con una disinvoltura mai ostentata.
Sebbene tutto il suo cammino sia improntato alla verifica di ipotesi diverse, secondo un solido principio di laicità, quasi sempre, quando egli ha acquisito una verità, l’ha subito messa in discussione considerandola come provvisoria, passibile di ulteriori approfondimenti.
Questa che a volte può apparire come ambiguità, a me sembra la più autentica caratteristica di un figlio dell’Illuminismo, di uno scienziato del pensiero.
Non è un caso che sulla bara di Sciascia, ateo ma religiosamente credente nei valori dell’etica, sia stato posto un crocifisso, anche perché egli aveva un profondo rispetto verso questo simbolo.
In copertina: foto scattata a Leonardo Sciascia nell’estate del 1979 al gruppo parlamentare radicale alla Camera dei deputati (Wikimedia Commons)