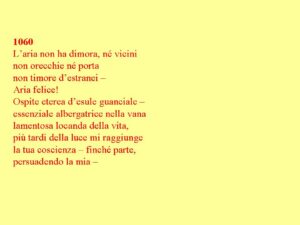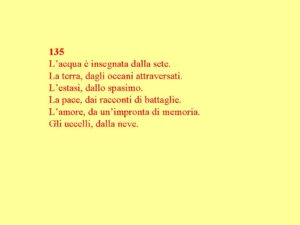Massimo Rizzante
Sembrerebbe che i narratori moderni non capiscano più cosa significhi raccontare l’altro mondo, quasi che fossero permanentemente ospedalizzati in questo mondo e nella cosiddetta ‘realtà’, di cui il loro linguaggio deve essere al servizio. Perciò quasi tutti i romanzi in circolazione debbono mettere avanti un progetto di dire qualcosa di drammatico su questo mondo, sulla ‘realtà’, per poter essere presi seriamente”. Quando ho cominciato a leggere il tuo ultimo libro, Fata morgana (2005), sorta di resoconto etnografico su una popolazione mai esistita, mi è subito venuto in mente Gulliver, e tutta una tradizione narrativa semiseria di viaggi fantastici e luoghi introvabili che probabilmente risale agli inverosimili racconti di Luciano di Samosata. Poi ho scovato nei miei appunti la citazione sugli scrittori “ospedalizzati” nella realtà. È stralciata dalla tua Prefazione a La miseria in bocca di Flann O’Brien, libro uscito nel 1987. Anche la vena satirica di O’Brien è profondamente fantastica: O’Brien non si fa nessuno scrupolo, alla stregua di Swift, a trasformare l’ospedale della realtà in un asilo per pazzi. Lilliput, il mondo sottomarino delle antiche fiabe gaeliche, o la tua valle dei Gamuna sono luoghi inverosimili, eppure ci raccontano qualcosa di ‘vero’. È da qui che dobbiamo partire?
Gianni Celati
La citazione dall’introduzione a Flann O’Brien, dove dico che i moderni sono come ospedalizzati nella cosiddetta “realtà”, è un po’ violenta come apertura di discorso. Partiamo da cose più elementari. Negli ultimi tempi mi è capitato di vedere alcuni film che sono considerati di fantasia, come Il signore degli anelli e Harry Potter. In modo inconfondibilmente anglosassone, la fantasia qui è data come un regno del torbido, del mostruoso, anche dello sporco e del polveroso. Il pragmatico mondo anglosassone vede la fantasia come una zona torbida della psiche umana, da dominare con la razionalità. Questo compito ora è affidato all’onnipotenza della tecnologia, con i suoi effetti elettronici che possono dominare la psiche di tutti. La separazione tra fantasia e realtà è ricondotta a quella tra mondo soggettivo e mondo oggettivo; e questa separazione sottolinea che le fantasie “non sono vere” perché esulano dalle “verità scientifiche”. Bisogna ripartire di qui, mettendo in dubbio che esista questa separazione netta tra il mondo immaginario o fantasticato e quello che viene ufficialmente dato come mondo reale quotidiano.
Massimo Rizzante
La conoscenza fantastica ieri come oggi non è mai stata presa sul serio dagli uomini, malati e “ospedalizzati” nella conoscenza cosiddetta razionale. Che cosa si deve fare, per liberarsi da un’idea di fantasia intesa come “irrealtà”, a cui credo faccia da pendant un’idea di realtà concepita secondo i canoni intimidatori della vulgata scientifica?
Gianni Celati
Il fatto è che noi ci serviamo della fantasia tutti i momenti per interpretare le cose, cercando di capire quello che è fuori dalla nostra portata; e tutto il nostro sistema emotivo dipende da come immaginiamo ciò che non è sotto i nostri occhi. Quando abbiamo paura, quando siamo a disagio, quando siamo gelosi, quando facciamo progetti, entra in gioco l’atto di fantasticare. Quando siamo innamorati non facciamo che ripassarci il film delle fantasie sull’essere amato, e anche quando riflettiamo cerchiamo aiuto nell’immaginazione o nella fantasticazione. Il fantasticare è così assiduo che lo diamo per scontato. Però se si inceppa abbiamo un campanello d’allarme, che è la noia: la noia è una specie di una nebbia mentale che blocca gli slanci immaginativi, e rende fastidioso anche il flusso di stimoli che viene dai sensi e dal mondo esterno.
Massimo Rizzante
Infatti l’immaginazione – che qui andrebbe tradotta con la parola “fantasia” – secondo Aristotele ha la funzione di regolare il flusso che viene dai sensi e che va verso l’intellezione
Gianni Celati
Sì. In un testo tra i massimi della storia della filosofia, il De anima, Aristotele cerca di spiegarsi come succede che portiamo in mente le immagini, ossia perché abbiamo in noi questa produzione immaginativa. Aristotele chiama in due modi le immagini che sorgono della mente: phantasma e phantasia, entrambi dal verbo phaino, “mostrare”. Sono figurazioni che “si mostrano” in noi come un richiamo a percezioni avute o possibili. Queste immagini nella mente, dice Aristotele, sono una combinazione di ciò che abbiamo percepito attraverso i sensi e ciò che opiniamo con l’intelletto. E nel suo trattato sulla memoria dice che sono oggetti di memoria quelli che cadono sotto l’immaginazione; dunque immaginazione e memoria non sono separabili: ricordare vuol dire in qualche modo immaginare la cosa ricordata, ripensarla fantasticamente. È anche l‘idea di Giambattista Vico, il quale diceva che “la memoria è l’istesso della fantasia”.
Massimo Rizzante
Volevo, se mi permetti, riportare un passo di Aristotele, tratto dall’opera da te già citata, Della memoria e della reminiscenza – fra l’altro riportato da Maria Corti nel suo studio sull’inventio dantesca. Eccolo: “La memoria, anche degli intelleggibili, non è senza immagine… È chiaro dunque a quale parte dell’anima appartiene la memoria, cioè a quella cui appartiene anche l’immaginazione: sono oggetti di memoria per sé quelli che cadono sotto l’immaginazione, per accidente, poi, quelli che non sono separati dall’immaginazione”.
Gianni Celati
I greci non avevano una parola per dire “conoscenza”, ma ne avevano una per dire “intellezione”: noèsis – il processo del pensiero nella comprensione di qualcosa. La noesiè per Aristotele un modo di percezione, dunque bisogna pensare l’intelletto come una specie di lente. Si possono usare altre immagini per dire questo processo, come quella della lampadina accesa nella mente, usata nei fumetti. Emanuele Coccia usa l’idea della trasparenza delle immagini, come la soglia attraverso cui percepiamo qualcosa nel processo di intellezione (La trasparenza delle immagini, Bruno Mondatori Editore, 2005). Insomma: le immagini sono uno stato ricettivo a cui si apriamo, e nei termini di Aristotele uno stato ricettivo è una passione (come l’opposto dell’azione). Dunque tutto il sentire dei sensi o percezione corrisponde a modi di passione. Non è nella forma bruta dello scambio di informazioni che capiamo qualcosa del mondo esterno, ma nel processo con cui ci proiettiamo verso ciò che si configura come un’esperienza e una passione.
Massimo Rizzante
Potresti portare un esempio di questo uso della fantasia intimamente legato alla memoria?
Gianni Celati
L’esempio più importante è Giambattista Vico. La rivoluzione portata da Vico sta nel concepire l’immaginazione e la fantasia non come produzioni soggettive, ma come una specie di filo che collega gli uomini. In altre parole: noi possiamo capire fantasticazioni e mitologie molto lontane da noi, perché anche la nostra forma mentis è disposta a produrre fantasticazioni e mitologie simili, cominciando da quando eravamo bambini. Solo così si possono rimemorare i processi che hanno dato luogo a costruzioni mitologiche e antropologiche, secondo stadi della vita collettiva; e in questo senso la fantasia non è qualcosa di soggettivo, ma una vasta memoria collettiva che ci collega al passato e anche a ciò che è lontano da noi, fino ai limiti dell’umano. La scienza che si occupa di queste cose, Vico la chiama “sapienza poetica”, come scienza delle forme fantastiche con cui gli uomini si intendono in quanto appartenenti alla specie umana. Questo è il succo del pensiero di Vico. Ed è il presupposto di ogni antropologia, che in questo senso è una memoria dove i cosiddetti primitivi non stanno più in una opposizione categorica rispetto a noi.
Massimo Rizzante
Il tuo discorso è chiaro. Fin quando ha avuto un forte legame con la memoria, la fantasia ha partecipato al processo cognitivo dell’uomo (penso a Montaigne, ad esempio).
Gianni Celati
La memoria non può mai essere pensata come neutra informazione che si accumula alla maniera del denaro. L’esempio decisivo è quello del nazismo, su cui abbiamo un’enorme informazione, che però lo presenta quasi sempre come un fenomeno unico, mostruoso e incomprensibile. Invece il nazismo è strettamente intricato con l’umano, con tendenze che pervadono tutta la vita comune, come ci ha insegnato Primo Levi. Con un po’ d’immaginazione si può intravedere come molti di questi uomini che stanno sempre a galla, che accettano i peggiori modi di trivializzare la vita per attenersi alle norme vigenti, se governasse il nazismo sarebbero votati al quella stessa burocratica ferocia. Uno dei principali organizzatori dei campi di sterminio, Eichmann, era un tecnocrate che credeva ai calcoli ben fatti, all’obbedienza ai superiori, e credeva ciecamente nella propria buona fede. Come ha detto Hannan Arendt, era un uomo senza immaginazione, senza fantasia.
Massimo Rizzante
Questo mi sembra il punto essenziale: possiamo ridare valore alla nozione di fantasia se ridiamo alla fantasia la sua funzione perduta di regolatrice della conoscenza umana, di scrigno di forme ricevute attraverso i cinque sensi, di mediatrice tra corporeo e incorporeo.
Gianni Celati
Ma nel modo in cui viene usata oggi, la parola “conoscenza” dà l’idea d’un sapere composto di informazioni che si capitalizzano per far carriera in qualche settore. Questa è la concezione di tutte le forme di expertise o professionalità attuali. E sempre di più trovi il romanziere che va in un archivio a raccogliere informazioni per scrivere il suo romanzo, dove la cosa studiata diventa un mistero stupidissimo per tenere il lettore sulla corda. A parte ciò, quel romanziere non ha mai tempo di studiare niente, perché deve scrivere la sue 500 parole al giorno e pubblicare un libro all’anno. Fino a Gadda, Calvino, Landolfi e Manganelli, scrivere e studiare erano la stessa cosa: si scrive perché si studia; perché studiando la testa si riempie di immagini che smuovono il pensiero; e perché il pensiero deve essere fatto lavorare altrimenti si fossilizza nella chiacchiera.
Massimo Rizzante
Una malattia più recente è quella che Milan Kundera ha definito nel suo ultimo saggio, Il sipario, come “morale dell’archivio”: un assurdo proliferare di informazioni e saperi, un’accumulazione senza freni di libri nel tentativo di abbracciare un Tutto, di cui – paradosso nel paradosso – da almeno un secolo, si predica l’inesistenza. Il risultato, al di là di un facile idillio con un falso concetto di eguaglianza, è che più concepiamo la memoria come archivio, più la nostra capacità figurativa, rammemorativa e reminiscente, viene meno.
Gianni Celati
Bene. Cambiamo argomento.
Massimo Rizzante
C’è un’affermazione piuttosto forte che tu hai fatto: hai detto di non credere nell’estetica così come è stata intesa dal Settecento in poi. È un caso se il tuo rifiuto dell’estetica moderna coincida con la critica alla pretesa moderna dei romanzi di regolare le avventure umane secondo le convenzioni della coscienza? Critica da te sviluppata in Finzioni occidentali.
Gianni Celati
Sì, Finzioni occidentali tratta di questo: le convenzioni della coscienza come una specie d giudice supremo di tutti i fatti della vita. Il romanzo moderno (in inglese novel) è cominciato con questa pretesa di spazzar via tutti gli errori – gli errori degli ignoranti, dei pazzi, delle donne, dei bambini e dei selvaggi – per il trionfo della coscienza maschile, adulta e civilizzata. Nel 1968 ho avuto una borsa di studio che mi ha permesso di passato due anni a Londra, chiuso nella biblioteca del British Museum. Ne è venuto fuori quel saggio sulla nascita del romanzo che hai citato. Questo si ispirava a Don Chisciotte, come mio eroe e guida nei pensieri. E ciò che mi appassionava di questo eroe era la sua resistenza a tutte le censure, il suo passare imperturbato attraverso le critiche degli intenditori che vorrebbero ricondurlo sulla retta via della coscienza “realistica”. Per questo il Don Chisciotte è così illuminante, perché qui si affaccia per la prima volta la questione della “realtà”, posta in un contrasto con l’immaginazione e le tendenze fantasticanti. E si affaccia anche l’idea che il “nuovo” sia qualcosa che spazza via le inutili anticaglie (i romanzi cavallereschi che hanno invaso il cervello di Don Chisciotte). Ma, posto questo schema, dove Don Chisciotte ha sempre torto in quanto invasato da fantasie passate di moda, poi succede che sono proprio le sue tendenze fantasticanti a arricchire di senso il mondo. Sono le sue fantasie e le sue riflessioni a farci intravedere l’aperto mondo sotto l’aperto cielo come la nostra unica vera casa. Tutto il Don Chisciotte rimane un esempio meraviglioso di questa potenza del pensiero figurale che ci guida verso un’apertura al mondo esterno.
Massimo Rizzante
A partire dagli anni Ottanta, con il nuovo esordio di Narratori delle pianure (1985), si accentua nelle tue opere e nelle tue riflessioni l’opposizione tra il “delirio critico razionalistico”, che vuole sempre spiegare e incasellare la “realtà”, e il senso comune, un sapere pratico, incapace di discriminare, che ci riconduce alla prosa del mondo, in basso, nella terra dei “luoghi comuni”: termine quest’ultimo che tu usi spesso, così come quelli di “banalità”, “ovvietà”, “sentito dire” in cui tutti noi siamo immersi. Che cosa puoi dirci a proposito di quell’epoca?
Gianni Celati
Per alcuni anni sono andato in giro per la valle del Po, prima insieme ad alcuni fotografi e poi da solo, a prendere appunti. Di qui è venuto fuori quel diario di viaggio intitolato Verso la foce. Una delle attività che facevo era quella di piantarmi per interi pomeriggi nei bar di campagna e ascoltare cosa dicevano gli avventori. A ogni momento sentivo accenni a storie possibili, e di lì mi sembrava di capire come nascono i racconti. L’altra cosa che mi veniva in mente è l’idea che noi viviamo dentro al “sentito dire” collettivo, ossia che tutto il mondo per noi sia come foderato dal “sentito dire”. Continuamente no parliamo di cose che ci sono “note”, perché sono cose che immaginiamo in un modo o nell’altro attraverso un “sentito dire” (che può essere anche quello dei giornali). Il “sentito dire” è come uno spillo: qualcuno mi punge con quello spillo e mi spinge a farmi delle domande per capire di cosa si sta parlando. Questo è il lavoro di chi scrive racconti: sente una cosa, vuole capire ciò che si dice, e parte a farsi domande, ossia a fantasticare. Quello che lega gli uomini sono le domande che gli uomini si fanno: non le affermazioni, ma il pensiero interrogativo, dove ogni interrogazione promuove altre immagini e fantasie.
Massimo Rizzante
Mi ricordo che quando lessi Verso la foce (1989) mi colpì molto la “Notizia” che tu, come autore, avevi posto sulla soglia del libro. Mi è sempre rimasta impressa, soprattutto la parte finale: “Ogni osservazione ha bisogno di liberarsi dai codici familiari che porta con sé. Ha bisogno di andare alla deriva in mezzo a tutto ciò che non capisce, per poter arrivare ad una foce dove dovrà sentirsi smarrita. Come una tendenza naturale che ci assorbe, ogni osservazione intensa del mondo esterno forse ci porta più vicino alla nostra morte, ossia ci porta ad essere meno separati da noi stessi”. Questa tendenza naturale è una variazione del senso comune? E ancora: scrivere sotto questo imperativo naturale che ci assorbe, significa scavalcare il recinto del territorio estetico per porci in un territorio di ascolto e visitazione “fantastica” degli altri?
Gianni Celati
L’idea di ascolto e visitazione fantastica degli altri è bel concetto. In realtà poi ognuno di noi va sempre in cerca d’una sua popolazione, d’una popolazione d’individui a cui associarsi anche solo fantasticamente. Allo stesso modo i cani vanno in cerca d’altri cani con cui annusarsi, e i bambini cercano altri bambini con cui giocare, e gli adolescenti cercano altri adolescenti per parlare di cose da adolescenti. Gli antichi dicevano che il simile cerca il simile. La letteratura stessa a me sembra non un prodotto di autori separati, ma di popolazioni, di bande di sognatori, tra cui avviene quell’ascolto e quella visitazione fantastica che hai detto. Per questo la letteratura cavalleresca è la tradizione narrativa italiana che più mi attira e che bisognerebbe rimettersi a studiare. Perché non parla di individui separati nella loro cosiddetta psicologia, non parla dell’individuo moderno chiuso nel proprio guscio, ma sempre della vita come un fenomeno vegetativo generale, dove tutto è collegato e tutto è animato. E parla di popolazioni di sognatori passionali e sbandati, puramente esposti alla fatalità del destino, come Don Chisciotte.
Massimo Rizzante
La tendenza naturale, per chi scrive racconti, dunque, è complementare a quella capacità fantastica che affonda le sue radici nel terreno del senso comune?
Gianni Celati
Sì. E riflettere sulla fantasia aiuta a capire quello che tu chiami senso comune: cosa ci lega agli altri nei pensieri a distanza, anche nel quadro d’una separazione generale degli individui come quella in cui viviamo. Per questo credo sia utile la ripresa del pensiero di Aristotele, di Vico, come ripresa di un’idea di intellezione collettiva. Essere al mondo vuol dire essere con gli altri dall’inizio alla fine. Anche se sono su un’isola deserta, gli altri sono sempre con me in una trama che determina i miei gesti, i miei atteggiamenti, quello che voglio e quel che non voglio.
Massimo Rizzante
Vorrei ritornare su qualcosa che forse nella mia domanda precedente non è risultato chiaro. La “tendenza naturale” ad andare verso l’altro e scoprire ciò che abbiamo tutti in comune, nei tuoi racconti procede, a partire dagli anni Ottanta, attraverso la descrizione e l’osservazione. La tua prospettiva è diversa da quella di molti scrittori moderni per i quali il bersaglio privilegiato è lo spazio interiore. Mi sembra di poter dire che tu hai condiviso questa prospettiva antipsicologica con altri autori italiani e stranieri, primo fra tutti il maestro Italo Calvino. Fin dagli anni Settanta (ma probabilmente fin dall’inizio della sua carriera letteraria) uno dei problemi più assillanti per Calvino è stato: come descrivere le cose? Come farsi assorbire dall’esterno, evitando i trabocchetti dell’io? All’ombra della nozione di fantasia (che oggi Calvino, grazie a uno dei suoi guizzi, avrebbe certamente contribuito a illuminare) ti chiedo: dove risiede secondo te la frontiera tra il tuo modo di vedere o di fantasticare rispetto a quello del tuo amico Italo?
Gianni Celati
Non ci ho mai riflettuto. Ma se c’è stato un sodalizio tra noi, credo sia nato da una simpatia comune per libri esenti dal peso della psicologia: Ariosto e la letteratura cavalleresca, i romanzi settecenteschi inglesi, e poi Swift, e infine Beckett, che Calvino onorava molto. Nel 1968-70 ogni volta che passavo da Parigi per andare a Londra dormivo a casa sua, e andavamo a spasso parlando di cose da scrivere, e lui fantasticava sempre a ruota libera. Certe volte si incazzava con me per cose strane, come il fatto che attraversavo l’Europa in macchina senza una carta stradale: lo trovava inconcepibile. Ma ogni volta lo ritrovavo contento di vedermi per chiacchierare di libri e di idee sullo scrivere. Nell’ultima di queste mie soste a Parigi, tornavo dall’America con le Avventure di Guizzardi finito, e lui mi è venuto a prendere all’aeroporto di Orly.
Massimo Rizzante
Ma con la fantasia come la mettiamo? Calvino, fino all’ultimo, fino alla stesura delle Lezioni americane, dove c’è un bellissimo passaggio su Dante, ha insistito con convinzione sulla nozione di fantasia…
Gianni Celati
Ho ma ho l’idea che certe sue cose nascano appunto da una volontà di tener fede alla nomea di scrittore fantastico. Così per la trilogia, con l’eccezione del Cavaliere inesistente. Di questo libro lui si vantava, a ragione, dicendo che era il “libro del maggiore scripturalist italiano”. La parola scripturalist non so dove l’avesse scovata, ma cadeva a proposito. Voleva dire che il suo era un lavoro di fantasia usando la scrittura come una specie di disegno a mano libera. Non credo che nessuno abbia mai studiato l’influsso dei disegnatori sul suo modo di scrivere. Calvino mi raccontava che il nostro grande disegnatore Rubino capitava nella villa dei suoi genitori a Sanremo, quando lui era piccolo, e gli faceva dei disegni per intrattenerlo – quei disegni con quelle linee art nouveau così eleganti. C’è tutto un percorso di Calvino verso questo modo di uso “fantastico” delle parole, come quello dei fumetti o delle illustrazioni per ragazzi. La sua tendenza a usare la scrittura alla maniera delle vignette, dei fumetti o delle caricature, è stato ciò che gli ha dato una grossa libertà d’azione rispetto agli altri narratori italiani. Ma è anche qualcosa che a un certo punto lui ha sentito come un limite, perché gli veniva troppo facile. A volte diceva: “Io devo pormi degli ostacoli, altrimenti sono uno scrittore domenicale”. Di lì in poi è come se si fosse dato degli ordini, per mettere vincoli alla facilità della sua vena fantasticante. Poi nel Castello dei destini incrociati e nelle Città invisibili, la sua vena disegnativa è venuta in primo piano, attraverso un confronto con le figurazioni dei tarocchi, delle miniature dei vecchi libri di viaggi o con immagini nelle mappe medievali. E ha cominciato a usare dei frames o incorniciature, che creano un effetto simile a quello postmoderno della auto-riflessività.
Massimo Rizzante
Nella Presentazione che hai scritto con Jean Talon ad Altrove di Henri Michaux (2005), c’è un passo che mi è sembrato subito significativo, e ancor più adesso, dopo quanto abbiamo detto: “Riprendiamo l’idea del pensiero come tragitto. Un bambino scrive un tema scolastico: si ferma, non sa più cosa dire. Ha scritto ciò che chiamiamo un ‘pensiero’. Ma, chiede Michaux, cosa c’è intorno alla frase che si blocca dopo aver espresso un pensiero?…Ci sono ‘abissi di nescienza’. Sono gli abissi di tutto quello che non sappiamo ancora, o non sapremo mai”. Calvino fa parte di una categoria di scrittori che ad un certo punto della loro vita, contemplando fuori della finestra, hanno ricominciato come bambini a scrivere i propri temi. Penso al suo amato Ponge. Tuttavia la sua contemplazione non contemplava l’abbandono, non contemplava il pericolo rappresentato dagli “abissi di nescienza” di cui parla Michaux, non contemplava la scrittura come “gesto”, “movimento sulla pagina” privo di giustificazioni, di significato. Che ne pensi? Questa riflessione è legata al problema della forma, problema che Michaux sembra non porsi. Calvino, invece, se lo poneva, eccome! Il suo amore per Perec non era forse legato alla sua ludica ossessione per le serie matematiche? Al suo distacco nei confronti della “realtà”? Nei tuoi racconti, Celati, tutto questo non c’è. C’è piuttosto un abbandono alla contemplazione delle cose fuori di noi.
Gianni Celati
Ora non so rispondere a questo. Posso aggiungere qualcos’altro su Calvino. Lui era uno molto più “abbandonato” di me, nel senso che era più sicuro di sé. Ricordo la sua casa di Castiglione della Pescaia, dove lo andavo a trovare d’estate. Si metteva lì in un angolo e scriveva mentre io parlavo con sua moglie, e dopo un po’ diceva: “Sentite cosa ho scritto”.
Massimo Rizzante
Credevo che Calvino fosse uno scrittore che prima di mettere la parola fine a un manoscritto si torturasse parecchio…
Gianni Celati
Tornando alla tua domanda sulla frontiera tra il suo modo di vedere e il mio, mi viene in mente questo: Calvino era “Lo Scrittore”. Anche nell’intimità delle chiacchiere e degli scherzi era come se non potesse dimenticarsi quel ruolo. Era molto modesto e onesto, perché non si travestiva mai da qualcos’altro, non aveva le pose dello scrittore all’americana che vanta la propria “esperienza di vita”. Calvino era “Lo Scrittore”, e giustamente non gli interessava “l’esperienza di vita”, gli interessava la letteratura, come un serio artigianato della penna. In questo vedo la frontiera tra me e lui. Perché io non mi sono mai sentito “scrittore”, e non credo di aver mai fatto carriera.
Massimo Rizzante
Volevo tornare ancora sulla forma. Cosa succede quando si scrive? Si tratta di tracciare con le parole delle linee in modo da creare, come tu dici a proposito di Michaux, “luoghi da esplorare”? “Bisogna lasciare che venga”, affermava ancora Michaux. È così che anche tu concepisci il tuo scrivere? Un movimento esplorativo che non si pone nessuna meta? Nessuna “opera”?
Gianni Celati
In questi termini non so rispondere. So però che scrivere è un rituale che noi impariamo a scuola, quando siamo bambini: una rituale dove si cerca di mettere in moto il pensare-immaginare, per farsi venire in mente una frase, per ricordare una parola. Tutto questo fa parte di qualcosa che è molto costruito in noi, e va inevitabilmente insieme a un certo grado di fantasticazione. Poi c’è qualcos’altro, che è la distanza da cui si guarda la figurazione delle parole che sorge dai segnetti scritti. Nei libro che hai citato, Altrove, Michaux parla di una popolazione immaginaria e descrive i loro costumi e i loro teatri: “A teatro si rivela il loro gusto del lontano. La sala è lunga, il palcoscenico è profondo. Le immagini, le forme dei personaggi vi appaiono grazie a un gioco di specchi. Gli attori recitano in un’altra sala, e vi appaiono più reali che se fossero presenti. Più concentrati, più purificati, più definitivi, sbarazzati di quell’alone che produce sempre la presenza reale, faccia a faccia…”. Questa idea di attori che recitano in un teatro dove sono visti attraverso un gioco di specchi, mi sembra una figurazione del gioco dello scrivere, che non può mai essere diretto. È sempre un gioco sulla distanza che ci sottrae al faccia a faccia con la realtà, e al tempo stesso potenzia la percezione come un gioco di specchi. Perché in questa modo non vediamo soltanto qualcosa: vediamo il vedere, guardiamo il guardare, percepiamo l’atto di percepire. Il rituale dello scrivere prevede questo effetto, come una messa a distanza delle percezioni, per sottrarle alla casualità e portarle verso la trasparenza dell’intelleggibile. Solo in questi termini riesco a scrivere, e faccio fatica a sopportare chi prende lo scrivere come un riflesso della sua esperienza personale o della cosiddetta realtà nuda e cruda, senza vedere il processo rituale a cui le parole debbono essere sottoposte (metrica, ritmo, colore tonale, distanza focale).
Gianni Celati – Dialogo sulla fantasia con Massimo Rizzante, Tratto da: Griseldaonline, n. VII, 2007-2008.