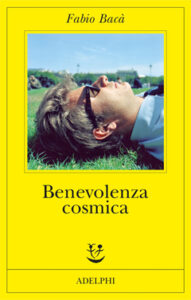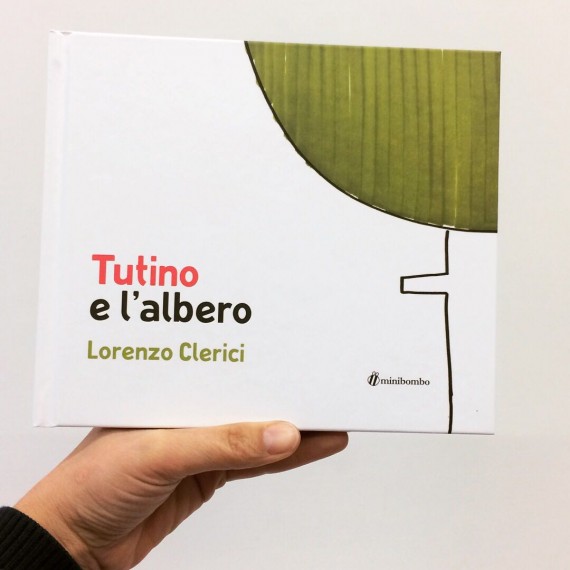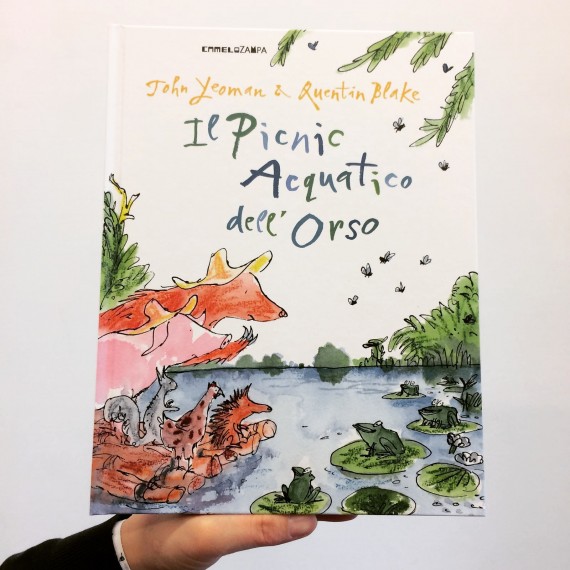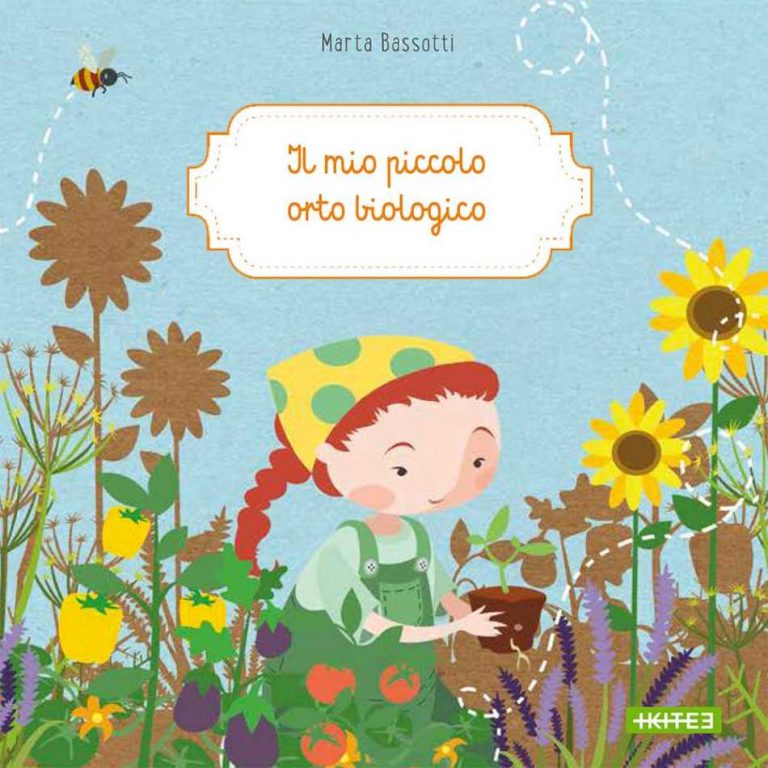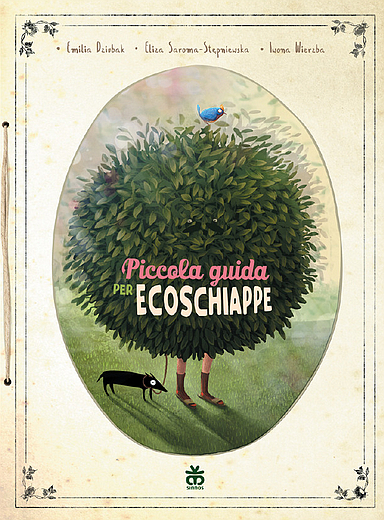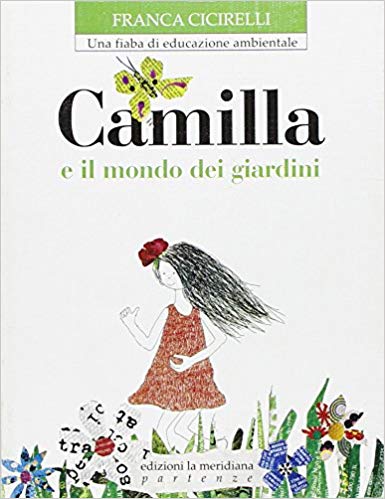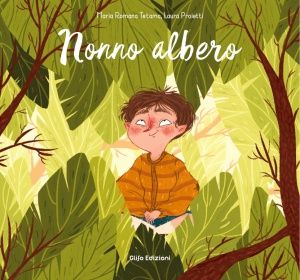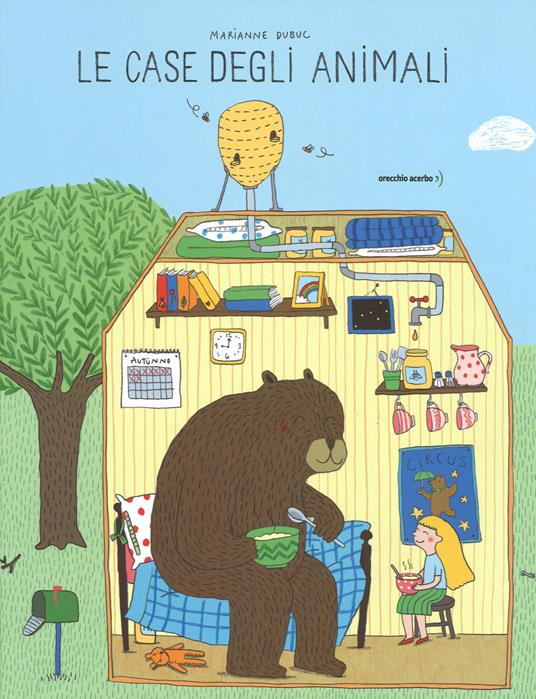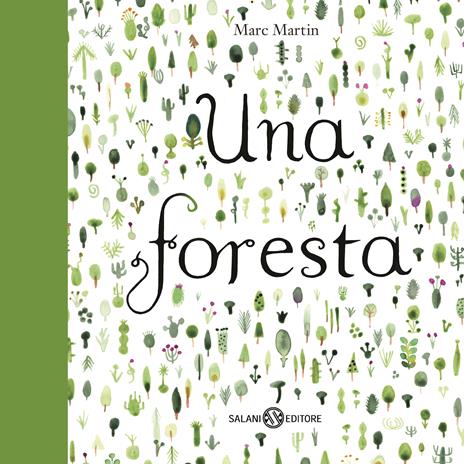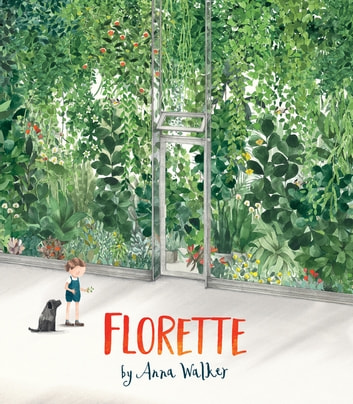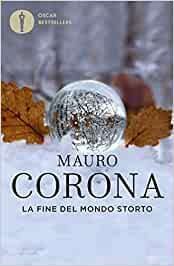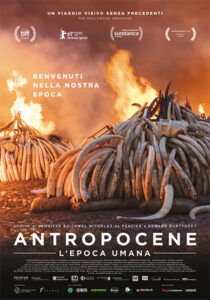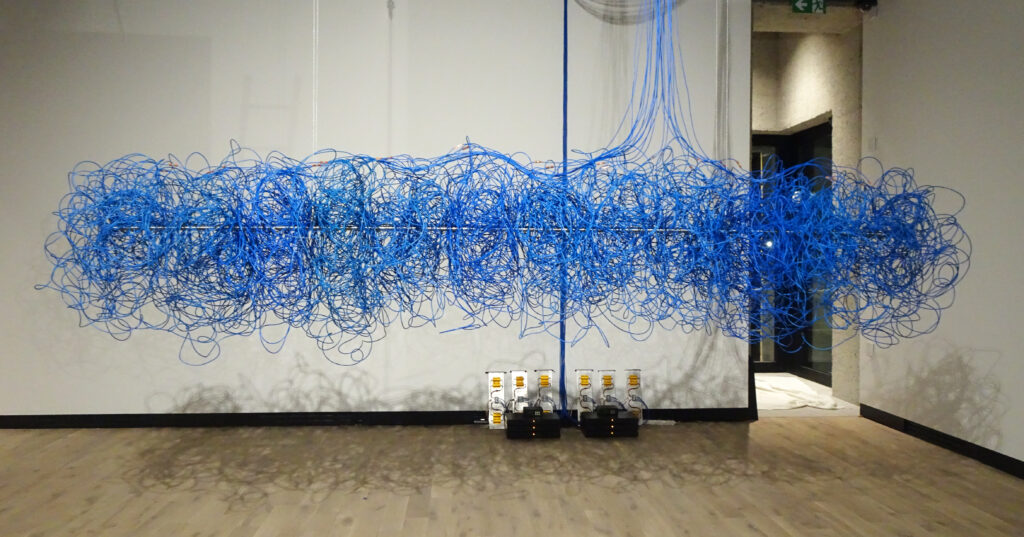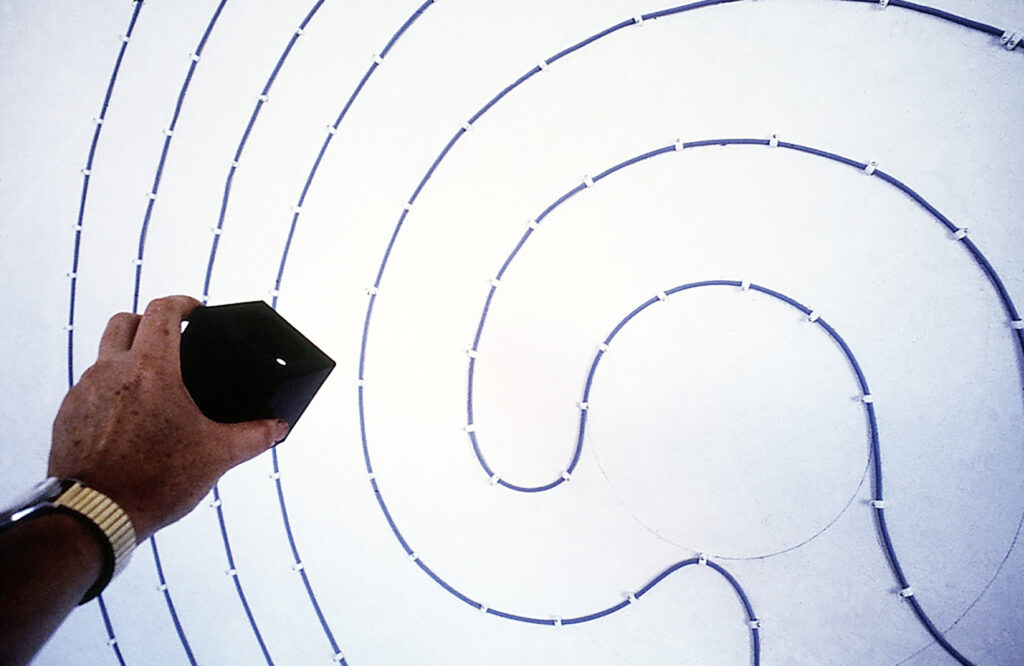Nei 77 anni che ci separano da Hiroshima e Nagasaki, il pericolo di un conflitto nucleare non è mai stato così grave e incombente come quello corso durante la guerra criminale scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Per questo il comportamento delle potenze della Nato di fronte a questo pericolo è stato, fin dall’inizio, irresponsabile. Proprio il fatto che Putin, secondo il coro unanime dei media e di tutti i governanti occidentali, è un despota feroce, dovrebbe consigliare di prendere sul serio la sua minaccia, formulata fin dal 13 marzo, di una “reazione nemmeno immaginabile”. Giacché questo despota ha già mostrato ciò che è capace di fare, è fornito di armi nucleari come ha più volte voluto ricordare ed è quindi ben possibile, se crescerà la tensione, che ne faccia uso. La sola cosa seria da fare dovrebbe essere quindi l’impegno di tutti di porre fine alla guerra e di contribuire al ristabilimento della pace.
E’ questa, del resto, la regola valida in tutte le comunità civili per far fronte alle azioni criminali in atto. Quando un bandito minaccia di sparare e poi spara su una folla se non saranno accolte le sue richieste, il dovere di quanti hanno il potere di farlo – in questo caso la comunità internazionale – è quello di trattare, trattare, trattare la cessazione della strage. Poco importa se il bandito sia considerato un criminale, o un pazzo oppure un capo politico irresponsabile che non ha visto accogliere le sue giuste ragioni e rivendicazioni. La sola cosa che importa è la cessazione dell’aggressione e della strage degli innocenti. Tanto più perché, in questo caso, la continuazione della guerra può deflagrare in una guerra nucleare. Proprio i più accaniti critici di Putin non dovrebbero dimenticare, ripeto, che ci troviamo di fronte a un autocrate fornito di oltre seimila testate nucleari, e che l’insensatezza di questa guerra, anche dal punto di vista degli interessi della Russia, non consente di escludere ulteriori, apocalittiche, insensate avventure.
Trattare è ciò che chiedono milioni di manifestanti in tutto il mondo quando domandano di “cessare il fuoco”: per porre fine alla tragedia dei massacri, delle devastazioni e della fuga di milioni di sfollati ucraini. All’inizio di aprile, come ci informa l’Agenzia Onu per i rifugiati, erano 4 milioni i rifugiati ucraini nei paesi vicini e circa 7 milioni gli sfollati interni, in gran parte donne e bambini. Gli orrori, gli stupri e le stragi di civili commessi dall’esercito russo impongono con forza, per la loro atrocità, l’impegno di tutti perché si ponga fine, quanto prima possibile, a questa tragedia. Non importa che atrocità simili sono state commesse in tante altre guerre, talune delle quali scatenate dall’Occidente. Ciò che importa è che si avverta come intollerabili le violenze contro persone inermi, che si faccia di tutto per farle cessare e che esse valgano ad aprirci gli occhi sugli orrori inevitabilmente connessi a qualunque guerra.
Sono queste le condizioni di ogni pacifismo degno di questo nome: in primo luogo stare dalla parte degli aggrediti contro i loro aggressori; in secondo luogo sostenere le loro ragioni nella trattativa diretta a far cessare quanto prima l’aggressione e le sue nefandezze.
2. La necessità di coinvolgere nella trattativa i paesi della Nato. Il ruolo che dovrebbero svolgere gli organi dell’Onu, convocati in seduta permanente
Ma in che modo si sostengono le ragioni degli aggrediti nei negoziati di pace? Chi ha il potere e, aggiungerò, il dovere di offrire questo sostegno? C’è una grande ipocrisia alla base delle politiche dei governi europei e del dibattito pubblico sulla guerra. Tutti sanno, ma tutti fanno finta di non sapere che dietro questa guerra, della quale l’Ucraina è soltanto una vittima, il vero scontro è tra la Russia di Putin e i paesi della Nato. Sono perciò gli Stati Uniti e le potenze europee che dovrebbero trattare la pace, affiancando l’Ucraina nelle trattative anziché lasciarla a trattare da sola con il suo aggressore.
Sarebbe questo il vero atto di solidarietà dell’Occidente nei confronti del popolo ucraino. Il vero aiuto alla popolazione ucraina, bombardata e massacrata dal 23 febbraio, sarebbe la partecipazione alla trattativa, a fianco dell’Ucraina, dei paesi membri della Nato, a cominciare dagli Stati Uniti, dotati di ben altra forza e di ben maggiore capacità di pressione, onde ottenere, con il minimo costo per l’aggredito, l’immediata cessazione dell’aggressione. Una simile assunzione di responsabilità delle maggiori potenze – Stati Uniti ed Unione Europea – varrebbe non solo a porre fine alla guerra, ma anche a scongiurare il pericolo di un suo allargamento incontrollato.
Per questo la sede appropriata dei negoziati, come ho già avuto occasione di sostenere, dovrebbe essere non più soltanto la sconosciuta località della Bielorussia dove si incontrano, con sempre minori capacità di accordo, le delegazioni della Russia e dell’Ucraina, ma anche l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per due ragioni. In primo luogo perché le Nazioni Unite sono l’organizzazione la cui finalità istituzionale, come dice l’articolo 1 del suo statuto, è mantenere la pace e conseguire con mezzi pacifici la soluzione delle controversie internazionali. In secondo luogo perché nel Consiglio di sicurezza siedono, come membri permanenti, tutti dotati di armamenti nucleari, esattamente le potenze che hanno la forza e il potere per trattare la pace: la Russia, la Cina e i principali membri della Nato, cioè gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia. La trattativa si svolgerebbe così sotto gli occhi dell’intera umanità, all’interno di un’istituzione che ha per ragione sociale il conseguimento della pace. Sappiamo bene che l’Onu è sempre più debole, al punto che ne è stata dichiarata l’inutilità. Ma questa è una ragione di più perché ritrovi, di fronte a questa guerra, la sua funzione istituzionale e la sua ragion d’essere.
L’alternativa è l’escalation della guerra, con il rischio sempre maggiore della sua degenerazione in una guerra nucleare. Ma anche al di là di questa terrificante prospettiva, la continuazione di questa guerra, oltre a produrre altri massacri e devastazioni nella povera Ucraina, non potrà che far crescere e, per così dire, istituzionalizzare la logica bellica dell’amico/nemico. La decisione del nostro Parlamento di aumentare di oltre il 50% le spese militari, la terribile decisione tedesca di finanziare con 100 miliardi di euro il proprio riarmo, l’opzione di Biden per il rafforzamento militare della Nato anziché per il confronto diplomatico, il compiacimento generale per la compattezza dell’Occidente in armi raggiunta in questa logica di guerra, la crescita dell’odio verso il popolo russo e l’informazione urlata e settaria sono tutti segni e passi di una corsa folle verso la catastrofe. E’ il trionfo della demagogia e dell’irresponsabilità, il cui costo è pagato oggi dal popolo ucraino e domani, se la corsa non si fermerà, dall’intera umanità e in particolare dall’Europa.
Esiste insomma una responsabilità istituzionale dell’Onu e il dovere della comunità internazionale di fare tutto ciò che è possibile fare al fine di ottenere la pace. E ciò che l’Onu può fare, e perciò deve fare è non lasciare sola l’Ucraina al tavolo del negoziato, bensì offrire i suoi organi istituzionali, l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza, come i luoghi e i soggetti della trattativa, che ben potrebbero essere convocati in seduta pubblica e permanente fino a quando non riusciranno a porre termine alla guerra. Sarebbe un’iniziativa eccezionale, senza precedenti, dotata di un enorme valore politico e simbolico, che varrebbe a segnalare la gravità dei pericoli che incombono sull’umanità, a rilanciare il ruolo dell’Onu e a impegnare tutti gli Stati in una riflessione sul futuro del mondo e a prendere sul serio il principio della pace stabilito dallo Statuto dell’istituzione della quale sono membri.
3. Due visioni del futuro del mondo
E’ precisamente il futuro del mondo nel dopo guerra che dovrebbe stare al centro del dibattito politico e di politiche estere responsabili. In caso di scampato pericolo nucleare, gli esiti possibili di questa guerra saranno infatti due, tra loro opposti: il riarmo o il disarmo, la corsa a maggiori armamenti, in attesa della prossima guerra e, di nuovo, del rischio nucleare, oppure un risveglio della ragione e la comune riflessione sul possibile ripetersi del pericolo atomico e perciò sulla necessità, nell’interesse di tutti, di un progressivo disarmo, fino alla denuclearizzazione dell’intero pianeta.
La prima ipotesi, purtroppo la più miope e la più probabile, si manifesta nell’aumento delle spese militari degli Stati occidentali e in una militarizzazione delle nostre democrazie: dal riarmo della Germania all’aumento delle spese militari fino al 2% del Pil deciso dall’Italia e dagli altri Stati europei. «Pazzi», li ha chiamati papa Francesco, dichiarando di essersi per loro «vergognato». E’ l’ipotesi espressa dalla gara di insulti nei confronti di Putin nella quale si cimentano i leader occidentali, a cominciare dal presidente Biden – «macellaio», «criminale di guerra», «quest’uomo non può restare al potere!» –, che hanno il solo effetto di minare, o quanto meno di rendere più difficili i negoziati o peggio, essendo rivolti a un autocrate irresponsabile, di provocarlo e di indurlo ad allargare il conflitto fino a farlo precipitare in una terza guerra mondiale. Sono invettive che segnalano un intento inquietante: la volontà che la guerra prosegua per ottenere la sconfitta della Russia, o quanto meno la sua umiliazione nel pantano di una guerra fallita, per consolidare la subordinazione dell’Europa alla politica di potenza degli Stati Uniti ed anche, magari, per raccattare qualche voto alle elezioni americane di mid-term. Questa guerra diventa così l’occasione, per gli Stati Uniti e per l’apparato politico-mediatico schieratosi a suo sostegno, per un rilancio eticamente connotato dello scontro di civiltà tra democrazie e autocrazie, tra mondo libero e mondo incivile, onde ottenere la vittoria sul Male, anche a costo di mettere a rischio la sicurezza del mondo dal possibile olocausto nucleare.
La seconda ipotesi è quella pacifista, qui prospettata, dell’impegno della comunità internazionale a fermare immediatamente la guerra a qualunque, ragionevole costo: dall’assicurazione che l’Ucraina non entrerà nella Nato all’autonomia delle piccole regioni separatiste dell’Ucraina orientale, russofone e russofile, sulla base di un voto popolare nell’esercizio del diritto dei popoli all’autodeterminazione; in forza del quale, dice l’articolo 1 di entrambi i Patti internazionali sui diritti umani del 16 dicembre 1966, «tutti i popoli… decidono liberamente del loro statuto politico». Dal clima di pace generato dalla trattativa potrebbe uscire non soltanto la fine dell’aggressione all’Ucraina, ma anche una seria riflessione sul pericolo, mai così grave, del conflitto nucleare che sta correndo il genere umano. Potrebbe uscirne la consapevolezza comune della necessità di una rifondazione, mediante l’introduzione di idonee garanzie in tema di limitazioni della sovranità degli Stati, del patto di convivenza pacifica stipulato con la creazione dell’Onu. Il pericolo nucleare che stiamo correndo potrebbe inoltre indurre i paesi che ancora non l’hanno fatto ad aderire al Trattato sul disarmo nucleare del 7 luglio 2017, già sottoscritto da ben 122 paesi, cioè da più dei due terzi dei membri dell’Onu. Potrebbe, soprattutto, convincere gli Stati Uniti ad annullare il loro ritiro, deciso il 2 agosto 2019 dal presidente Trump, dal trattato del 1987 sul disarmo nucleare e indurre tutti gli Stati dotati di tali armamenti a riprendere questo graduale processo fino al totale disarmo. Oggi, nel mondo, ci sono 13.440 testate nucleari (erano 69.940 prima del trattato sul disarmo del 1987), in possesso di nove paesi: 6.375 in Russia, 5.800 negli Stati Uniti, 320 in Cina, 290 in Francia, 215 nel Regno Unito, 160 in Pakistan, 150 in India, 90 in Israele e 40 nella Corea del Nord. E’ stato calcolato che bastano 50 di queste bombe per distruggere l’umanità. Questo significa che con questi armamenti il genere umano può essere cancellato dalla faccia della Terra per ben 270 volte.
Alla discussione su queste due ipotesi non sta portando nessun contributo il dibattito pubblico, che sta svolgendosi in un clima avvelenato da contrapposizioni radicali. Non è un dibattito basato sul dialogo, sul confronto razionale e sul rispetto delle opinioni altrui, ma uno scontro fondato sull’opposizione amico/nemico, sul sospetto della malafede degli interlocutori e sulla loro squalificazione morale, o come putiniani o come guerrafondai. Del tutto assenti sono l’atteggiamento problematico, l’incertezza, il dubbio, l’interesse per le idee diverse dalle nostre, la consapevolezza della complessità e dell’ambivalenza delle questioni, che sempre dovrebbero informare la discussione pubblica.
Le questioni sulle quali il dibattito politico è stato più acceso e tra sordi sono due: quella dell’invio di armi all’Ucraina e quella dell’aumento della spesa militare fino al 2% del pil. Sono questioni diverse, che l’alternativa fra le due ipotesi sopra illustrate consente forse di affrontare con lungimiranza. La prima è un dilemma morale tra la solidarietà giustamente dovuta al popolo ucraino, i cui esponenti hanno più volte richiesto l’invio delle armi, e il prolungamento che ne seguirebbe del conflitto e delle stragi. Trattandosi di un autentico dilemma morale, non hanno senso le accuse che si scambiano i sostenitori delle due opzioni. Ci sono validi argomenti a sostegno di entrambe.
A mio parere il maggiore argomento contro l’invio delle armi consiste, oltre che nel rischio che esso possa essere inteso come cobelligeranza in un conflitto destinato a durare e a produrre altri massacri, nella sua decisione insieme a quella di un aumento delle spese militari. Questa seconda decisione è chiaramente a sostegno della logica della guerra, se non altro perché tale aumento è già avvenuto, ininterrottamente, da oltre venti anni. Rispetto al 2019 l’aumento, nel 2020, è stato del 2,6% a livello globale e ben del 7,5% in Italia. La spesa complessiva nel mondo è giunta quasi a 2000 miliardi di dollari l’anno, dei quali il 39% (776 miliardi, contro i 252 della Cina e i 62 della Russia) spesi dai soli Stati Uniti che hanno riempito il pianeta di ben 800 basi militari. A cosa serve, domandiamoci, accumulare ulteriori, inutili armamenti, se non ad alimentare il clima di guerra e ovviamente a soddisfare gli interessi del complesso militar-industriale? Entrambe le opzioni, l’invio di armi alla resistenza ucraina e l’aumento delle spese militari risultano perciò accomunate da un’opzione militarista: dall’idea suicida delle armi come unica soluzione strategica delle controversie internazionali, in letterale contrasto con l’articolo 1 della Carta dell’Onu, con l’articolo 11 della Costituzione italiana e, più in generale, con i principi della pace e dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani nei diritti fondamentali. Un’uguaglianza, dobbiamo aggiungere, che continuiamo a sbandierare come un valore dell’Occidente aggredito e, insieme, a violare nei confronti dei quattro quinti dell’umanità.
4. Per una Costituzione della Terra
E’ su quest’ultimo punto che voglio soffermarmi. Non possiamo continuare a parlare decentemente di difesa della democrazia, dei principi di uguaglianza e dignità della persona e di universalismo dei diritti umani minacciati dalle autocrazie, fino a quando questi principi resteranno un privilegio dei nostri paesi – non più di un miliardo di persone su quasi otto miliardi di esseri umani – mentre per il resto del mondo non sono altro che vuota retorica. Non possiamo continuare a declamarli come i “valori dell’Occidente”, mentre quei principi, proclamati come universali da tutte le carte dei diritti, non sono garantiti a tutti gli esseri umani ma solo a una loro esigua minoranza. Giacché quei valori o sono universali, oppure non sono. Oggi le nostre democrazie sono in declino, sottoposte alla doppia minaccia dell’onnipotenza delle maggioranze politiche sradicate dalle loro basi sociali e dei poteri dei mercati globali. Ma, soprattutto, i diritti umani e i principi di uguaglianza e dignità delle persone, proclamati in tante carte costituzionali e internazionali, sono promesse non mantenute: attuate, oltre tutto malamente, in pochi paesi privilegiati e vistosamente e sistematicamente violate per il resto dell’umanità, anche a causa delle politiche di rapina, di sfruttamento e di esclusione praticate dal civile Occidente. La loro conclamata inviolabilità, come la loro indivisibilità e universalità altro non sono che parole, contraddette dalle loro violazioni sistematiche e dalla loro mancata attuazione, per mancanza di garanzie, in gran parte del mondo. In assenza di una sfera pubblica mondiale capace di garantirli, le disuguaglianze sono destinate a crescere, i poteri globali, sia politici che economici, non possono che svilupparsi in forme selvagge e distruttive, le violazioni massicce dei diritti umani non possono che dilagare e tutti i problemi globali non possono che aggravarsi.
C’è dunque una questione di fondo che questa guerra impone di affrontare. La guerra, e prima ancora la pandemia, hanno mostrato in tutta la loro drammaticità l’inadeguatezza delle istituzioni internazionali esistenti e soprattutto il pericolo rappresentato dal vuoto di garanzie nei confronti dei poteri selvaggi degli Stati sovrani e dei mercati globali. Le due tragedie – pandemia e guerra – sono per molti aspetti opposte. La pandemia, con i suoi 6 milioni di morti, ha mostrato l’interdipendenza e la comune fragilità dell’umanità, l’insensatezza dei confini e dei conflitti identitari e la disponibilità alla solidarietà delle pubbliche opinioni ed anche della politica. La guerra, con le sue migliaia di morti, le città devastate e più di 10 milioni di sfollati, sta generando, al contrario, odi tra popoli, logiche politiche dell’amico/nemico, lacerazioni tra nazionalità che non sarà facile rimarginare. Entrambe le tragedie sono tuttavia una drammatica conferma dell’insensatezza e della pericolosità dello stato attuale del mondo e segnalano la necessità e l’urgenza di una rifondazione dell’Onu basata su una Costituzione della Terra alla loro altezza. E’ questo il progetto del movimento “Costituente Terra” formatosi a Roma nell’assemblea del 21 febbraio 2020 e da me illustrato nel libro Per una Costituzione della Terra, pubblicato quest’anno da Feltrinelli.
Oltre alla guerra e alle pandemie, sono molte altre le sfide e i pericoli che minacciano il futuro dell’umanità e che solo un costituzionalismo globale può fronteggiare. Anzitutto l’emergenza ecologica, che la guerra sta aggravando e insieme rimuovendo dall’orizzonte della politica, ma che continua ad essere la minaccia forse più grave per il futuro dell’umanità. Per la prima volta nella storia il genere umano, a causa del riscaldamento climatico, rischia l’estinzione per la progressiva inabitabilità di parti crescenti del nostro pianeta. Da molti decenni la concentrazione nell’aria di anidride carbonica cresce in maniera progressiva: ogni anno, costantemente, viene immessa nell’atmosfera una quantità di CO2 maggiore di quella immessa l’anno precedente. E’ chiaro che fino a quando questo processo non sarà invertito, vorrà dire che stiamo andando verso la rovina.
C’è poi l’emergenza diritti. La globalizzazione, con il potere delle grandi imprese di dislocare le loro attività produttive nei paesi nei quali è possibile lo sfruttamento illimitato dei lavoratori, ha svalorizzato il lavoro a livello globale, cancellandone nei paesi avanzati le garanzie conquistate in un secolo di lotte e riducendo il lavoro, nei paesi poveri, a forme e a condizioni para-schiavistiche. A causa della miseria crescente, inoltre, muoiono ogni anno, nel mondo, otto milioni di persone per mancanza di alimentazione di base e altrettante per mancanza di cure mediche e di farmaci salva-vita, vittime del mercato, oltre che delle malattie, giacché i farmaci in grado di salvarli non sono disponibili nei loro paesi poveri, o perché brevettati e perciò troppo costosi, o perché non più prodotti per mancanza di domanda dato che riguardano malattie – infezioni respiratorie, tubercolosi, Aids, malaria – debellate e scomparse nei paesi ricchi. Di qui il dramma di decine di migliaia di migranti, ciascuno dei quali ha alle spalle una di queste tragedie. Di qui l’odio per l’Occidente, il discredito dei suoi valori politici, lo sviluppo della violenza, dei razzismi, dei fondamentalismi e dei terrorismi.
E’ chiaro che sfide globali di questa portata richiedono risposte globali: il progressivo disarmo, non soltanto nucleare, di tutti gli Stati e la messa al bando di tutte le armi come beni illeciti; il superamento degli eserciti nazionali auspicato più di due secoli fa da Kant e la realizzazione, a garanzia della pace e della sicurezza, del monopolio della forza in capo all’Onu e alle polizie locali; l’istituzione di un demanio planetario che sottragga i beni comuni e vitali – l’aria, l’acqua potabile, le grandi foreste e i grandi ghiacciai – alle appropriazioni private, alla mercificazione e alle devastazioni ad opera del mercato; l’introduzione di divieti, finalmente sanzionati, delle emissioni di gas serra e della produzione di rifiuti comunque velenosi; l’uguaglianza nei diritti e nella dignità di tutti gli esseri umani tramite la creazione di istituzioni globali di garanzia di tutti i diritti fondamentali, dai diritti di libertà ai diritti sociali alla salute, all’istruzione, all’alimentazione e alla sussistenza, come un servizio sanitario e un sistema scolastico mondiali con ospedali, farmaci, vaccini, scuole e università in tutto il mondo; l’unificazione del diritto del lavoro e la globalizzazione delle garanzie dei diritti dei lavoratori, in grado di assicurarne l’uguaglianza e la dignità contro l’odierno sfruttamento illimitato; l’istituzione di una Corte costituzionale sovrastatale, con il potere di invalidare tutte le fonti normative che violano diritti umani, e la trasformazione da volontaria in obbligatoria delle competenze della Corte di giustizia e della Corte penale internazionale; l’introduzione infine di un adeguato fisco globale progressivo in grado di finanziare le istituzioni globali di garanzia e di impedire le attuali concentrazioni illimitate della ricchezza.
Misure di questo genere, è evidente, possono essere imposte solo da una rifondazione della Carta dell’Onu ad opera di una Costituzione della Terra rigidamente sopraordinata alle fonti statali e ai mercati globali. Solo una Costituzione della Terra che introduca le funzioni e le istituzioni globali di garanzia dei diritti proclamati in tante carte e convenzioni può rendere credibili il principio di uguaglianza e l’universalismo dei diritti umani. Solo una Costituzione mondiale, che allarghi oltre gli Stati il paradigma del costituzionalismo rigido sperimentato nelle nostre democrazie può trasformare promesse ed impegni politici, come quelli presi in materia di ambiente dai G20 a Roma e poi a Glasgow, in limiti e in obblighi giuridici effettivamente vincolanti.
Non si tratta di un’utopia. Si tratta invece dell’unica risposta razionale e realistica allo stesso dilemma che fu affrontato quattro secoli fa da Thomas Hobbes: la generale insicurezza determinata dalla libertà selvaggia dei più forti, oppure il patto razionale di sopravvivenza e di convivenza pacifica basato sul divieto della guerra e sulla garanzia della vita. Con una differenza di fondo, che rende il dilemma odierno enormemente più drammatico: la società naturale dell’homo homini lupus ipotizzata da Hobbes è stata sostituita da una società di lupi non più naturali, ma artificiali – gli Stati e i mercati – dotati di una forza distruttiva incomparabilmente maggiore di qualunque armamento del passato. Diversamente da tutti gli orrori del secolo scorso – perfino dalle guerre mondiali e dai totalitarismi – la catastrofe ecologica e quella nucleare sono irreversibili: c’è infatti il pericolo, per la prima volta nella storia, che si acquisti la consapevolezza della necessità di cambiare strada quando sarà troppo tardi.
Neppure si tratta di un’invenzione, né di un mutamento dell’attuale paradigma costituzionale. Si tratta, al contrario, di un suo inveramento, cioè di un’attuazione del principio della pace e dell’universalismo dei diritti umani quali diritti di tutti già stabiliti nella Carta dell’Onu e in tante carte costituzionali e internazionali. La logica intrinseca del costituzionalismo, con i suoi principi di pace e di uguaglianza nei diritti umani, non è nazionale, ma universale. Gli Stati nazionali e le loro costituzioni sono d’altro canto impotenti di fronte alle sfide globali, le quali richiedono risposte e garanzie giuridiche a loro volta globali. E il patto di convivenza pacifica stipulato con la Carta dell’Onu e con le tante carte internazionali dei diritti è fallito per due ragioni: perché contraddetto dalla persistente sovranità degli Stati e dalle loro cittadinanze disuguali, e perché non sono state istituite le necessarie garanzie globali, senza le quali i diritti e i principi di giustizia pur solennemente proclamati si riducono a ingannevole ideologia.
A questa prospettiva viene contrapposta, in nome del realismo politico, l’idea del suo carattere utopistico e irrealizzabile. Io penso che dobbiamo distinguere due tipi opposti di realismo: il realismo volgare di chi naturalizza la realtà sociale e politica con la tesi “non ci sono alternative a quanto di fatto accade”, e il realismo razionalista, secondo il quale le alternative ci sono, dipende dalla politica adottarle e la vera utopia, l’ipotesi più irrealistica, è l’idea che la realtà possa rimanere a lungo come è: che potremo continuare a basare le nostre democrazie e i nostri spensierati tenori di vita sulla fame e la miseria del resto del mondo, sulla forza delle armi e sullo sviluppo ecologicamente insostenibile delle nostre economie. Tutto questo non può durare. E’ lo stesso preambolo alla Dichiarazione dei diritti del 1948 che stabilisce, realisticamente, un nesso di implicazione reciproca, quale solo una Costituzione della Terra e le sue istituzioni di garanzia possono assicurare, tra pace e diritti, tra sicurezza e uguaglianza e, dobbiamo aggiungere oggi, tra salvataggio della natura e salvataggio dell’umanità.
D’altro canto l’umanità forma già un unico popolo. Sessanta anni fa, ricordo, eravamo, sul pianeta, 2 miliardi di persone, ma quel che succedeva dall’altra parte del mondo non ci riguardava. Oggi la popolazione mondiale è arrivata a 8 miliardi, ma siamo tutti interconnessi, sottoposti al governo globale dell’economia ed esposti alle stesse emergenze e catastrofi planetarie. Siamo perciò un unico popolo, meticcio ed eterogeneo, ma unificato dagli stessi interessi alla sopravvivenza, alla salute, all’uguaglianza e alla pace, che solo la miopia dei poteri politici non è in grado di vedere e che anzi occulta con la difesa dei confini. La logica schmittiana dell’amico/nemico è una costruzione propagandistica a sostegno dei populismi e dei regimi autoritari che sta oggi contagiando, purtroppo, anche le nostre democrazie. Se i massimi governanti del pianeta, anziché impegnarsi sulla base di questa logica nelle loro miopi e miserabili politiche di potenza, fossero capaci di trarre lezioni dalla storia, questa terribile guerra in Ucraina sarebbe una fonte inesauribile di insegnamenti. Insegnerebbe – contro l’insensatezza delle guerre, delle armi, dei confini, dei nazionalismi e dei conflitti identitari – il valore razionale, nell’interesse di tutti, della pace universale e dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani in dignità e diritti e la necessità delle garanzie necessarie ad assicurarle.